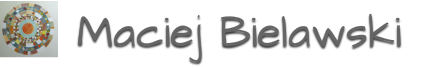La passione per Dio
Scritti italiani di Piotr Rostworowski, un eremita
a cura di Maciej Bielawski
con l'introduzione e un saggio sull'amicizia tra Piotr Rostworowski e Piccola Sorella Magdaleine Hutin
Scritti italiani di Piotr Rostworowski, un eremita
a cura di Maciej Bielawski
con l'introduzione e un saggio sull'amicizia tra Piotr Rostworowski e Piccola Sorella Magdaleine Hutin
Le meditazioni di questo libro sono di un monaco di nome Pietro Rostworowski (1910-1999). Polacco di origine, ma d’altra parte uomo universale, spaziò tra diversi paesi e continenti, trascendendo in Dio qualsiasi tipo di frontiera. Fu benedettino e eremita camaldolese, ma soprattutto uomo di Dio. In alcuni periodi visse in eremi italiani parlandone assai bene la lingua e scrivendo meditazioni come quelle qui riportate, composte, alcune, nell’eremo camaldolese (in illo tepore) di Nola vicino a Napoli negli anni 1984 e 1985, altre nell’eremo tuscolano vicino a Frascati in cui trascorse gli ultimi anni della sua vita e dove oggi riposa. La forza e la bellezza delle sue parole, di cui questo libro rende una testimonianza, sono uniche e sorprendenti.
Introduzione
Adalberto Giovanni (in polacco: Wojciech Jan) Rostworowski nacque 12.09.1910 in Rybaczewice, nella diocesi di Lublino (Sud-Est di Polonia), in una famiglia nobile (suo padre era un senatore della Repubblica Polacca nel periodo interbellico). Adalberto nel 1930 entrò nel monastero benedettino di San Andrea vicino Brugge in Belgio prendendo il nome Pietro. Dopo il periodo previsto per la formazione e dopo l’ordinazione sacerdotale (1937), venne mandato a Roma per approfondire la sua formazione teologica nell’Ateneo benedettino di Sant’Anselmo sull’Aventino. Trascorso un anno, da Roma venne chiamato in Polonia, dove il suo monastero belga aveva avviato una nuova fondazione. Nell’estate del 1939 Padre Pietro fu nominato sotto-priore dei monaci e maestro dei novizi del monastero di SS. Pietro e Paolo a Tyniec, vicino a Cracovia. Un mese dopo la sua apertura scoppiò la seconda guerra mondiale. Il monastero è sopravissuto alle cavalcate sia degli eserciti tedeschi sia di quelli russi diventando anche, per alcuni (Polacchi ed Ebrei), luogo di rifugio e di nascondimento. In Polonia alla fine della guerra, si stabilì il governo comunista e, per la crescente intolleranza stalinista, i monaci belgi furono costretti a lasciare il paese. Su Padre Pietro cadde la responsabilità di guidare questa nuova fondazione (anni 1952-1958). Erano tempi difficili: la vita della Chiesa era ostacolata dal regime, il Primate cardinal Stefan Wyszyński venne imprigionato, alcuni monasteri furono chiusi, altri sorvegliati dalla polizia segreta, ecc. Padre Pietro in questo periodo, oltre a guidare il monastero di Tyniec, agiva in diversi campi: resistenza al comunismo, attività pastorale; uomo di appoggio e di consiglio, divenne una delle figure più imponenti della chiesa in Polonia. Per toglierlo di mezzo e screditare la sua autorità, il regime trovò motivi di accusa e lo imprigionò per circa quattro anni (1964-1967).
Uscito, in qualche modo libero e staccato dagli impegni precedenti, gli si chiese di aiutare il processo di rinnovamento negli assai indeboliti eremi dei monaci camaldolesi della congregazione di Monte Corona presenti in Polonia. Dopo il 1968 il clima politico nel paese cambiò e la Chiesa, monasteri inclusi, entrò nel processo di rinnovamento post-conciliare in cui Padre Pietro venne coinvolto. Nel 1972 formalmente si fece camaldolese e la sua figura, in abito bianco e con lunga barba grigia, si ripresentò nel mondo monastico ed anche oltre le mura degli eremi. Fu un periodo molto fecondo della sua vita: scriveva, predicava, ascoltava, dava consigli e i due eremi camaldolesi in Polonia si riempivano di monaci e riprendevano la loro vita. Dopo l’elezione del cardinale Wojtyła di Cracovia alla sede petrina, le visite di Padre Pietro in Italia, dove tra l’altro a Frascati si trovava la casa generalizia del suo ordine, divennero più frequenti finché, nel 1983, gli fu assegnato l’incarico di superiore dell’eremo di Nola vicino a Napoli. Nel 1986 si aprì ancora un altro capitolo del tutto nuovo nella vita di Rostworowski – l’ordine lo incaricò dell’organizzazione di una nuova fondazione in Columbia. Nei successivi otto anni, sotto la sua direzione, furono aperti gli eremi a Envigado (vicino Medelin – poi chiuso) e, in seguito, quello di Santa Rosa esistente tutt’oggi. Nel 1994 Padre Pietro ritornò dal continente Sud-Americano e si stabilì nell’eremo di Frascati. Qui per un certo tempo condusse la vita di recluso che però gli venne impedita per ragioni di salute. Dopo la crisi causata da un ictus si riprese per un po’ ma, ormai indebolito e invecchiato, si spense nell’ospedale di Albano il 30 aprile 1999.
Già da questa breve nota biografica si intravede una personalità ricca e straordinaria. La sua opera, possiamo chiamarla così, aspetta ancora di essere veramente scoperta, portata alla luce e conosciuta. Scrivere la biografia di questo monaco, che potrebbe fornire gli elementi per un giudizio completo ed equilibrato, non sarà un compito facile – ma tali iniziative sono state già felicemente avviate. La stessa cosa riguarda l’edizione dei suoi scritti e il giudizio del suo messaggio teologico e spirituale, che non sono meno eminenti della sua biografia.
Padre Pietro scrisse – molto e lungo tutta la sua vita; pubblicò poco, perché non volle, ma il suo patrimonio letterario, così come oggi lo conosciamo, è immenso. In esso si trovano tanti “commenti” biblici, o piuttosto le meditazioni che lui scriveva per se stesso o con il desiderio di condividerle con altri. Scrivere questi commenti era per Padre Pietro un modo di pregare, di comprendere ed approfondire la Parola di Dio. Nell’insieme essi coprono forse tutti gli scritti del Nuovo Testamento (alcuni commentati più volte), i Salmi (forse tutti) e diverse altre parti dell’Antico Testamento. In questo patrimonio si distinguono temi diversi: preghiera e vita interiore, direzione spirituale ed educazione alla vita con Dio, vita monastica in genere, dogmi e liturgia; non mancano traduzioni (per esempio La nube della non conoscenza), ma anche il Cantico che, nella versione di Padre Pietro, entra nella traduzione ufficiale e liturgica polacca della Scrittura. Tanti di questi scritti sono su quaderni, su vecchi calendari o sui fogli di carta strappati e sparsi qua e là – centinaia e migliaia di pagine coperte con una scrittura regolare, chiara e senza correzioni; altre scritte a macchina; non mancano anche registrazioni delle sue conferenze e prediche. Insomma il materiale è immenso e fortunatamente ben conservato nell’archivio del monastero di Tyniec – grazie alla premura di persone ben consapevoli del valore in esso racchiuso. Già oggi, nonostante la raccolta non sia ancor terminata, si possono distinguere circa quaranta blocchi tematici per più di 4 o 5 mila pagine. A tutto questo si devono aggiungere le lettere: quasi 30 mila (sì!) per le quali Padre Pietro tenne un registro preciso – una parte di esse si riferisce al suo lavoro di visitatore, la maggioranza ha valore spirituale (si trovano ad esempio lettere indirizzate a singole persone con cui aveva corrisposto per diversi anni).
Lo stile dei suoi scritti è limpido – il pensiero scorre in modo semplice e profondo, senza correzioni, il che denota nell’autore una perfetta padronanza del tema che tratta (questo fatto è legato alla sua stupenda disciplina mentale coltivata e sviluppata nei lunghi anni di vita monastica). Tutto qui parte dall’esperienza e dalla ricerca di Dio – ogni tanto si ha pure l’impressione che l’autore di questi testi sia stato proprio rapito da Dio e scriva sotto una sua ispirazione: il suo pensiero, e la sua personalità, sono impressi da un forte teo-centrismo. La Parola di Dio occupa in tutto questo un posto privilegiato: Padre Pietro la commenta e scrivendo cerca di capirla, ma d’altra parte la stessa Parola schiude nel suo cuore una esperienza di Dio e lui stesso si vede in essa. Una volta scrive per salvarsi, un’altra perché si sente salvato. Ogni tanto scrive perché sa e in altri momenti perché desidera di sapere. Comunque i suoi testi possiedono la forza e l’autenticità dell’esperienza di Cristo e sono intrisi di passione per il suo amore. Qui viene presentata solo una piccola parte della sua eredità letteraria; si tratta di scritti, in lingua italiana – in particolare i testi di Nola sono su un quaderno, quelli di Frascati sono su diversi fogli e quaderni. Se ne riporta una scelta secondo un ordine diverso da quello dato da Padre Pietro e con le minime e limitate modifiche linguistiche, ritenute necessarie. Il presente lavoro vuole essere solamente la premessa a un’opera ben più vasta e profonda, ma forse già da questo libretto il lettore potrà cogliere grandezza e bellezza del personaggio e del suo pensiero. Forse a qualcuno piacerà – forse aiuterà qualcuno ad appassionarsi di Dio (ancora di più).
Maciej Bielawski 2003
Indice
Introduzione
I. Monastica
1. Su me stesso
2. Quattro pilastri della vita monastica
3. Umiltà
4. Ispirazioni di Dio (I)
5. Ispirazioni di Dio (II)
6. I comandamenti di Cristo (I)
7. I comandamenti di Cristo (II)
8. Imitazione di Dio
9. Immutabilità di Dio (I)
10. Immutabilità (II)
11. La pazienza di Dio
12. La pazienza (hypomoné)
13. La prova
II. Liturgica
1. Nativitas B.V.M.
2. La Venuta del Signore
3. Natale
4. La Passione del Signore
5. Pasqua – sabato in albis
6. L’incontro in Galilea
7. Ascensione
8. Ascensione e Pentecoste
9. San Benedetto
10. San Lorenzo
III. Biblica
1. Salmo 2 75
2. Salmo 4 78
3. Salmo 23 81
4. Salmo 86 82
5. Salmo 92 83
6. Salmo 130 86
7. Sul Libro dei Proverbi 88
8. La Lettera ai Filippesi 1 91
Maciej Bielawski: Piccola Sorella Magdeleine Hutin e Padre Pietro Rostworowski.
Storia di un’amicizia 100
I. Monastica
1. Su me stesso [1]
Io sono monaco sin dalla giovinezza. Già a dodici anni ero convinto che questa fosse la mia vocazione. Ora sono entrato nell’ottantaseiesimo anno della mia vita e fra una settimana sarà anche il sessantacinquesimo anniversario della mia entrata in monastero. Sono sacerdote da cinquant’otto anni. Oggi colgo l’urgente necessità di riformare la mia vita. Dio mi offre chiara coscienza di quante grazie ho sprecato, per mancanza di prudenza e di sapienza, e che sarebbero state importanti per condurre la mia vita.
Dio mi ha dato una buona famiglia e buone condizioni per vivere. Nella mia giovinezza non ho conosciuto il peso né della povertà né di sfide materiali o morali. La mia famiglia era credente e unita e la disciplina della vita si fondava sulla carità, sul reciproco rispetto e sulla fiducia. Non si richiedeva da me molto. Dio mi ha dato una buona intelligenza e così lo studio non era per me difficile: raggiungevo ottimi risultati senza sforzo. Ero segnato da una forma di nobiltà del vivere. Mi piaceva quanto era nobile, avevo un’inclinazione spontanea all’amicizia e alla misericordia, ma anche alla pigrizia, al conformismo e poca solidità. Nel mio ambiente ero ben accettato e stimato. Sin dalla mia gioventù mi rispettavano e godevo di una certa autorità e fiducia. Sinceramente desideravo essere buono e mi sembrava di esserlo, allora non facevo caso al fatto che dovevo assolutamente combattere i vizi del mio carattere. Il primo campo di battaglia, di cui mi resi conto, fu quello della castità. Questa battaglia ravvivò il mio contatto con Dio e mi preoccupavo di vivere in stato di grazia. Mi mancava però una ascesi sistematica e una vita spirituale più ordinata.
Quando nel 1930 ho iniziato la vita monastica, mi sono sottomesso subito alla disciplina della vita comunitaria e liturgica. Sono stato ben accettato dalla comunità. I superiori hanno ben apprezzato la mia cultura e la mia sincera buona volontà, perché anch’io ho accettato l’ordine monastico con fede semplice e simpatia. Ma non mi sono avviato verso la prassi sistematica dell’ascesi. Non ero cosciente di tale necessità. Speravo piuttosto che i miei sforzi di scendere sempre più profondamente nella preghiera, lentamente mi trasfigurassero – e desideravo questa trasformazione.
Nell’ordine monastico del mio tempo non esisteva la direzione spirituale fatta in modo sistematico. Ovviamente un giovane monaco poteva chiederlo a un sacerdote che sceglieva. Non si praticava un’obbedienza che negava la propria volontà. E io, che in modo assai naturale e molto facilmente mi adattavo all’ambiente, anche perché non mi attirava l’essere ribelle e seguire soltanto la mia volontà, sono entrato nella vita monastica liscio e senza ostacoli. Tutto questo nell’insieme, il mio “carattere facile”, ha impedito che io mi rendessi conto di quanta superbia e volontà propria si trovavano in me. Ho accettato allora la cornice della dipendenza monastica, ma dentro questa cornice, di fatto, facevo quanto volevo o organizzavo la mia vita da solo – devo dire che lo facevo in un modo poco prudente e stupido. Avrei dovuto avere un maestro saggio, qualcuno capace di sorvegliare la mia vita spirituale e la mia formazione intellettuale. L’ordine monastico lo faceva in modo solamente esteriore – decidendo, per esempio, che dovevo studiare a Roma. Là frequentavo i corsi e superavo gli esami, ma in quale direzione “concretamente” doveva svilupparsi la mia formazione intellettuale e spirituale decidevo io, completamente da solo e per tutti gli anni della mia vita monastica. Mi era stata lasciata una grande libertà, che da parte mia, era stata impiegata in modo del tutto sbagliato. Mi mancava la prudenza e l’orientamento per scegliere la direzione migliore per me – e devo dire che avevo possibilità stupende. In tutto questo il peggio era che non possedevo lo spirito dell’umiltà e dell’obbedienza per lasciarmi dirigere dagli uomini saggi che incontravo sulla via della mia vita. Il risultato è che, oggi, avendo ottantacinque anni, sono una persona con una vita sprecata, sono una persona senza una vera conoscenza teologica o biblica, non possiedo né una scienza spirituale, né una virtù provata da un’ascesi stabile. E poiché credo che il Padre Celeste sia buono e paziente nei miei confronti, che non abbia perso la sua pazienza e sia pronto a darmi la grazia della vera conversione anche se il tempo che mi rimane è molto breve, voglio ora umiliarmi totalmente di fronte a Lui e supplicarLo perché abbia misericordia della mia vita peccaminosa.
Quanto ho scritto sopra è stato detto secondo una prospettiva molto umana. Ma a Dio non piace un tale ragionamento. Perché è dal punto di vista umano che la mia vita è stata sprecata. Che cosa è stato sprecato? Forse avrei potuto ottenere una formazione teologica ottima e ho perso questa occasione? Questo significa che mi dispiace perché non ho raggiunto una certa grandezza, io che sono un niente e tutta la mia vita tende alla kenosis? Che cosa voglio allora? Certamente qui si tratta del fatto che ho perso alcuni valori apprezzati agli occhi degli uomini, e persino alla Chiesa. Ma l’acquisto di questi valori avrebbe potuto solo aumentare la mia superbia, ne sono certo. E allora? La mia vita può essere definita una frana o una vita sprecata in quanto ho offeso Dio (l’ho fatto tante volte). D’altra parte mi chiedo: è mai esistita una vita più sprecata di quella del buon ladrone, che stando di fronte alla morte, non poteva contare di avere tempo per la conversione e per la penitenza? Ma la vita di questo uomo fu un successo fatto da Dio, questa vita fu pienamente affermata da Cristo e dalla sua Redenzione. Non bisogna allora dire che la vita è sprecata fin quando ancora dura.
2. Quattro pilastri della vita monastica. [2]
Carissimi Fratelli.
Tutti siamo venuti all’Eremo per vivere intensamente nella presenza di Dio, nel pensiero delle cose eterne, e prepararci a una buona morte che sappiamo essere molto vicina. Abbiamo tutti i nostri peccati, tutti dobbiamo far penitenza, tutti dobbiamo convertirci e umiliarci davanti al Signore fino in fondo, e poi sperare nella Sua infinita Misericordia. Il monaco è colui che prende questo programma con grande serietà. Morto con Cristo nel battesimo e risorto con Lui nello stesso sacramento, vuole realizzare questo mistero di morte e di vita nella propria esistenza. Per poter vivere più profondamente e più intensamente questo mistero, il monaco si chiude nella solitudine cercando di approfondire, nella preghiera e nella meditazione, l’ammirevole economia del divino Amore che ci salva.
I. Ciò che caratterizza il contemplativo è la passione di Dio e del divino, della grandezza di Dio, della sua gloria. È vero che il cristiano può santificarsi in mezzo al mondo, avendo una famiglia, un mestiere, un inserimento nella società. Ma l’amore del contemplativo dice che il Signore è degno di essere l’unico fine, l’unica preoccupazione dell’esistenza umana. Dio è degno che si abbandoni tutto per Lui solo, per occupasi di Lui solo, per lodarLo, per adorarLo e amarLo ogni giorno e tutto il giorno.
Il mondo moderno ha dimenticato il primo precetto dell’amore ancora più del secondo. Se si parla di carità, si pensa ordinariamente all’amore del fratello, ma quasi mai all’amore di Dio. Benché l’amore di Dio non sia separabile dall’amore del prossimo, rimane sempre vero che l’amore di Dio è il primo e principale. Esclusivamente di questo amore diretto e personale per Dio la Scrittura dice: “Ascolta, o Israele, Jahvé è il nostro Dio, Jahvé è uno solo. Ama Jahvé, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutta la forza” ( Dt 6, 4-5 ). La vocazione particolare dei contemplativi nel mondo è di essere in modo speciale un segno e un ammonimento, un grido per far ricordare il primato assoluto dell’amore di Dio stesso, amore con tutto il cuore, tutta l’anima e tutte le forze. Per poter offrire a Dio tutto il nostro cuore, il nostro pensiero e le nostre forze, lasciamo le molteplici distrazioni del mondo, quelle che riempiono l’immaginazione e la mente e quelle che trascinano il cuore e la volontà. È questa misteriosa passione di Dio che ci ha condotti qui in questo eremo.
È certo che la vocazione alla vita contemplativa è una speciale vocazione all’intimità con Dio. Essa è come una anticipazione della vita eterna. Ha un’importanza speciale nella Chiesa poiché realizza in modo eminente l’essenza stessa della Chiesa – Comunità di preghiera in via verso il supremo incontro con Dio nella vita eterna. In questo sta la bellezza e la sublimità, ma anche la difficoltà della vita contemplativa. Vivere “facies ad faciem” con l’Invisibile, l’Infinito, perseverare davanti all’insondabile Mistero tutta la vita e non scoraggiarsi, non fuggire verso le cose mondane che sono della nostra natura materiale, è una cosa non solamente difficile per l’uomo ma, senza l’appello e la potente grazia di Dio che ci attrae misteriosamente al suo cuore, una cosa veramente impossibile, tanto più che noi siamo non soltanto esseri umani, ma anche peccatori. Di questa forma di vita, senza dubbio sovrumana, siamo responsabili giacché ne abbiamo ricevuto la grazia.
II. Ma qui viene il secondo elemento essenziale della vita contemplativa. Il primo – abbiamo detto – è una caratteristica passione per Dio e per il divino, propria dei contemplativi. Questa passione di Dio si ritrova in modo eminente nella nobile figura del nostro Fondatore, il Beato Paolo Giustiniani. È amore per Dio totale, intransigente e senza compromessi. Il secondo elemento è fiducia in Dio, assoluta e totale. Siamo convinti – Carissimi – che la nostra vocazione sia totalmente soprannaturale, che non sia affare di forze umane, né di capacità umane, né di calcoli umani, ma una chiamata personale del Signore onnipotente e fedele. Non cerchiamo il nostro appoggio in noi stessi, la nostra gioia, la nostra contentezza in noi stessi, nelle nostre forze e capacità che abbiamo ricevute da Dio. Non è però questo il nostro sostegno. Tutto questo può esserci e può anche mancare, come pure la nostra salute corporale. Osserviamo che nella S. Scrittura non c’è forse niente che Dio domandi da noi con maggior insistenza che la fiducia, di riporre in Lui tutta la nostra fiducia, tutta la nostra speranza.
Se Dio è venuto nel mondo per essere con noi, l’uomo non ha più diritto di sentirsi solo nei suoi combattimenti, nei suoi problemi, nelle sue difficoltà personali. Il Signore chiama: “Venite a me” (Mt 11, 28). Andiamo dunque, non siamo soli, non siamo soli mai, se è vero che il Signore ha voluto venire nel mondo per essere con noi. Il Cristo è la risposta, l’unica risposta divina a tutti i nostri problemi, a tutte le nostre difficoltà. Non cerchiano nient’altro. È la nostra risposta alla divina vocazione, è una risposta di fiducia senza limiti. Penso che, alla maggioranza di coloro che non hanno perseverato nella vocazione eremitica, sia mancata proprio questa fiducia.
Vediamo questa fiducia eroica nella vocazione di Abramo. Dio gli disse: Esci dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre…(Gn 12, 1) E lui partì senza sapere dove andava, ha abbandonato tutto senza ricevere niente, nessun appoggio umano fuori della fedeltà di Dio che non delude mai. La fiducia perfetta è come un salto da un aereo senza paracadute nelle braccia aperte di Dio. Ispiriamoci dunque nella nostra vita alla grande fiducia dei Santi e non dimentichiamo mai, e specialmente nei momenti duri della tentazione, dello scoraggiamento, del buio, la presenza di Dio e la sua indefettibile fedeltà.
III. Il terzo elemento essenziale a una vita veramente monastica è l’accettazione della dottrina evangelica sul vero sviluppo dell’uomo. L’uomo vuole svilupparsi o – come si dice oggi – “realizzarsi”. Di questo parlano spesso i giovani religiosi, ma spesso dimenticano l’insegnamento di Gesù Cristo in questa materia. La divina dottrina sul vero sviluppo spirituale dell’uomo si trova nel cap. 12 del Vangelo di San Giovanni. Il Signore ci parla e dice: In verità, in verità vi dico: Se il chicco di frumento non cade in terra e vi muore, resta solo; se invece muore, porta molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna (12, 24). C’è nel nostro cuore un misterioso desiderio di questa morte. Non uccidiamo questo delicato anelito – è l’istinto della grazia. Forse saremo felici di poterlo realizzare un giorno. È lo Spirito che ci dice: “Non temere il sacrificio della tua vita. Non temere di perdere la tua vita in questo mondo per vivere in pienezza, non temere di sacrificarti a Dio nei tuoi fratelli, di sacrificare il tuo proprio benessere alle necessità della tua Famiglia eremitica. Non temere di rinunciare a questo… a quello… non temere”. Lo Spirito ci dice di non temere perché non sono i buoni desideri che ci mancano, ma il coraggio delle forti decisioni. Rimane però la verità che si deve morire per vivere, per “realizzarsi” veramente, si deve perdere la propria vita. Questa è la sapienza del Vangelo. Mai l’egoismo che cerca di conservarsi arriverà alla contemplazione.
IV. Il quarto elemento della vita monastica contemplativa è l’umiltà. S. Benedetto, volendo istituire una scuola del servizio di Dio, ci mostra una via dritta per arrivare alla gloria celeste. Questa via è l’umiltà. È vero che veniamo alla vita camaldolese per umiliarci davanti al Signore fino in fondo. L’ascensione spirituale dell’Eremita è realmente una umiliazione sempre più profonda dinanzi a Dio e una sottomissione sempre più perfetta, totale e amorosa alla sua volontà. Questo atteggiamento di totale umiliazione e sottomissione a Dio fa entrare nella vera pace di Dio, dove una profonda contemplazione si fa possibile.
3. Umiltà
Il capitolo settimo della nostra Santa Regola è d’importanza capitale. Si può in questo capitolo vedere come un sommario della vita spirituale del monaco, un itinerario dell’anima monastica a Dio. È la via dell’amore, siccome – secondo la bella espressione di San Francesco di Sales – l’umiltà è “un amore che scende”. San Benedetto ci presenta un tipo di monaco tutt’altro che raggomitolato su se stesso in un atteggiamento di timidezza e di affettata modestia. L’umiltà fa dei monaci una vera stirpe dai tratti netti e vigorosi, temprata nelle dure battaglie della fede e nella diuturna fatica del ritorno a Dio per la via dell’obbedienza; una stirpe di servi, allenati al superamento dell’egoismo e pur sempre consapevoli di essere inutili e – come tutti gli altri uomini – peccatori. Monaci autentici, dunque, sono coloro che non vanno “in cerca di cose grandi” (Sal 130, 1c), ma, al contrario, guardano con animo da bambini a colui che solo è grande e che tuttavia si è fatto l’ultimo di tutti, per dare l’esempio da seguire: Imparate da me che sono mite ed umile di cuore (Mt 11, 29). L’insegnamento fondamentale messo in programma nella scuola del servizio divino è proprio quello che fa apprendere a camminare umilmente con Dio.
Noi dovremmo distinguerci soprattutto in questo, ma spesso non sappiamo nemmeno capire quanto ci manchi per essere almeno un po’ riconoscibili quali appartenenti alla stirpe dei miti e umili di cuore! Miti non sono i “rassegnati” ma i “forti” che sanno piegare se stessi, con l’aiuto di Dio, sempre guardando al Cristo che si è abbassato fino all’estrema umiliazione. Se vogliamo essere sinceri dobbiamo riconoscere che tutte le nostre punte di risentimento sono dovute a mancanza di umiltà; tutti i nostri scoraggiamenti, le nostre malinconie, le nostre tristezze, i nostri abbattimenti sono dovuti a mancanza di vera umiltà, perché non sappiamo accettare come normale la via della Croce. Vorremmo camminare comodamente, senza rimetterci troppo; anche nell’impegno della Santità siamo sempre tentati da questa paura; santi sì, ma non a troppo caro prezzo!
Chi si esalta, sarà umiliato… (Lc 14, 11; 18, 14): quanti sono i modi in cui ci si esalta, si resiste o, ci si affanna in ciò che non è la pura ricerca di Dio! C’è un modo di esaltarsi che consiste nel non saper accettare con amore e profonda convinzione di fede le situazioni dure e contrarianti ma provvidenziali, che ci impongono distacco e sacrificio nel rapporto con gli altri o nel nostro cammino interiore. C’è un orgoglio che consiste nel non avere la giusta conoscenza della propria realtà, nel non accettare la verità su se stessi, e quindi nel fare in modo di “tenersi su” di fronte agli altri, rifuggendo da tutte le situazioni che potrebbero mettere in evidenza i nostri limiti.
Ecco come si comporta chi vuole camminare nell’umiltà: davanti a qualsiasi trattamento o situazione, si sente in certo modo fortunato e prova gratitudine profonda, sincera, perché è convinto che gli altri fanno sempre troppo per lui. Chi invece non è umile o almeno desideroso di diventarlo, è sempre scontento; ha sempre l’impressione di non ricevere quanto merita. L’orgoglio ha reso Lucifero, angelo della luce, scontento di Dio e invidioso della sua gloria. Quando anche noi siamo scontenti degli altri e di tutto, non illudiamoci, è segno chiaro che siamo egoisti e superbi. Ogni esaltazione è una specie di superbia… (Regola, cap. VII): esaltazione sono gli atteggiamenti contenziosi di chi non si mette mai al suo giusto posto, o non ritiene mai di esservi messo. Si può perfino trascorrere tutta una vita rammaricandosi per la mancanza di circostanze favorevoli (o di persone illuminate) che mettano in risalto le nostre vere capacità! C’è un modo di pretendere stima o premura che può anche non sembrare amor proprio, ma di fatto lo è. “Ogni esaltazione…”: torniamo a dirlo: ogni “tentativo di tenerci su”, di non lasciarci buttare giù dalle nostre illusorie altezze, si oppone allo spirito del Vangelo, del Cristo. Occorre dunque acquistare la mentalità della Croce; abbassandosi si viene innalzati, innalzandosi da se stessi si precipita invece nel vuoto. Con Gesù Cristo, Dio fatto uomo, è avvenuto un capovolgimento dei valori.
Se, dunque, fratelli, noi vogliamo toccare le vette della più grande umiltà, se noi vogliamo giungere rapidamente a questa celeste altezza, cui si può salire mediante l’umiltà della presente vita, dobbiamo innalzare – ascendendo con i nostri atti – quella scala che apparve in sogno a Giacobbe, sulla quale egli vedeva angeli scendere e salire. Certamente questa visione vuole significare che l’esaltazione dell’orgoglio fa discendere, mentre l’abbassamento dell’umiltà fa salire (Regola, cap. VII). Tutta la spiritualità monastica, se può aver avuto interpretazioni diverse circa l’ascesi corporale, o circa la forma della preghiera, ha però sempre ritenuto l’umiltà quale valore fondamentale che ci pone alla radice di qualsiasi vocazione a Dio. “Il monachesimo – dice Padre Adalbert De Vogüé – si è sempre manifestato come una via di umiltà. Nell’ambito cenobitico questa umiltà si realizza nella dipendenza economica (povertà); nell’obbedienza (non auto-determinazione); nel nascondimento, nella pazienza che è un modo di mettersi sotto gli altri”.
Il primo grado di umiltà consiste nel porsi sempre davanti agli occhi il timor di Dio, per evitare nel modo più assoluto di vivere da smemorati. Occorre infatti ravvivare sempre il ricordo dei divini comandamenti e considerare ogni momento la realtà dell’inferno che – come fuoco divorante – consuma, per i loro peccati, i disprezzatori di Dio, mentre per coloro che li temono è preparata la vita eterna (Regola di S. Benedetto, cap VII). Ecco dunque qual è il contenuto del primo grado dell’umiltà: è consapevolezza della presenza di Dio; rinnovare continuamente il ricordo di Lui per fuggire la smemoratezza dell’uomo superficiale e svagato. Secondo San Benedetto l’umiltà è una virtù essenzialmente contemplativa. Non si arriva all’umiltà – come Lui la capisce – per esercizi di auto-disprezzo e di umiliazione. Essa scaturisce direttamente dal contatto con Dio e dalla meditazione della verità totale su Dio e sull’uomo.
Il primo grado di umiltà ci dice che la pratica dell’umiltà si inizia con un esercizio continuo e paziente di mettersi davanti agli occhi la pienezza di questa verità. Questo deve essere un vero esercizio ascetico: “Sibi ante oculos semper ponens, oblivionem omnino fugiat”. Contrariamente a ciò che caratterizza l’uomo moderno, che non tratta Dio con serietà, San Benedetto vuole che il suo monaco viva davanti al Signore e davanti a tutto ciò che Dio ci ha rivelato. Per i moderni Dio è così misericordioso che i peccati non costituiscono nessun pericolo per la salvezza. In ogni caso una onesta mediocrità può sempre bastare per contentare il Signore… S. Benedetto mette il suo monaco davanti a tutta la pienezza del problema della salvezza dell’uomo. Anche il monaco deve meditare la realtà dell’inferno come pena del peccato e, d’altra parte, deve elevare il suo spirito con la speranza e il desiderio ardente della vita eterna. Così al principio del suo cammino spirituale il monaco deve trattare Dio, la sua volontà, i suoi comandamenti, il suo giudizio e le sue sanzioni con una serietà diciamo estrema.
Nella Regola di San Benedetto i gradini dell’umiltà riguardanti l’atteggiamento esteriore dell’uomo si trovano alla fine della sua scala. Un lettore superficiale della Regola può essere sorpreso di trovare prescrizioni sul parlare e sul riso – che sembrano essere molto più facili e accessibili – dopo il settimo grado che contiene la vetta dell’umiltà spirituale. Questo ordine mostra l’intenzione dell’Autore della Regola di formare prima di tutto lo spirito, affinché le manifestazioni esteriori dell’umiltà siano emanazioni di una umiltà interiore autentica e profondamente vissuta, e non soltanto atteggiamenti formati per un’ascesi esteriore priva di contatto con Dio e priva del timore di Dio, che ne deve essere la sorgente e l’anima. Quindi, l’ascesi benedettina è costruita su una piena e costante consapevolezza della verità rivelata. Un contatto spirituale costante con questa verità totale è nell’anima umana la sorgente di un dinamismo speciale, il quale come semplice affermazione di Dio è amore, e, come una sottomissione a Dio, atteggiamento che sempre e in tutto conta con Dio e con la volontà di Dio, è il timore di Dio. Da questi due risulta l’umiltà, che è insieme un’affermazione totale di Dio e una sottomissione anche totale a Lui.
Una vita fuori della verità e fuori della presenza ardente di Dio non può essere purificata. Abbiamo quindi in questo primo grado di Umiltà una dottrina della purificazione spirituale, una salda e provata dottrina della via purgativa. Ma questa potenza purificatrice agisce se il monaco “fugge in tutti modi la dimenticanza”; se invece non è consapevole di tutte quelle grandi realtà, la fiamma di Dio non lo purifica e rimane nei suoi peccati siccome manca di lucidità per conoscerli e di forza per combatterli. Stando davanti a Iddio l’uomo comincia a rendersi conto dei suoi peccati e poco a poco diviene capace di scorgere e di controllare i diversi movimenti del suo cuore.
E guardandosi in ogni istante dai peccati e dai difetti dei pensieri, della lingua, delle mani, dei piedi e della propria volontà, ma anche dai desideri della carne, l’uomo consideri che Dio dal cielo lo guarda sempre, e che le sue azioni in ogni luogo sono osservate dallo sguardo della Divinità, e gli sono riferite continuamente dagli angeli (Regola, cap. VII) L’uomo senza raccoglimento interno, senza consapevolezza della presenza di Dio, l’uomo che si lascia vivere così in superficie, non arriva mai alla conoscenza di se stesso. Egli non sa niente dei diversi movimenti che agiscono nella sua anima. Un tale uomo è incapace di purificazione. Per lui entrare nel sistema ascetico di San Benedetto con gli esercizi del I° grado di umiltà significa una vera e profonda conversione.
4. Ispirazioni di Dio (I) [3]
Carissimi Confratelli!
Una cosa che è essenziale per la nostra vita eremitica è ciò che chiamerei l’ascolto continuo di Dio. È cosa propria della vita cristiana, cosa che la distingue da tutte le altre concezioni di vita. La ragione di questa differenza radicale consiste in questo, che la vita cristiana è una convivenza con Dio. La formulazione più vecchia di questa realtà si trova già nell’Antico Testamento. Nel primo dei nostri Sacri Libri, nella Genesi, si dice parlando dei Patriarchi: Cum Deo ambulavit. Cioè, “camminava con Dio” (6, 9). È la formula più antica e più semplice della perfezione. Si dice per esempio di Noè: Noè era uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei, Noè camminava con Dio (Gn. 6, 9). Camminare con Dio, essere con Dio, fare tutto insieme con Dio… Come si potrebbe dire più semplicemente ciò che difatti costituisce la perfezione spirituale del cristiano?
Nelle concezioni puramente naturali della perfezione umana si parlerebbe piuttosto della formazione del carattere, dell’acquisto delle virtù. È certo che un carattere nobile, elevato e vigoroso, dotato di un insieme di virtù che rendono l’uomo giusto, prudente, casto, temperante, coraggioso, forte e paziente… costituisce un bene che potrebbe essere presentato come ideale e scopo della vita e degli sforzi morali di un uomo. Nel cristianesimo tutto questo conserva il suo valore, ma non basta.
La Rivelazione divina ci insegna che l’uomo non è chiamato a costruire la propria perfezione morale, ma è chiamato a vivere con il suo Dio in amore e unità con Lui. È vero che questa unità con Dio esige una trasformazione profonda dell’uomo, esige la perfetta purificazione del suo essere, la trasformazione del suo carattere, però non come condizione previa che si dovrebbe compiere con le sole forze umane, prima di incominciare con Dio.
L’unione con Dio non è solamente il fine, lo scopo di tutti gli sforzi del cristiano, ma è insieme il mezzo indispensabile per raggiungere questo ideale, la via per la quale si arriva a questo fine. Noi vogliamo arrivare all’unione con Dio usando come mezzo essenziale la stessa unione con Dio. Cristo non è soltanto la Verità che cerchiamo, non è soltanto la Vita alla quale aneliamo pervenire; Egli è ancora la Via, e l’unica Via per la quale possiamo sperare di pervenirvi. La vita del cristiano che vuole arrivare all’unione con Dio deve cominciare dall’unione con Dio, altrimenti non arriverà al fine al quale mira di pervenire.
Cristo è quindi il primo e non esiste una preparazione a Cristo che sia senza Lui. O Lui è il primo, o non arriveremo mai a Lui. Se la peccatrice del capitolo settimo di S. Luca avesse voluto prepararsi a purificarsi prima di giungere al Signore, non sarebbe mai andata perché una preparazione a Cristo non esiste. Lui per opera di Dio divenne per noi sapienza e insieme giustizia e santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto: “colui che si gloria si glori nel Signore” (1 Cor 1, 30-31). Questa è la caratteristica della vita cristiana a confronto con tutte le altre concezioni di vita e di perfezione umana. Per il cristiano la vita è fin dall’inizio una convivenza con Dio. Se è veramente così, ne risulta che il contatto vitale con Dio è il fondamento, la sorgente dalla quale scaturisce tutta l’evoluzione della vita spirituale umana.
Ma se questa misteriosa convivenza con il Dio Vivente è una realtà, ne risulta un’altra verità che manifesta chiaramente la grandissima differenza tra la vita cristiana e la vita umana concepita come uno sviluppo naturale. Questa verità consiste nella direzione interna dello Spirito di Dio che è il vero Pedagogo, il vero Maestro ed Educatore del cristiano. Questa direzione spirituale compiuta dallo Spirito Santo è doppia: una esterna, che si fa per la Rivelazione e la Chiesa, e l’altra, interna, che si realizza per l’ispirazione personale.
Su questa pedagogia interna dello Spirito, cioè sull’ispirazione, vorrei insistere oggi. È una cosa di importanza grandissima e San Benedetto ne parla nel Prologo della sua Regola, ove attira l’attenzione del monaco sul “deificum lumen” e sulla voce di Dio “quotidia clamans”, la voce di Dio che grida ogni giorno e parla all’anima del monaco. La ragione principale della nostra ricerca di solitudine e di silenzio è appunto questa, che vogliamo metterci in atteggiamento di poter sentire questa voce di Dio poiché, senza udirla, è impossibile per l’uomo progredire nella perfezione spirituale. Il Salmo 27 dice: “A Te, Jahvé, io grido, mia rocca; non farti sordo con me! Affinché facendoti unito con me, io non sia come quelli che scendono nella fossa” (27, 1). Senza questa collaborazione intima con lo Spirito Santo non è possibile alzarci sopra una mediocrità. Le virtù eroiche dei Santi sono manifestazioni della potenza di Dio che opera liberamente nella loro anima sensibile e aperta alle Sue ispirazioni.
Ora dobbiamo riconoscere che la nostra vita eremitica, solitaria e silenziosa è molto adatta a condurre lo spirito umano a quello stato di attenzione interna alle ispirazioni divine. Veramente si sente con facilità Dio nella cella dell’eremita, se soltanto si vuole sentirLo e accettare la Sua direzione. Nella vita umana ordinaria, in mezzo alle occupazioni mondane, i cristiani spesso neppure hanno un’idea delle ispirazioni dello Spirito Santo. Lui è presente e agisce anche nella loro vita, ma il chiasso mondano, la fretta oggi quasi continua, la molteplicità delle cose da pensare e da fare, l’infinità di impressioni diverse che produce ogni giorno la vita moderna, rendono veramente difficile questa attenzione spirituale a Dio, presente e parlante. Invece – l’esperienza ci mostra – come è facile, vivendo nella cella eremitica, renderci conto della volontà di Dio, delle preferenze del Signore che ci spingono con delicatezza a tale preghiera, a tale rinunzia, a tale umiliazione. Vere possiamo dire col Profeta Baruch: “Noi beati, o Israele, perché ci è noto quello che piace a Dio” (Bar 4, 4).
5. Ispirazioni di Dio (II) [4]
Abbiamo detto l’ultima volta che la nostra vita di solitudine e di raccoglimento crea delle condizioni ottime per conoscere la volontà di Dio e sentire le sue ispirazioni. Quanto più siamo raccolti, tanto più Dio ci spinge internamente a una conversione vera, profonda, coraggiosa, ci spinge a intraprendere con una decisione virile questo “viaggio” santo verso Gerusalemme, del quale ci parla il Salmo 83 nella nostra Santa Liturgia. Ciascuno di noi sente in se stesso questa voce dello Spirito che parla senza parole.
L’ispirazione non cambia ogni giorno, non ci propone ogni giorno un’altra cosa. Dio nell’anima agisce piuttosto così: le suggerisce di fare questo, o lasciare questo, rinunciare a questo… e poi il giorno seguente o forse dopo settimane o mesi ritorna allo stesso e dice: “Perché non l’hai fatto? Io aspetto ancora… se lo farai, potrà essere una cosa d’importanza decisiva per il tuo progresso, per la tua vita intera… Non mi rifiutare…” Così, in questo dialogo quotidiano con il Signore, se l’anima si sforza di essere fedele, maturano delle decisioni interne che rendono l’anima capace di fare cambiamenti profondi e decisivi nella vita, ai quali senza questo assiduo dialogo non avrebbe né luce né coraggio di pervenire.
Ma si deve anche prendere in considerazione un’altra verità, cioè che le ispirazioni divine non bene accettate possono creare una situazione spirituale pericolosa, se l’uomo sa bene cosa dovrebbe fare per piacere al Signore e nondimeno non lo fa. Di questo pericolo ci parla la Santa Scrittura. È veramente raccapricciante ciò che dice il Salmo 80: Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire: Israele, se tu mi ascolterai, non ci sarà in te dio straniero, né ti prostrerai a un Dio forestiero. Sono io, Jahvé, il tuo Dio, che ti feci uscire dalla terra d’Egitto. Apri la bocca e la riempirò. Ma non diede ascolto il mio popolo alla mia voce e Israele non volle saperne di me (80, 9-12). Dio chiede questo ascolto per il bene dell’uomo stesso, e dice quali sono i vantaggi di un tale atteggiamento di attiva sottomissione dello spirito umano al Signore. Il principale vantaggio è la conoscenza del vero Dio, che fa svanire tutti i falsi dèi, tutti valori illusori: “non ci sarà in te dio straniero, né ti prostrerai a un dio forestiero…”. Allora conoscerai che “io sono Jahvé, il tuo Dio, che vi fece uscire dalla terra d’Egitto”. Secondo il salmista il frutto di questo fedele ascolto del Signore, di questa prontezza a compiere la sua volontà, sarebbe una conoscenza personale di Dio come Dio nostro, come il Dio Salvatore che ci ha salvato dalla servitù egiziaca. La munificenza di Dio in favore di quelli che Lo vogliono ascoltare viene brevemente espressa in questa piccola frase del Salmo: “Apri la bocca e la riempirò”.
Difatti, il popolo di Israele non si è mostrato fedele ad ascoltare il suo Dio, né desideroso di compiere sempre la sua santa volontà. Le conseguenze sono state terribili. Ecco cosa ne dice il Signore stesso: “Ma non diede ascolto il mio popolo alla mia voce, e Israele non volle saperne di me”. Quali sono state le conseguenze di un tale atteggiamento, vediamo: E li abbandonai alla ostinazione del loro cuore; camminino pure nei loro voleri! (80, 13). Non ci può essere una punizione più terribile in questo mondo. È veramente una cosa spaventosa esser così abbandonati da Dio ai nostri propri voleri, ai pensieri del nostro proprio cuore, senza la luce divina che ci conduca in questo tenebroso mondo. Questa punizione è per quelli che non vogliono ascoltare il Signore quando parla al loro cuore sulla strada della loro vita. Difatti, che cosa può essere più spaventoso per un uomo dell’essere lasciato così alle tenebre del suo povero intelletto accecato?
Ma Dio è sempre pronto ad aiutarci. Dopo questa minaccia il Signore continua nel Salmo: Se il mio popolo mi ascolterà, Israele se camminerà nelle mie vie, in breve piegherò i loro nemici… e lo nutrirò di fior di frumento e lo sazierò con miele della rupe” (80, 14-15a.17). Il peccato dell’indocilità è molto pericoloso, ma con Dio è sempre possibile ripararlo presto e totalmente per una rinnovata volontà di ascolto.
Per renderci sensibili alle divine ispirazioni dobbiamo prima essere molto attenti alle espressioni ordinarie della volontà di Dio, e prima di tutto coltivare nella nostra anima un desiderio sincero e ardente di compiere in tutto la volontà del Signore, di sottometterci a Lui in tutti i nostri desideri e tutte le nostre azioni. Penso a questo atteggiamento dell’anima che si trova perfettamente espresso nel Salmo 118: “Con tutto il mio cuore Ti cerco, non farmi deviare dai Tuoi precetti. Nel mio cuore celo i Tuoi detti, per non peccare contro di Te, Benedetto sei Tu, Signore, insegnami i Tuoi decreti. Con le mie labbra ripasso tutti i giudizi della Tua bocca. Sulla via delle Tue testimonianze gioisco più che per ogni ricchezza. Sui tuoi ordini io medito e considero i Tuoi sentieri. Nei Tuoi decreti mi allieto, non dimentico la Tua parola” (118, 10-16). Questo è un atteggiamento spirituale perfettamente benedettino. Questo ardente desiderio di sottomettersi perfettamente a Dio, di fare solamente la Sua volontà costituisce il fondamento di una spiritualità sana e sicura. A una tale volontà Dio non resiste, e lo Spirito Santo non nega le sue ispirazioni.
In questo clima spirituale si sviluppano quelle realtà che nella teologia spirituale si chiamano doni dello Spirito Santo. Questi doni sono diversi e la tradizione ne enumera sette. Ma tutti hanno questo di comune, che sono delle disposizioni che rendono l’uomo capace di sentire le ispirazioni dello Spirito Santo. Una immagine può facilitare la comprensione di questa dottrina. In questo ambiente ove ci troviamo ci sono innumerevoli onde elettromagnetiche portatrici di voce umana provenienti da molte stazioni radiotrasmittenti. Ci sono discorsi, ci sono concerti di musica, ecc… Sono qui, in questo spazio dove siamo noi, ma non possiamo udire tutte queste voci non avendo un apparecchio adatto per captare queste onde. E così tutta questa realtà benché presente ci sfugge. Così le anime che non hanno in sé questi doni dello Spirito abbastanza sviluppati mancano dell’organo necessario per incontrare e sentire queste sottili voci dello Spirito che parla. La Santissima Vergine Maria, Sposa dello Spirito Santo, aveva questi doni in una tale pienezza che tutte le ispirazioni e le mozioni dello Spirito furono nella Sua anima pienamente efficaci. Il primo dono, fondamento di tutti gli altri, è il dono del timore di Dio. È appunto questo dono che fa prendere all’anima l‘atteggiamento del quale abbiamo parlato sopra, cioè l’umile e ardente desiderio di una sottomissione totale al Signore.
6. I comandamenti di Cristo (I) [5]
Insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato (Mt 28, 20). Abbiamo visto sabato scorso che il Signore Gesù, incontrandosi dopo la sua Risurrezione con i suoi discepoli in Galilea, li ha mandati nel mondo per istruire tutte le genti e battezzarle nel nome… Come attrezzatura per questo difficilissimo incarico ha dato loro la Sua potente Parola e l’inesauribile tesoro dei Sacramenti: “istruite tutte le genti battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28, 19). Alla proclamazione della salvezza e al dono dei sacramenti aggiunse ancora un terzo dono: l’istruzione morale: “insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato”.
È certamente essenziale per un cristiano sapere che è stato riscattato dalla potenza tenebrosa del peccato e della morte per la Misericordia infinita del Padre e la Croce salvifica del Figlio, credere nella risurrezione e la vita eterna. È anche essenziale partecipare a questa realtà mediante i sacramenti; ma il cristiano come discepolo di Cristo deve ancora sapere come vivere secondo questa grazia, deve conoscere la via nuova discesa dal cielo sulla terra per poter camminare secondo essa. Il Signore non ci lascia senza istruirci anche in questo campo importantissimo della vita umana: “insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato”. La Parola di Dio non solamente ci rivela ciò che Dio ha fatto amorosamente per noi, ma ci fa vedere anche quello che noi dobbiamo fare in amorosa risposta alla sua grazia immensa.
Così è vero ciò che dice il Salmo 118: “Lampada al mio piede è la Tua parola, e luce al mio cammino” (118, 105). Ma quando un cristiano pensa ai comandamenti del Signore, pensa ordinariamente al Decalogo. È giusto questo perché il Decalogo conserva sempre il suo valore e la sua attualità. Però, se si limitano le esigenze di Dio a quelle espresse nel Decalogo anche estendendole al loro prolungamento spirituale, si perde molto della luce nuova apportata dal Vangelo. Quindi, se il Signore Gesù ha mandato i suoi Apostoli per insegnarci ad osservare tutto ciò che Lui “ha comandato”, deve essere molto attento il cristiano, quando legge il Vangelo, di non trascurare queste numerose espressioni della volontà del Signore, ma di sforzarsi di essere obbediente ad esse. Certamente questi precetti del Vangelo sono molto numerosi e non è possibile per noi qui meditarli tutti, ma per svegliare la nostra attenzione, affilare la coscienza e aguzzare il desiderio, sarà buono meditarne almeno alcuni.
Quando parliamo dei Comandamenti di Dio, c’è una cosa che dobbiamo sempre prendere in considerazione. Penso a questa verità fondamentale, che il dono di Dio sempre precede le sue esigenze. Quindi, le esigenze di Dio sono rivelazioni del suo dono, sono conseguenze e come l’altra faccia della sua grazia. Dio esige ciò che ha dato e niente di più. San Agostino l’ha capito bene e quando dice: “Domine da quod iubes, et iube quod vis” (Signore dacci ciò che comandi e comanda ciò che vuoi). Quindi, rivelandoci ciò che dobbiamo, Dio ci rivela ciò che possiamo, ci rivela le forze e le possibilità della nuova natura che ci ha dato in Cristo Gesù.
Tra le parole di Gesù troviamo una che ricorre molto spesso sulle labbra del Signore. Gesù ama dire agli uomini “Non temete”. Questa parola ha un doppio significato. (1) Essa costituisce l’espressione della nuova relazione dell’Umanità con Dio nel Nuovo Testamento. È una relazione di vicinanza, di amore, di comunione. In questo senso l’Angelo disse a Maria e, in sua persona, a tutta l’umanità: Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio (Lc 1, 30). Queste parole, indirizzate principalmente a Maria, riguardano noi tutti. A ciascuno di noi si potrebbe dire: “Ne timeas, invenisti gratiam” (Non temere perché hai trovato grazia). L’Annuncio dunque dell’Angelo a Maria è l’annuncio del Nuovo Testamento, l’inizio del Nuovo Testamento. Questo stesso senso ha la parola di Gesù alle donne ritornanti dal sepolcro : “Non temete, andate a dire ai miei fratelli…” (Mt 28, 10). Si deve dunque avere un rispetto infinito per Dio, non dimenticando però l’amore che cambia tutto e fa dire al Figlio di Dio: “miei fratelli”. Il primo senso di questo comandamento: “non temete”, comporta dunque una relazione con Dio del tutto nuova, una relazione di comunione figliale. Dio vuole che l’uomo conformi il suo atteggiamento riguardo a Dio alla grazia della filiazione ricevuta.
(2) Il secondo significato di questo comandamento: “non temete”, è differente. Nella descrizione evangelica della tempesta sul mare San Marco scrive: “Sopravvenne un violento turbine di vento che spingeva le onde nella barca, in modo che essa ne era già piena. Ed Egli, a poppa dormiva sopra un cuscino. Lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non t’importa che periamo? Ed Egli, svegliandosi minacciò il vento e disse al mare: Taci! Calmati! E il vento cadde e si fece grande bonaccia. Poi disse loro: Perché avete paura così? Come! Non avete fede?” (Mc 4, 37-40). In un altro luogo dice: “Sono io, non temete” (Gv 6, 20). Il coraggio è dunque un obbligo per un discepolo di Cristo. Se il Creatore del cielo e della terra è con noi, che cosa possiamo temere? Dio vuole che facciamo nostre le forti parole del Salmo 45: “Dio è per noi rifugio e presidio; aiuto grande si mostrò nelle strette. Perciò non temeremo se si stravolge la terra, se crollano i monti nel cuore dei mari. Mugghino e spumeggino pure le loro acque; tremino i monti quando si gonfiano. ( ) Jahvé degli Eserciti è con noi; è Rocca per noi il Dio di Giacobbe” (45, 2-4.8). E San Paolo nel suo inno all’amore di Dio nella Lettera ai Romani scrive: “Chi potrà strapparci dall’amore di Cristo? Quale tribolazione, angustia, persecuzione, fame, nudità, pericolo, spada? Se pur sta scritto: ogni giorno per Te siamo messi a morte. Siamo trattati come pecore da macello. Di tutte queste prove trionfiamo appieno, grazie a Colui che ci ha amato. Certamente né la morte, né la vita, né gli angeli, né i principati, né il presente, né il futuro, né le potenze, né cose alte o profonde, né alcun’altra creatura ci potranno separare dall’amore di Dio che ci giunge nel Cristo Gesù, nostro Signore” (Rm 8, 35-39 ). Il comandamento evangelico del coraggio cristiano è fondato sull’Amore di Dio, sulla sua irrevocabile fedeltà e presenza nella vita del discepolo. Il coraggio è inseparabile da una vera fiducia in Dio. Mandando i suoi discepoli al combattimento che li condurrà fino al martirio, il Signore Gesù dice: “Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l’anima; (…) Due passeri non si vendono forse per un asse? E non uno di essi cade a terra senza la permissione del Padre vostro. Quanto a voi, anche i capelli del vostro capo sono numerati. Dunque, non temete” (Mt 10, 28.29-31).
Meditiamo ancora un altro comandamento del Signore. Egli dice nel Vangelo di San Matteo: Venite a Me, voi tutti che siete stanchi e aggravati, ed io vi darò riposo (Mt 11, 28). Si considera queste parole piuttosto come un appello, una amoroso invito. Ma per un vero discepolo di Gesù, che vuole obbedire ad ogni volontà del suo Maestro e Signore, questo invito è anche l’espressione della volontà di Colui che ha ricevuto dal Padre ogni potere nel cielo e sulla terra. Siamo già con Lui e Lui è con noi, e nondimeno dobbiamo ancora venire a Lui.
C’è una solitudine buona, quella degli eremiti che cercano la solitudine per non essere soli, che cercano la solitudine per essere con Lui, cioè per compiere questo suo comandamento: “Venite a me”. Perché esistono tutti questi bellissimi eremi, veri paradisi sulla terra, se non per venire a Lui ed essere con Lui, per compiere questa sua misteriosa volontà di essere con noi? È veramente meravigliosa questa confidenza di Dio che si trova nel Libro dei Proverbi 8, 31: “Mi ricreavo sulla faccia della terra e la mia delizia era tra i figli dell’uomo”. Una confidenza veramente stupenda! Noi difficilmente sopportiamo la compagnia degli uomini e Dio trova la sua delizia tra loro. Ma se ci ha rivelato questo, noi vogliamo procurarGli questa delizia e perciò cerchiamo la solitudine per essere con Lui. Questa è la vera, la buona solitudine, quella che compie il suo comandamento: “Venite a me”.
Ma c’è un’altra solitudine, cattiva, contraria a quella sua volontà. Guardiamo un po’ la nostra vita e consideriamo se non siamo un po’ troppo soli nella nostra vita, nelle nostre decisioni, nei nostri problemi, nelle nostre sofferenze, nelle nostre prove e incertezze, nei nostri sforzi quotidiani del nostro cammino verso la perfezione e la salvezza eterna. Questa solitudine, questa solitaria baruffa dello spirito umano con se stesso senza riposarsi in Lui, non è secondo la volontà di Dio. Dio non si è fatto uomo perché l’uomo fosse solo, abbandonato a se stesso nella sua vita. Tutta la vita dobbiamo imparare a vivere insieme con Dio, a essere con Lui, pensare e agire con Lui, soffrire con Lui. Tutta la vita dunque dobbiamo imparare a compiere questo suo comandamento : “Venite a me, ed io vi darò riposo”.
7. I comandamenti di Cristo (II) [6]
Insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato (Mt 28, 20). Dopo aver esortato i suoi uditori, e noi tutti con loro, di venire a Lui, il Signore disse: Prendete il mio giogo su di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete riposo per le anime vostre (Mt 11, 29). Come, Signore? Tu dici: “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e aggravati, ed io vi darò riposo” (Mt 11, 28), e subito aggiungi: “prendete il mio giogo su di voi”. Tu prometti agli stanchi e agli aggravati un riposo e proponi invece un giogo! È questo il Tuo riposo?… Non sei Tu il gran Aspettato di cui parla il Profeta Isaia dicendo: “Il giogo pesante del popolo e la sbarra intorno alle sue spalle, il bastone del suo aguzzino Tu hai spezzato come nel giorno di Madian?” (Is 9, 3). Tu sei il Liberatore che toglie ogni giogo, e Tu ci parli ancora di giogo, Tu ci esorti a prendere il giogo?
Si, è un giogo di Cristo che dobbiamo portare. In un altro luogo del Vangelo Gesù lo nomina apertamente dicendo: Chi vuole seguirmi rinneghi se stesso e prenda la sua croce ogni giorno e mi segua (Lc 9, 23). L’Uomo è stato liberato dal durissimo giogo del diavolo non per essere senza giogo, ma per assumere il giogo di Cristo che è pieno di dolcezza. Il Signore disse altrove : “Nessuno può servire a due padroni” (Mt 6, 24). E tu forse pensi: “non posso servire a due, e dunque non servirò a nessuno”. Questo non è possibile. L’Uomo è troppo debole per questo. Se non serve Dio, cadrà certamente nelle mani del diavolo. L’unica via per scappare alla servitù del diavolo è di farsi servo di Dio, di appartenere a Lui. Un piccolo stato tra due superpotenze non potrà conservare una perfetta indipendenza, ma cercherà l’appoggio dell’una o dell’altra, rinunziando così a una piena autonomia. La potenza del diavolo è grandissima, uno solo di questi spiriti cattivi è più forte di tutto il genere umano e l’odio che sentono verso gli uomini è tremendo. Se per un solo momento Dio cessasse di custodire l’umanità, queste migliaia di nemici accanitissimi la distruggerebbero subito. Come l’uomo può pensare di poter conservare la sua indipendenza e la sua libertà appoggiandosi su se stesso?
Liberati quindi dal durissimo giogo del diavolo, prendiamo il giogo di Cristo. E bene dice il comandamento del Signore: “prendete”. L’atteggiamento spirituale significato per questa parola “prendete” è molto importante. Significa un’accettazione attiva di un peso come dono del Signore. Così dobbiamo ricevere tutto dal Signore, anche le cose pesanti, come dono del Suo amore. Nella vita spirituale del cristiano, del monaco, la maniera con la quale lui prende il giogo dei suoi doveri, della sua esistenza reale e concreta, il giogo delle sue prove e delle sue sofferenze, ha una grande importanza.
Se un operaio deve portare un sacco di 100 chili di grano, non è certo indifferente come lo prenderà sulle sue spalle; se lo prende male, non potrà camminare con questo peso e lo lascerà presto, ma se sottomette bene le sue spalle al peso, non gli sembrerà esser troppo pesante. Si deve quindi formare in noi questa disposizione d’anima salda e forte, disposizione volonterosa di ricevere, di prendere su di sé con gioia il giogo del Signore. È molto importante questo. Purtroppo ci sono molti anche tra i monaci che sono sempre scontenti di ciò che hanno e non sanno portare il peso della loro vita con gioia. Così, la loro vita si guasta. Questa maniera di ricevere il giogo della nostra vita come dono di Dio, come dono del Suo amore, all’incontro del quale usciamo di noi stessi, farà che “troveremo riposo per le anime nostre”. Il riposo vero non è nella liberazione da ogni giogo, ma nell’accettazione amorosa del giogo del Signore. A questo riposo aneliamo, non a un riposo immaginario, che consisterebbe in una liberazione da tutti i doveri e tutte le sofferenze. Tra tutte queste situazioni possiamo trovare il riposo nel Cuore di Gesù, se vogliamo prendere il suo giogo e fare la sua volontà.
Per incoraggiarci il Signore aggiunge: il mio giogo, difatti, è agevole e il mio carico è leggero (Mt 11, 30). Pensiamo un po’ a queste parole che ci portano luce. Perché, se il peso che portiamo su di noi ci sembra duro e insopportabile, non è forse un segno che non portiamo il carico del Signore, ma un altro carico che non è suo? Spesso accade che l’uomo si piega sotto un peso che non può sopportare. Se volesse analizzare attentamente, potrebbe scoprire che ciò che porta con tale fatica e tale sforzo non è il carico del Signore, ma il giogo della sua propria volontà. Ci immaginiamo di dover assolutamente arrivare a qualche scopo, e non ci poniamo la questione purificatrice, se Dio lo vuole da noi, e allora comincia per noi una triste via di sforzi sterili, pieni di angosce e incertezze, una via senza pace né riposo. Il male non consiste nella grandezza del carico del Signore, ma consiste in questo, che il grande peso che portiamo non è il peso impostoci dal Signore, ma è il terribile peso della nostra volontà propria. Dobbiamo dunque spesso esaminarci per sapere se veramente portiamo il giogo del Signore e non un altro giogo.
Andando dalla Polonia con la macchina verso l’Italia per partecipare al Capitolo Generale dell’anno 1977, un’altra macchina mi ha sorpassato sulle montagne tra Vienna e Graz. Era un Apostolo della strada. Dietro alla sua macchina aveva una grande inscrizione: “Pensa se il tuo viaggio è conforme alla volontà di Dio”. San Giovanni scrive nella sua prima epistola: “Questo è l’amore di Dio: osservare i suoi comandamenti. Comandamenti che non sono gravosi, perché chiunque è generato da Dio sa vincere il mondo” (1 Gv 5, 3-4). San Agostino commentando questo passo scrive: “Tu forse dirai: come non sono gravosi i comandamenti di Dio? È forse facile amare i nemici? È forse facile sopportare persecuzioni?… Fratello mio, non dire che sono gravosi i comandamenti di Dio, quando la Parola di Dio ci insegna che non sono gravosi. Pensa piuttosto che tu non hai ancora ricevuto il dono a te destinato, il dono che rende facile il compimento dei comandamenti di Dio. Prega dunque col gemito della tua volontà per ricevere il dono della facilità. Questo è l’amore di Dio – dice S. Agostino – a cui il carico di Cristo è leggero, o piuttosto egli stesso è il carico di Cristo che è leggero”.
Ma il Signore, quando disse queste parole: “prendete il mio giogo su di voi”, aggiunse ancora una piccola frase: imparate da me che sono mite e umile di cuore (Mt 11, 29). La traduzione italiana di Salvatore Garofolo scioglie in un senso solo l’alternativa che rimane nel testo originale greco, dicendo: “imparate da me ché sono mite e umile di cuore”. Secondo questa traduzione ciò che abbiamo da imparare da Gesù Cristo è appunto la sua mitezza e l’umiltà di cuore. Ma si potrebbe e forse dovrebbe tradurre: “imparate da me perché sono mite e umile di cuore. La mitezza e l’umiltà di Gesù non costituiscono l’oggetto preciso del suo insegnamento, ma sono le qualità di chi vuol insegnare a meritare la fiducia dei suoi discepoli. Gesù è un buon Maestro perché possiede queste qualità di mitezza e di umiltà. Possedendole si capisce che le trasmette anche ai suoi discepoli. Non c’è dunque una grande differenza tra queste due interpretazioni.
8. Imitazione di Dio[7]
Una verità centrale della nostra religione cristiana è certamente quella che in Cristo Gesù siamo divenuti figli di Dio. Dio ci ha salvati e ci ha presi nella Sua Famiglia, creando per la sua ineffabile grazia una relazione di indicibile intimità tra Lui stesso e noi. Questa meravigliosa filiazione apre all’uomo creato “a immagine e secondo la somiglianza di Dio” (Gn 1, 26-27), e poi caduto nel peccato, la nuova possibilità di rinnovarsi a somiglianza di Dio che è ormai il Suo Padre. Di questo profondo rinnovamento spirituale parla San Paolo nell’Epistola ai Colossesi dicendo: “Vi siete spogliati del vecchio uomo con la sua condotta e avete rivestito il nuovo, quello che si rinnova per giungere alla piena conoscenza, secondo l’immagine di colui che lo ha creato” (Col 3, 10). Una caratteristica quindi dell’uomo rinnovato è la sua somiglianza a Dio. Il figlio rassomiglia a suo Padre. Questa somiglianza non è solamente un attributo dell’uomo rinnovato, ma costituisce un programma e un dovere da riempire, non è un carattere statico, ma una sorgente viva di un dinamismo di unione e di assomiglianza. Dal momento che l’uomo è divenuto figlio di Dio, non più la natura umana, ma la Natura Divina, Dio stesso è la norma della nostra perfezione. L’Apostolo può ormai dire: “Siate dunque imitatori di Dio quali figli diletti” (Ef 5, 1).
Il Signore nel Vangelo di San Matteo ci insegna: Avete udito che fu detto: Amerai il prossimo tuo e odierai il tuo nemico. Io, però, vi dico: Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, il quale fa levare il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti, amate quelli che vi amano, quale ricompensa avrete? Forse non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno forse lo stesso anche i pagani? – e infine aggiunge: – Voi, dunque, siate perfetti come il vostro Padre celeste è perfetto” (Mt 5, 43-48). Nell’Antico Testamento Dio aveva detto a Mosè: “Parla a tutta la comunità dei figli di Israele e dì loro: Siate Santi, perché io, Jahvé vostro Dio, sono Santo!” (Lv 19, 2). Notate che Dio non disse a Mosè: “Siate Santi come io, Jahvé vostro Dio, sono santo, ma perché io sono santo”. Segue una enumerazione di prescrizioni legali da osservare. Quindi, non si tratta qui di imitare la Santità di Dio, ma di osservare la Legge di Dio Santo e così di affermare la Sua santità. L’imitazione diretta di Dio appartiene al figlio, e perciò nel Nuovo Testamento, basato sulla filiazione, si dice: “siate perfetti come il vostro Padre celeste è perfetto”. Nel Vangelo di San Luca dirà: “siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6, 36).
Si vede, dunque, che per noi cristiani non esiste più una norma umana di perfezione, ma Dio stesso, il nostro Padre, rivelato dal Figlio, è la noma di perfezione per noi. Un moralista si sente imbarazzato leggendo la parabola del diciottesimo Capitolo di San Matteo. Il Signore vi parla di un re che voleva fare i conti con i suoi servi. Gli fu presentato uno che gli era debitore di diecimila talenti. All’umile preghiera di questo servo il re gli condonò tutto il debito. Ma poi questo servo uscendo fuori si imbatté in uno dei suoi compagni di servizio, che gli doveva cento denari. Secondo le leggi della morale naturale il servo creditore aveva diritto di esigere dal suo debitore il rimborso del suo prestito. La misericordia del re verso di lui non gli faceva perdere il suo diritto alla restituzione di cento denari. Certo, lui li esigeva con troppa severità, ma esigeva il suo. Non era dunque un conato di rapina, ma una esigenza troppo severa di restituzione di cosa dovuta… Perché dunque mandarlo in prigione e “consegnarlo agli aguzzini” (Mt 18, 34) se lui era nel suo proprio diritto?
Qui vediamo chiaramente la distanza tra la norma naturale e la norma evangelica. La norma naturale dice: non trasgredire i tuoi diritti, e la legge evangelica dice: fa come Dio, tuo Padre, ha fatto a te. L’unica norma è quindi Dio stesso e il suo modo di agire. Il Signore lo dice chiaramente: “Allora il re lo fece chiamare e gli disse: Servo malvagio, ti ho condonato tutto quel debito perché mi ti sei raccomandato; non dovevi a tua volta avere pietà del tuo compagno come io avevo avuto pietà di te?” (Mt 18, 32-33). Il servo sarà dunque punito non per aver commesso una ingiustizia, ma per non aver voluto agire come il suo re e Signore. Ecco la norma cristiana – agire come Dio, imitare il Padre per essere vero figlio ed esserlo sempre di più.
Quando si medita sugli attributi di Dio e si pensa quale dovrebbe essere la risposta dell’uomo-figlio a ciascuno di questi attributi, si vede subito un duplice modo di rispondere a questi attributi. Il primo modo è l’imitazione, e il secondo modo consiste nel tirare le conseguenze pratiche del fatto che Dio è così. Per esempio, Dio è Misericordia, il primo modo consisterà nell’imitare la Misericordia divina in tutte le nostre relazioni col prossimo, e il secondo sarà di appoggiarsi in tutto su questa Divina Misericordia. Ci sono degli attributi metafisici di Dio che il pensiero filosofico può dedurre dalla verità che Dio è la Causa Prima di tutto il creato, dunque è la Causa senza Cause, dunque “Ens a se”, necessario, infinito, onnipotente, sommo Bene, ecc… La meditazione di questi attributi metafisici di Dio è di gran prezzo per la vita spirituale.
Ma la Sacra Scrittura ci rivela ciò che si potrebbe chiamare il “carattere di Dio”. Ci mostra il Dio dell’Amore nelle sue relazioni agli uomini, nei suoi contatti con gli uomini, nel suo dialogo con l’uomo che riempie tutta la storia umana e ne costituisce il vero e unico senso. La rivelazione ci mostra il pensiero di Dio, il suo eterno disegno di salvezza in rapporto all’uomo. La Sacra Scrittura ci fa conoscere l’azione di Dio e le sue reazioni ai diversi atteggiamenti degli uomini. Finalmente, ci rivela anche il più profondo mistero della vita interna del Dio, uno nell’unità di Tre Persone. I cattolici moderni, per la figura di umiltà e di modestia dinanzi ai non credenti, dicono spesso: “noi non conosciamo molto, siamo ignoranti nelle cose essenziali della vita più o meno come voi”. Un atteggiamento certamente molto gentile e molto cortese, però non conforme alla verità, un atteggiamento cristiano che fa ingiuria a Dio e alla sua rivelazione. Si dovrebbe piuttosto dire con il Siracide: “Ti fu, infatti, mostrato più di quanto tu non possa comprendere” (3, 22). Possiamo, dunque, ora cominciare a meditare insieme su Dio e i suoi attributi.
9. Immutabilità (I)[8]
Si avrebbe oggi l’impressione che l’antico filosofo Eraclito sia diventato il favorito del nostro secolo. Lui infatti ha fissato il suo sguardo sul cambiamento continuo, sul flusso di tutte le cose esistenti. Nelle celebri parole panta rei, cioè tutto scorre, tutto passa, lui ha espresso la sua intuizione della realtà. La nostra generazione ha perso il senso dell’assoluto e dell’eterno per fissare lo sguardo sul relativo e sul variabile. La legge naturale, considerata da secoli come legge divina e eterna, inscritta per sempre nella natura umana, appare ai moderni come mutabile, come funzione di situazioni storiche, psicologiche, economiche, ecc… L’evoluzionismo e il suo grande eroe, Teilhard de Chardin, che rappresenta tutto il mondo in continua evoluzione, piace ai nostri contemporanei. Temono invece tutto ciò che si presenta come stabile, come assoluto. L’uomo moderno deve essere in un continuo progresso, deve essere creativo e perciò deve fuggire le obbligazioni di una morale che scaturisce da sorgenti eterne. Tutto questo lui vorrebbe rigettare come un “establishment”, come un assideramento che toglie la Libertà e rende il progresso impossibile.
Ma un vero contemplativo è sempre un uomo dell’eterno e dell’immutabile. È bellissima e profondissima l’espressione di S. Agostino, che in una brevissima formula unisce il mutabile all’eterno: “Per incommutabile nunc tuum omnia saecula transierunt”. Il contemplativo sempre gode non di quello che cambia, ma di quello che è immutabile, come dicono i certosini: “Stat Crux dum volvitur orbis”. La contemplazione dell’Eterno rimane sempre la sorgente della vera creatività e di un instancabile dinamismo di progresso autentico. Il miraggio del cambiamento continuo ha tutte le marche di un influsso satanico nel mondo odierno.
Ma ritorniamo all’attributo divino dell’immutabilità e poniamo la questione se è possibile all’uomo figlio di Dio imitare in qualche modo questo attributo del suo Padre celeste. Ci sembra che si dovrebbe dare una risposta negativa alla nostra questione. La mutabilità appartiene all’essenza stessa della creatura, come dunque si potrebbe imitare l’Immutabile? “Ogni carne è come erba e tutta la sua gloria è come fiore del campo. Secca l’erba, appassisce il fiore... Ma la parola del nostro Dio sussiste in eterno” (Is 40, 6.8). Quindi, una opposizione irriducibile? Noi siamo difatti in un continuo cambiamento: cambiano le nostre disposizioni, le nostre occupazioni, le nostre esperienze, le nostre decisioni e risoluzioni, siamo soggetti a un processo continuo di invecchiamento. Come possiamo noi imitare l’Immutabile e l’Eterno?
Ma se è vero che Dio è il nostro Padre, deve esistere una possibilità per noi di imitarlo anche in questo. Infatti la Santa Scrittura ci mostra l’esistenza di una tale possibilità. Apriamo il Salterio. In prima pagina troveremo la duplice immagine del giusto e dei malvagi. Il giusto viene caratterizzato appunto in opposizione alla mutabilità che lo circonda. Lui è stabile: “nella legge di Jahvé è il suo diletto e nella sua legge si addestra di giorno e di notte. E sarà come albero piantato su rivi d’acque, che il suo frutto dà a suo tempo e la sua fronda non cade; e questo lo porta a successo” (Sal 1, 2-3). L’albero ha una radice che lo tiene saldo contro tutti i venti, una radice che attinge le acque nascoste. Così il giusto vive in contatto con Dio, radicato in Dio, mentre i malvagi non trovano nessuna stabilità: “non così gli empi, no! Perché anzi saranno come pula che il vento sospinge” (Sal 1, 4). La pula è leggera, secca, infruttuosa, sempre in superficie, sempre in movimento senza scopo, inutile. Vediamo dunque che è possibile l’imitazione anche di questo attributo divino – dell’immutabilità.
10. Immutabilità (II) [9]
Progrediamo oggi, carissimi Confratelli, nella nostra meditazione su Dio e i suoi attributi. Per i figli di Dio è una cosa utilissima e anche gradevole pensare al loro Padre celeste e trovare la loro gioia nell’ammirazione delle sue infinite perfezioni. Abbiamo parlato l’altra volta dell’immutabilità di Dio e abbiamo posto il problema della possibilità per una creatura essenzialmente mutabile di imitare questo attributo di Dio. A prima vista questo pare essere totalmente impossibile, ma sull’esempio del giusto presentatoci dal Salmo 1 abbiamo visto che questa impossibilità non è totale, che l’uomo può con la grazia del Signore imitare in una certa maniera anche l’immutabilità di Dio, suo Padre.
Nei nostri tempi un artificio diabolico certamente assai pernicioso consiste nel presentare all’uomo come un segno di vitalità superiore l’assenza di ogni regolamento di vita. L’uomo deve essere spontaneo, deve rispondere liberamente e con spontaneità alle situazioni, agli impulsi che cambiano ogni giorno, anzi ogni momento. Una pneumatologia moderna vede in questa spontaneità sempre nuova, libera da ogni regola e da ogni prescrizione, un segno caratteristico dell’azione dello Spirito Santo. Nella luce di questa dottrina l’obbedienza a una regola di vita appare pressappoco come un peccato contro lo Spirito Santo. Invece, la teologa dei santi vedeva nell’obbedienza di un religioso un segno della presenza e dell’azione dello Spirito Santo. Questa apoteosi moderna dello spontaneo conduce direttamente a un indebolimento della volontà, rendendola incapace di vincere se stessa in nulla, né di sottomettersi a lunga scadenza a nessun obbligo. Perciò ho detto che un artificio diabolico si trova all’origine della diffusione di una tale dottrina.
Se si toglie dalla vita umana ogni elemento di stabilità come il dovere, il precetto, una regola di vita, i voti, i propositi, un determinato scopo da raggiungere, la virtù, ecc…, l’uomo è totalmente lasciato alle sue fantasie e ai suoi impulsi. Un tale individuo umano diventa un balocco del diavolo. La pseudo-libertà di un tale uomo è in realtà una schiavitù delle sue tendenze più basse. La Santa Scrittura ci mostra sempre l’instabilità in relazione con la malvagità. Il Salmo 1 paragona i malvagi alla “pula che il vento sospinge”. Il Profeta Isaia ha una bella e molto impressionante immagine nel capitolo 57, 20-21, che mostra l’instabilità e la continua inquietezza dei malvagi: “Gli empi sono come un mare agitato che non può trovar pace, e le cui acque travolgono melma e fango. Non ci sarà pace per gli empi, dice il mio Dio”. Il Signore Gesù nel Vangelo ci mostra il diavolo come essenzialmente instabile e inquieto: “Lo spirito immondo vaga per luoghi aridi in cerca di riposo, e non lo trova” (Mt 12, 43). L’Angelo ribelle ha voluto fare la propria volontà, non ha voluto sottomettersi, non ha voluto accettare la volontà di Dio. È dunque caduto fuori dall’unico luogo di pace degli spiriti creati – il seno di Dio. Adesso e per tutta l’eternità sarà vagante per luoghi aridi in cerca di riposo e non lo troverà mai.
Vediamo – carissimi Fratelli – come è pericoloso per uno spirito angelico o umano non cercare la stabilità che si trova nella sottomissione alla volontà di Dio, ma preferire di seguire la spontaneità dei propri desideri in continua mutazione. L’uomo deve dunque cercare non l’instabilità ma la stabilizzazione in Dio. In questo senso possiamo anche capire le celebri parole di Sant’Agostino : “inquietum est cor nostrum donac requiescat in Te”. Soltanto nel seno di Dio gli spiriti trovano la loro pace e la loro fermezza eterna. Una delle intenzioni principali di San Benedetto, quando scriveva la Sua Regola, era di stabilizzare i monaci. Egli conosceva il suo tempo e osservava il monachesimo contemporaneo. Ha notato il gran pericolo spirituale dei piccoli gruppi di monaci dove ciascuno seguiva il suo piacere, ha notato i monaci girovaghi che si trovavano in uno stato di continuo cambiamento e viaggio. Vedeva tutto questo e ha capito che il monachesimo di quel tempo aveva un grandissimo bisogno di stabilità. Nella sua Regola, dunque, la stabilità è stata garantita per l’introduzione di un voto speciale, proprio al nostro Ordine. San Benedetto ama molto la stabilità, la costanza, la perseveranza, la fermezza del carattere, e desidera che i suoi monaci siano uomini stabili, sui quali Dio, la Chiesa e il monastero possano contare. Lui stesso era un uomo tale che poteva essere d’appoggio per gli altri.
Spesso i giovani che cominciano la loro vita monastica o eremitica incontrano come una delle prime grandi tentazioni, la tentazione di cambiare. Certo, vogliono servire Dio, non hanno l’intenzione di ritrarre la loro donazione a Dio, né il loro proposito di consacrare tutta la loro vita al suo servizio. Ma un pensiero ostinato viene come un ritornello: “Non è qui il tuo posto tu hai sbagliato strada, certamente ti sentiresti meglio e saresti più santo dai Carmelitani Scalzi, o dai Cappuccini, o dai Certosini, ecc…”. È una tentazione assai frequente e pericolosa perché può far di un buon giovane religioso un uomo traviato. Talvolta accade che un cambiamento di Ordine religioso sia inspirato da Dio, ma nella grandissima maggioranza dei casi è una tentazione che ordinariamente rivela un’immaturità della fede che non arriva ancora a radicarsi in Dio. Nella pratica della soluzione di simili casi è certo che “praesumptio stat pro stabilitate”. Il diavolo teme la costanza e spesso preferisce suggerire un ideale anche più alto per indurre a cambiare. Lui è sempre il maestro dell’instabilità. Perciò è giusto, è sapiente il consiglio del vecchio abate Nesteros, nella 14 conferenza di Cassiano, che dice: “se fai qualche cosa di buono non lasciarlo per un’altra cosa migliore, perché non c’è niente di migliore alla perseveranza nel bene”.
Non la spontaneità ma la costanza, la fermezza, la perseveranza, la fedeltà, il senso del dovere…, sono segni di una vera maturità spirituale. A questo atteggiamento morale non si arriva subito. E certamente non si arriva con una predilezione per l’elemento cambiante e variabile della vita. Di questa maturità San Paolo ci parla nell’Epistola agli Efesini dicendo: “Finché perveniamo tutti all’unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, a formare l’uomo maturo, al livello della statura che attua la pienezza del Cristo. Così non saremo più bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, alla mercé dell’inganno degli uomini” (Ef 4, 13-14).
Uno dei più grandi successi del diavolo nei nostri tempi è certamente il crollo della virtù di fedeltà tra i cristiani. Questo proviene in linea retta dall’incostanza e dall’instabilità insegnate dal diavolo alla nostra generazione. Molto nella Chiesa si basa sulla fedeltà a un impegno preso davanti a Dio e alla stessa Chiesa. E che cosa vediamo oggi? Dov’è la fedeltà matrimoniale? Quanti sacerdoti, religiosi e religiose non hanno saputo perseverare nelle obbligazioni prese? Questo è divenuto un fenomeno massiccio. Cristo ha detto nel Vangelo di San Luca: “Chiunque guarda indietro mentre mette mano all’aratro è inadatto per il Regno di Dio” (Lc 9, 62). Cristo insegna dunque che l’uomo è e deve essere capace di obbligarsi per tutta la vita, deve poter mettere mano all’aratro e senza guardare indietro andare fino alla fine della zolla. Molti cristiani di oggi invece, anche sacerdoti e religiosi, pensano che questo sia impossibile, che si deve sempre lasciare all’uomo una possibilità di cambiare. Povero nostro mondo!
Certo, l’uomo non sarà mai immutabile e immobile come Dio. Neppure il Signore Gesù come uomo era immutabile come Dio. Ma c’è un’immutabilità nell’Uomo Cristo che il cristiano può e deve imitare. Come il Verbo eterno sta (pros), cioè verso il Padre, così il Cristo Uomo è tutto verso il Padre. Questo atteggiamento di base non cambia mai, non indebolisce mai, non perde mai la sua intensità e niente può disturbarlo. Così dovrebbero essere nei figli adottivi di Dio la risposta all’immutabilità del suo amore e l’imitazione di essa. Dio è assolutamente immutabile, ogni uomo invece, e anche tutta la Chiesa di Dio, è come una nave sui flutti. Può essere anche fortemente agitata dalle ondate e dall’uragano, ma se un’àncora la tiene non sarà rapita dai flutti e sfracellata sulle rocce. Così il cristiano deve essere ancorato nell’abisso di Dio per la fede e la fiducia. Nonostante dunque la nostra grandissima debolezza, siccome siamo polvere, crediamo che Dio voglia darci la fermezza del pensiero e la potenza dell’amore, affinché possiamo essere fedeli a Lui in mezzo a questo mondo pieno di forze ostili. La teologia tradizionale, e specialmente San Tommaso, insegna il gran valore dei voti religiosi perché confermano la volontà nel bene. Lo stesso scopo hanno anche le regole e le costituzioni. Non sono fatte per complicare la nostra vita, né per far di noi degli automi, ma per dar un appoggio alla nostra volontà, per consolidarla nel bene, come dice San Benedetto: “si quid paululum restrictus, dictante aequitatis ratione ad emendationem vitiorum vel coservationem caritatis processerit. Amen.”
11. La pazienza di Dio [10]
Abbiamo parlato l’ultima volta dell’immutabilità di Dio considerando la possibilità per noi uomini di imitare questo attributo del nostro Padre. Abbiamo visto che, nonostante la variabilità essenziale alla creatura, una certa imitazione dell’immutabilità di Dio è possibile, però soltanto per viam unionis cum Deo. Soltanto in Dio, come ancorato in Dio, lo spirito umano trova questa forza stabile e pacifica che lo alza sopra le ondate della vita e del mondo. L’immutabilità appartiene agli attributi di Dio, ai quali la riflessione filosofica può giungere. L’intelligenza umana è capace di conoscere non solamente l’esistenza di un Dio Creatore, ma anche fino a un certo grado la Sua Essenza. La riflessione intellettuale, libera dalle tenebre del sensualismo moderno, è capace di conoscere l’onnipotenza, la sapienza, l’eternità, l’infinità, ecc., di Dio. Questa capacità radicale dell’intelletto umano di conoscere Dio costituisce un dogma della Chiesa cattolica, definito dal Concilio Ecumenico Vaticano I.
San Paolo nella Lettera ai Romani scrive: “Perché ciò che di Dio si può conoscere è palese in essi, avendoglielo Iddio stesso manifestato. Sì, gli attributi invisibili di Lui, l’eterna sua potenza e la sua divinità, fin dalla creazione del mondo si possono intuire, con l’applicazione della mente, attraverso le sue opere. Costoro sono dunque senza scusa” (Rm 1, 19-20). Ma ci sono altri attributi di Dio a cui la filosofia umana è incapace di giungere. Quelli sono come dei lineamenti del volto di Dio della Rivelazione, come tratti del suo carattere. La pazienza appartiene a questi attributi. La conosciamo dalla Santa Scrittura. Tutta la storia santa, la storia dei rapporti di Dio con l’uomo, costituisce una affascinante rivelazione di questo tratto caratteristico del nostro Padre Celeste. La pazienza di Dio si è impressa in una maniera indelebile nell’esperienza e nella memoria del Popolo di Dio e nell’esperienza personale di ogni vero cristiano.
Nel Nuovo Testamento ci sono due parole che esprimono l’idea di pazienza: (1) makrothumía – pazienza, longanimità: questo concetto di makrothymía può essere applicato a Dio stesso nei suoi rapporti con le creature; (2) hypomoné – pazienza, perseveranza, virtù di quello che soffre: e quindi non si può applicare questo concetto a Dio, ma soltanto all’uomo e al Cristo. Il grande Salmo storico 77 presenta tutta la storia di Israele sotto l’aspetto della straordinaria pazienza con la quale Iddio fedele e misericordioso sopportava le infedeltà e la durezza di cuore del suo popolo: “generazione ostinata e ribelle, generazione di cuore incostante, e di spirito non fedele a Dio” (Sal 77, 8); “Non custodirono l’Alleanza di Dio e rifiutarono di camminare nella sua legge. E dimenticarono le Sue imprese/ e le Sue meraviglie che mostrò loro/ Al cospetto dei loro padri fece prodigi,/ in terra d’Egitto compagnia di Ioan./ Divise il mare e li fece passare,/ e rizzò le acque come una diga./ E li condusse colla nube di giorno/ e ogni notte colla luce di foco./ Le rupi spaccò nel deserto,/ e li abbeverò come il grande abisso./ E fece uscire rivi della roccia,/ corsero a torrenti le acque./ E tornarono ancora a peccare contro di lui/ ribellandosi all’Altissimo nel deserto./ E tentarono Dio nei loro cuori” (Sal 77, 10-18).
Il Salmista ci mostra la provvidenza del Signore, sempre piena di tenerezza e di misericordia per il suo popolo, e dall’altra parte vediamo la durezza di cuore, l’infedeltà e una singola prontezza a dimenticare gli innumerevoli benefici ricevuti. Purtroppo questa è una vera immagine dell’uomo, di noi tutti nel nostro atteggiamento dinanzi a Dio. Considerando la straordinaria, l’ineffabile delicatezza dell’amore di Dio, si vede che l’uomo è uno zotico, un cafone grossolano e rozzo nei suoi rapporti col Signore. La grazia di Dio che deve trasformare questo zotico in un figlio di Dio, pieno di una squisita delicatezza nel suo amore filiale, ha un lavoro grandissimo da eseguire, un vero miracolo che non sarebbe possibile senza l’ammirevole pazienza dell’Amore divino.
Questa pazienza di Dio si manifesta in questo, che Dio preferisce vedere la sua infinita Maestà offesa, che respingere l’uomo. Qui è il Mistero della pazienza divina inaccessibile alla filosofia naturale. Questo profondissimo mistero della Maestà di Dio, oltraggiata e sopportante l’oltraggio per non distruggere l’uomo, si è rivelata in Cristo. Lo vediamo nella stupenda visione di Isaia: “Il Signore Jahvé mi ha aperto l’orecchio/ e io non mi sono opposto,/ non mi sono ritirato./ Ho consegnato il dorso ai flagellatori,/ la guancia ai depilatori,/ non ho nascosto la faccia/ agli oltraggi e allo sputo” (Is 50, 5-6). Dio, Creatore dell’uomo, lo conosce fino al fondo, conosce la sua estrema debolezza, la sua forte inclinazione al peccato. Il suo atteggiamento verso la creatura umana è quindi un atteggiamento di misericordia e pazienza. Come vediamo nella storia dei Niniviti, anche le altre nazioni erano oggetto di questa misericordiosa pazienza di Dio.
Tutta la Storia umana è la storia della pazienza misericordiosa di Dio, sempre di nuovo provocata dall’uomo e sempre di nuovo vittoriosa dell’uomo. E chi tra di noi non può ritrovare nella storia d’Israele la storia della sua propria anima? Chi non può applicare a se stesso i seguenti versi dal citato Salmo 77: “E il loro cuore non era costante con lui/ e non erano fedeli alla sua alleanza./ Ma Egli, pietoso, cancellava la colpa/ e non distruggeva./ E continuava a richiamare la sua ira/ e non suscitava tutto il suo furore./ E ripensava che essi erano carne,/ spirito che va e non torna” (Sal 77, 37-39). San Paolo nel terzo capitolo della sua Lettera ai Romani considera tutto il tempo che ha preceduto la venuta di Cristo come il tempo della pazienza di Dio (cf. 3, 25-26). Non c’era ancora il Sangue divino per lavare le colpe degli uomini. Dio le sopportava quasi con una paziente tolleranza (anoché).
La pazienza e la longanimità sono le virtù del pedagogo. Lui sa che nel processo educativo non si può contare su risultati immediati. Anche un buon allievo ha bisogno di tempo e di pazienza per arrivare a un risultato di valore. Un buon pedagogo lo circonda di bontà e di pazienza, incoraggiandolo a progredire con perseveranza. Così agisce Dio secondo la Sapienza del Siracide: “Il numero dei giorni dell’uomo/ al massimo può arrivare a cent’anni,/ goccia d’acqua del mare e granello di sabbia,/ così pochi quegli anni nel giorno dell’eternità!/ Per questo il Signore è longanime con loro/ e versa su di essi la sua misericordia./ Egli vede e conosce bene che la loro sorte è deprecabile/ e per questo abbonda nel perdono./ La compassione dell’uomo va al suo vicino;/ la compassione del Signore va a ogni creatura;/ riprende, istruisce, ammaestra,/ riconduce come pastore il gregge./ Ha Misericordia di chi riceve l’educazione/ e di chi si preoccupa dei suoi giudizi” (Sir 18, 8-14).
Gesù Cristo stesso parla di questa pazienza pedagogica di Dio nel Vangelo. Una parabola evangelica è consacrata specialmente a questo tema. Parlando della necessità per gli uomini di convertirsi, Gesù mostra Dio come aspettante pazientemente questa conversione. Dio sa aspettare, e la ragione di questa aspettativa divina è sempre la Misericordia. “Diceva questa sua parabola: Un tale aveva un fico piantato nella sua vigna e venne a cercarvi frutto, ma non ne trovò. Disse allora al vignaiolo: Ecco da tre anni vengo a cercar frutto su questo fico e non ve ne trovo; taglialo, a che scopo rendere infruttuoso il terreno? Ma quegli gli rispose: Padrone, lascialo ancora quest’anno, fin tanto che io zappi attorno ad esso e metta letame; se in avvenire farà frutto, bene; se no lo taglierai” (Lc 13, 6-9).
Il Creatore fa alle sue creature il dono del tempo. Tutto ciò che vive ha bisogno del tempo per svilupparsi e arrivare alla maturità. Anche un albero buono, piantato su corsi d’acqua, “dà il suo frutto a suo tempo.” (Sal 1, 3). Il tempo ha dunque per lo sviluppo dell’uomo un’importanza primordiale. Il Signore ci fa il dono del tempo, ci aiuta con le grazie necessarie e aspetta il frutto non subito, ma “in tempore suo”. È per noi una cosa di grandissima importanza ben capire l’importanza del tempo e di pensare a colui, grande Paziente, che ci guarda e ci aspetta con amore. Dio non si affretta, non ha permesso ai mietitori di strappare la zizzania prima della mietitura, ma ha lasciato crescere tutto fino alla messe.
Il debitore insolvibile della parabola di Matteo 18 “si gettò ai piedi del re e gli si prostrava dicendo: Signore sii paziente con me e ti restituirò tutto” (18, 26). Che cosa chiede se non il tempo per poter restituire la somma dovuta? Lui non pensa che il suo debito verso il Re è tale che nessun tempo basterebbe per poterlo restituire. Tutta la nostra vita è un grido verso Dio: “Abbi pazienza Signore”, ma nessun tempo può bastare per la restituzione del mio debito, se Tu non mi aiuti. Il compagno di servizio di questo servo cattivo chiedeva anche il tempo per poter rimborsare i cento denari che doveva. Per lui il dono del tempo sarebbe stato decisivo…
Quando abbiamo la tentazione di giudicare severamente i nostri fratelli perché non sono tali come secondo il nostro parere dovrebbero essere, pensiamo che questo fratello si getta ai nostri piedi e grida: “Sii paziente con me e restituirò!” Perché non vogliamo dare al nostro fratello il tempo del quale tutti abbiamo bisogno per cambiare, per convertirci, per correggerci? Dio dà il tempo a tutti, anche noi lo riceviamo e approfittiamo di questo dono veramente necessario per noi. Ma ai nostri fratelli spesso non vogliamo concederlo. Essi devono correggersi subito, perché questo esigiamo noi. L’ortolano ha la pazienza: lui contempla il lento e misterioso sviluppo delle piante e sa di non poterlo accelerare. L’agricoltore sa che non avrà il grano nell’aprile, anche se ci fosse una urgente necessità. Lui sa bene che in questa stagione non serve a niente uscire nel campo col falcetto. Ma per le leggi dalle quali dipende l’evoluzione dello Spirito e della persona umana spesso manca la comprensione. Ma questa pazienza e questa longanimità ti è necessaria anche per sopportare te stesso, il tuo proprio misterioso sviluppo che tu non capisci, la realtà nella quale tu non sei come vorresti essere. La saggezza dell’uomo è nel sentire il gran mistero della vita, della vita propria e della vita altrui, della vita di tutti i viventi, ma specialmente del Mistero delle operazioni della vita divina nelle anime. La consapevolezza di essere sempre in contatto con questo abissale mistero fa l’uomo umile, delicato e paziente.
12. La pazienza (hypomoné)[11]
L’ultima volta abbiamo considerato la pazienza di Dio, la Sua makrothymià, nel suo rapporto alle creature, e specialmente la sua lentezza a punire i peccanti. Dio dà ai peccatori il preziosissimo dono del tempo affinché abbiano la possibilità di correggersi. San Paolo nella Lettera ai Romani ammonisce gli Ebrei a non abusare di questa pazienza di Dio: “Pensi tu (…) di poter sfuggire al giudizio di Dio? Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza, della sua longanimità, non comprendendo che questa bontà di Dio ti spinge solo al pentimento” (Rm 2, 3-4). Ciascuno di noi deve pensare con grande serietà a questo, che Dio aspetta la nostra conversione, aspetta con una bontà paziente e longanime. S. Paolo insiste dicendo che questa paziente bontà di Dio ci spinge al pentimento. Essa ci spinge anche a usare di una simile longanime e misericordiosa pazienza verso gli altri.
L’Uomo approva Dio quando usa una tale pazienza verso lui stesso, anzi pensa facilmente che questo sia a lui dovuto, ma talvolta sopporta difficilmente la pazienza di Dio verso gli altri, specialmente se sono grandi peccatori. Nei tempi di grandi calamità si vedevano anche credenti sollevarsi contro Dio dicendo: “Come è possibile questo? Dio non vede? Dio non sa? O forse Dio non esiste?” Questo si sentiva per esempio durante l’ultima guerra mondiale: “Come Dio può permettere a un criminale come Hitler con una banda di mascalzoni di opprimere così tanti buoni e innocenti?!” Un mio cugino, che fu ufficiale nell’esercito durante la guerra, mi ha raccontato che ha preso parte alla grande offensiva dell’armata rossa contro la Germania. Tra le operazioni il suo distaccamento è stato accerchiato insieme con un reparto sovietico dalle truppe tedesche. In quel momento i soldati russi hanno preso delle medaglie di Santi e hanno cominciato a pregare. Uno tra di loro si è inginocchiato e alzando le mani al cielo gridava ad alta voce: “Dio dove sei! Tu non vedi che cosa si fa in Russia. Fino a quando vuoi tacere!” Qui è il mistero della pazienza di Dio, mistero che l’uomo non può capire, che deve sopportare con fiducia e speranza. E qui arriviamo all’altro aspetto della pazienza, cioè alla hypomoné.
Abbiamo detto che dei due termini biblici esprimenti l’idea di pazienza soltanto il termine makrothymía può essere applicato a Dio, perché esprime l’idea di longanimità senza racchiudere l’idea della sofferenza nel sopportare. Invece la hypomoné racchiude questa idea: questa era la virtù dei “poveri di Jahvé” nel Vecchio Testamento, quei poveri di Jahvé che appartenevano alle classi umili della società, uomini senza influsso, senza importanza, uomini calpestati dalle bufere della storia, poveri e sofferenti, ma uomini attaccati con tutto il loro cuore a Jahvé, credenti instancabilmente alla sua fedeltà e all’incrollabilità delle sue promesse. L’hypomoné è una pazienza sostenuta da una speranza umile, viva e inflessibile (Sustine Dominum!).
Sentiamo la voce di questa pazienza (hypomoné) nei Salmi, la sentiamo specialmente nelle Lamentazioni di Geremia. Noi non ci rendiamo facilmente conto della grandezza della prova alla quale fu sottomesso il Popolo di Israele: il Tempio di Dio distrutto, la Città Santa Gerusalemme preda delle fiamme, il Popolo cacciato dalla Terra Santa, data dal Signore per sempre, e disperso in mezzo a nazioni pagane. Come capire questo? Come non rompersi in disperazione? Su che cosa ancora appoggiarsi? La Terra Santa era un dono di Dio che aveva promesse di durare sempre. Il Tempio dove Dio abitava, dove gli Israeliti incontravano il Signore e contemplavano nella fede e nel culto il Suo volto, la Città Santa… Tutto questo costituiva per il Popolo di Israele il segno indispensabile della permanenza dell’Alleanza stessa. Come spiritualmente sopportare il crollo di tutto questo senza concludere che l’Alleanza stessa è crollata e perdere ogni fede in Jahvé (cf. Sal 76)? Si deve confessare che la prova fu veramente terribile e sovrumana. Ma appunto qui entra questa umile pazienza, questa hypomoné piena di una speranza, che non capisce niente, ma nondimeno rimane inflessibile in mezzo alla sofferenza e all’umiliazione.
“Tutto ciò ci venne addosso, né ti avevamo dimenticato,/ né avevamo mentito alla tua alleanza./ Non si era voltato indietro il nostro cuore,/ né si erano sviati i nostri passi dal Tuo sentiero./ Eppure ci hai fiaccato in un luogo di sciacalli,/ hai calato su di noi l’ombra della morte./ Se avessimo scordato il nome del nostro Dio,/ se avessimo steso le palme a un Dio straniero (...)/ Ebbene, per Te, siamo trafitti senza posa;/ siamo stimati come gregge da macello./ Svegliati, perché dormi, o Signore?/ Risvegliati e non respingerci per sempre./ Perché nascondi il Tuo volto,/ dimentichi le nostre miserie e le nostre oppressioni?/ Perché è china fino alla polvere la nostra anima,/ striscia per terra il nostro ventre./ Sorgi e soccorrici/ e salvaci per la Tua bontà” (Sal 43, 18-21.23-27).
Tutto può crollare, ma la fedeltà del Signore non può crollare. Tutto può perire, le esigenze della vita possono strapparci tutto, ma l’Alleanza mai! Questo è il fondamento saldo che ci rimarrà sempre indipendentemente da tutte le sofferenze, le umiliazioni e le rinunzie che dovremo subire in questo mondo. Questa pazienza cristiana, pazienza dei Santi, costituisce uno dei temi principali del Libro di Apocalisse di Giovanni: “Hic patientia sanctorum est, qui custodiunt mandata Dei et fideum Jesu” (Qui è la perseveranza dei Santi, i quali osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù) (Ap 14, 12). Secondo la Sacra Scrittura la fedeltà all’Alleanza con Dio è una cosa difficile in questo mondo. Un vero fedele è un vincitore, perché non si può essere veramente fedeli senza vincere. Ma è Dio che dà la vittoria a una fiducia che non si lascia abbattere.
Questa dottrina sull’hypomoné ha il suo posto d’onore nella Regola di San Benedetto. L’atteggiamento che lui descrive nel quarto grado di umiltà è propriamente quello della biblica hypomoné: “Il quarto grado di umiltà consiste in questo, che nella stessa obbedienza in cose difficili e ripugnanti, e perfino in qualsiasi ingiuria ricevuta, abbracci la pazienza con coscienza tranquilla e nel sopportare non si stanchi né venga meno, dicendo la Scrittura: Chi avrà perseverato fino alla fine, questi sarà salvo. Ed anche: Stia forte il tuo cuore e attendi il Signore. E per mostrare che il servo fedele deve per il Signore tollerare ogni cosa, dice nella persona di quelli che soffrono: Per amor tuo siamo tutto il giorno tormentati a morte, siamo ritenuti come pecore da macello” (cap. VII). E ecco anche la fiducia inseparabile della hypomoné: “E fiduciosi nella speranza della retribuzione divina, con gioia proseguono a dire: Ma in tutta questa cosa noi siamo vincitori per Colui che ci ha amati” (ivi). S. Benedetto prosegue insegnando che tutto questo si può sopportare se lo spirito prende, conformemente alla dottrina del Vangelo, un atteggiamento massimalistico: “Ma adempiono pure il precetto del Signore, con la pazienza nelle avversità e nelle ingiurie, coloro che, percossi in una guancia, porgono anche l’altra; a chi toglie loro la veste, lasciano anche il mantello; forzati di andare per un miglio vanno per due; con San Paolo Apostolo sopportano i falsi fratelli e benedicono quelli che li maledicono” (ivi). Il principio è chiaro: il fedele deve, per il Signore, poter sopportare tutto. Questa esigenza così radiale, così estrema, non fu escogitata dal Santo Padre nostro Benedetto, ma viene direttamente dalla Sacra Scrittura. C’è qualche cosa di profondamente cristiano e di cristiforme nel sopportare.
La pazienza di Dio si è rivelata nella pazienza del Figlio Suo, il quale prendendo la nostra natura umana acquistò la capacità di soffrire fino alla morte stessa che non Gli fu risparmiata. Così Egli rivelò in se stesso non solamente la makrothymía del Padre, ma fu anche l’esempio perfetto della hypomoné tra le sue sofferenze. Egli ha riscattato il mondo sopportando tutta la malvagità e la brutalità del mondo. Da questo momento sopportare è divenuto il programma dell’uomo su questa terra. È certo che ciascuno di noi ha molto da sopportare e che la pazienza è una virtù molto pratica in questo mondo. Non è una virtù dei giovani, perché generalmente i giovani non sanno aspettare e vogliono avere subito ciò che desiderano avere. Perciò non diciamo che la pazienza è una virtù caratteristica dei vecchi. Anzi ci sono non pochi vecchi impazienti, che non sono capaci di sopportare con umiltà e mansuetudine anche delle piccole contrarietà che disturbano le loro abitudini. Ma è certo che la pazienza, con la perseveranza la quale ne costituisce una forma, è una virtù cristiana fondamentale. S. Giacomo ne fa un brillante elogio nella sua lettera: “Perfetta gioia riputate, fratelli miei, l’imbattervi in prove d’ogni genere, ben sapendo che ciò che mette alla prova la vostra fede produce pazienza, e la pazienza perseverante conduce l’opera alla perfezione, affinché siate perfetti e completi, di nulla mancanti” (Gc 2, 2-4).
San Tommaso insegna che la pazienza costituisce l’atto principale della virtù di forza, siccome abbiamo bisogno di più forza per sopportare il male che ci aggredisce, specialmente se la situazione è durevole, che non di essere noi stessi la parte attaccante (principalior actus fortitudinis est sustinere quam aggredi). Per la pratica della virtù di pazienza amavo attirare l’attenzione dei giovani monaci sull’insegnamento molto pratico di San Benedetto nella Sua Regola. Penso al sesto grado dell’umiltà, che ci propone l’esercizio di un atteggiamento ascetico molto pratico. S. Benedetto dice: “Il sesto gradino dell’umiltà è che il monaco sia contento di ogni cosa vile e spregevole, e per tutte le cose che gli sono comandate si giudichi un inetto e indegno operaio, ripetendo a se stesso col Profeta: Mi sono ridotto al niente e non ho capito nulla; sono diventato come un bruto dinanzi a Te, ma sono rimasto sempre con Te” (cap. VII). Questa gioiosa contentezza di tutto ciò che ci accade di penoso è una via alla santa hypomoné di Cristo.
13. La prova [12]
Nell’ultima nostra conferenza che ebbe luogo a San Lorenzo, ispirandoci a questo santo martire e al martirio abbiamo meditato sul mistero della prova alla quale deve sottomettersi ogni uomo in questo mondo. Meditando su questo importantissimo problema della vita cristiana abbiamo interrogato la Sapienza del Siracide che ne parla nel capitolo secondo. Però con la nostra meditazione non abbiamo esaurito la grande ricchezza di questo capitolo 2. Oggi, dunque, continueremo la nostra meditazione su questo ammirevole capitolo 2. Ecco ciò che dice: Figlio, se ti accosti al servizio del Signore,/ disponi la tua anima alla prova./ Abbi un cuore retto, sii costante/ e non turbarti sotto la prova./ Tieniti unito a Lui intimamente e non separartene,/ perché tu ne resti avvantaggiato in seguito (Sir 2, 1-3).
Questi versetti li abbiamo già meditati. Poi segue: Ricevi quanto ti invierà/ e sii longanime nelle vicissitudini/ delle tue afflizioni (Sir 2, 4). È certamente cosa importantissima ricevere tutto ciò che Dio ci invia, secondo le meravigliose parole di Giobbe: “Se abbiamo ricevuto dal Signore il bene perché non riceveremo da Lui anche il male?” (Gb 2, 10). Ma per essere capace di far questo l’uomo deve avere la fede che tutto ciò che a lui accade viene realmente da Dio come un dono del suo infinito Amore. Senza una tale semplicità della fede non è possibile sopportare le grandi prove. La certezza soprannaturale che tutto ci viene dal Padre che ci ama, ci dà la pace, e allora diviene possibile ciò che dice il Siracide : “Sii longanime nelle vicissitudini delle tue afflizioni.”
Sì, adesso si può essere longanimi, si può tranquillamente aspettare, perché si sa che tutto ha un senso, che tutto è pieno di amore e di bontà divina: “Ricevi quanto ci invierà/ sii longanime”. Come è bello questo atteggiamento che sa sempre trovare Dio nelle circostanze sempre variabili della vita umana! Gli asceti insistono che non dobbiamo fermarci alle considerazioni delle cause seconde, ma dobbiamo sempre salire alla Causa prima, siccome è sempre direttamente presente poiché l’oro viene provato con il fuoco/ e gli uomini graditi nella fornace dell’umiliazione (Sir 2, 5). L’oro significa un tesoro, un grande valore. Ma l’oro deve essere purificato nel fuoco. Il fuoco è una potenza che distrugge molte sostanze, ma altre invece purifica. Le grandi sofferenze sempre fanno morire, ma da te, dalla tua cooperazione con la grazia dipende se morirai tu stesso o morirà il tuo vecchio uomo per far vivere il nuovo. Durante la guerra si vedeva questo doppio effetto di una grande sofferenza: tra quelli che sono stati imprigionati nei campi di concentramento molti sono usciti migliori, più forti, più umani, più uniti al Cristo. Altri invece sono stati spiritualmente rovinati e spezzati.
Le grandi prove – dice la Sapienza – sono preparate per gli amici di Dio, per uomini che Gli sono graditi. Per loro è preparata “la fornace dell’umiliazione”. Perché la divina Sapienza parla qui di “fornace dell’umiliazione”? Noi forse preferiremmo parlare di una fornace della sofferenza. È un’idea più generale, siccome non ogni sofferenza è umiliazione... Sì, ci può sembrare così, ma il pensiero espresso qui dal Siracide è più profondo e più preciso. Non è la sofferenza come tale che purifica e trasforma l’anima dell’uomo, ma l’umiliazione. L’intenzione di Dio quando ci manda la sofferenza non è di farci soffrire, ma ben di farci raggiungere una profonda umiltà del cuore che è la vera sapienza, è la vera purezza dell’anima. Quindi, in ogni sofferenza c’è l’umiliazione che costituisce l’elemento prezioso, la direzione della grazia che l’uomo deve saper trovare per collaborare a suo modo con la misteriosa pedagogia di Dio. Se non trova la dolcezza dell’umiltà, la sofferenza lo spezzerà.
Affidati a Lui e ti prenderà in tutela,/ segui la retta via e spera in Lui (Sir 2, 6). L’umiliazione dell’uomo è certamente l’intenzione del Padre Celeste quando ci manda il dono della sofferenza, ma non soltanto l’umiliazione. Dio vuole attrarre il cuore dell’uomo a sé. Non vuole Dio lasciare che l’uomo sia solo nella sua sofferenza, ma vuole che lui cerchi il Signore, che si avvicini a Lui, che scopra finalmente il mistero di una fiducia totale. Perché la sofferenza dell’uomo lì rivela la propria debolezza fin al punto di non poter più. Allora l’uomo capisce di essere stato creato per la fiducia, per affidarsi totalmente a Dio. Allora la sua estrema debolezza, la quale per sé dovrebbe portare alla disperazione, non fa più paura, ma piuttosto è sorgente di gioia, secondo le parole di San Paolo: “Libenter gloriabor in infirmitatibus meis, ut inhabitet in me virtus Christi: cum enim infirmor, tunc potens sum” (2 Cor 12, 10).
Affidati a Lui e ti prenderà in tutela,/ segui la retta via e spera in Lui. L’uomo deve semplicemente essere fedele adempiendo i suoi doveri ogni giorno e sperando in Dio. È vero però che la speranza in Dio è una virtù difficile. L’Uomo ama sentire un suolo fermo sotto i suoi piedi. Noi cristiani, che abbiamo la speranza in Dio, praticamente ci appoggiamo su tante cose create che concorrono al nostro benessere spirituale. Abbiamo una salute abbastanza buona, una certa sicurezza economica, molti amici che ci vogliono bene, condizioni di vita sufficienti, nessuno ci perseguita, nessuno ci vuole apertamente male, anche il diavolo ci lascia senza grandi tentazioni. Non è facile per noi immaginarci, vivendo tra tanti appoggi psicologici, che cosa sia appoggiarsi su Dio solo. Forse Dio ci darà una volta l’occasione di praticare questa speranza pura secondo le parole del misterioso “servitore di Jahvé” della Profezia di Isaia: “Chi tra di voi teme Jahvé/ ascolti la voce del suo servitore!/ Chi cammina nelle tenebre,/ senza alcuna luce in sé,/ speri nel nome di Jahvé,/ si appoggi sul suo Dio” (Is 50, 10). “Appoggiarsi sul suo Dio” è dunque un atteggiamento che si verifica in una infinità di gradi. Pochi lo realizzano perfettamente. Dobbiamo spesso esaminare la verità della nostra speranza in Dio.
Nei versetti seguenti il Siracide si rivolge tre volte a quelli che temono Dio: Voi che temete il Signore, aspettate la sua misericordia,/ non venite meno, se non volete cadere./ Voi che temete il Signore, abbiate fiducia in Lui,/ e la vostra ricompensa non verrà meno./ Voi che temete il Signore, sperate cose migliori:/ l’interminabile gioia e la misericordia (Sir 2, 7-9). L’insegnamento sulla prova e sulla maniera di comportarsi nella prova si cambia in un cantico alla fiducia in Dio e alla sua infinita misericordia.
Osservate le generazioni passate e fate attenzione:/ chi si è affidato al Signore e ne è rimasto deluso?/ Chi ha perseverato nel timore di Lui ed è stato abbandonato?/ Chi lo ha invocato ed è stato da Lui ignorato? / Perché il Signore è pietoso e misericordioso; / rimette i peccati e salva in tempo di sventura! (Sir 2, 10). Il timore di Dio che è un amore umile trova la sua piena espressione in una fiducia piena e senza limiti a Dio: Voi che temete il Signore, aspettate la sua misericordia/ Voi che temete il Signore, abbiate fiducia in Lui/ Voi che temete il Signore, sperate cose migliori:/ l’interminabile gioia e la misericordia (Sir 2, 7-9). Il Siracide ci insegna che questa fiducia in Dio deve essere coraggiosa: Guai ai cuori codardi e alla mani inerti! Guai al cuore abbattuto perché non crede: perciò sarà privo di protezione! Guai a voi che avete perduto la pazienza; che farete quando il Signore vi visiterà? Chi teme il Signore non diffida delle sue parole; chi lo ama, ne segue il cammino. Chi teme il Signore, si sforza di piacergli e chi lo ama si sazia della legge. Chi teme il Signore, dispone il cuore e umilia la sua anima innanzi a Lui. Gettiamoci nelle braccia del Signore e non nelle braccia degli uomini, poiché come è la sua grandezza così anche è la sua misericordia (Sir 2, 12-18). Ecco l’ultima raccomandazione indirizzata al servo di Dio duramente provato: “Gettiamoci nelle braccia del Signore, poiché come è la sua grandezza così anche è la sua misericordia”.
Il popolo di Dio nel Vecchio Testamento fu veramente duramente provato nella sua fede e la sua speranza in Jahvé. Dopo le grandi prove nel deserto dove tutto dipendeva dalla fede, sono venute le prove ancora molto più difficili in Palestina. Possiamo difficilmente immedesimarci nella situazione dei credenti Israeliti quando la Città Santa Gerusalemme fu distrutta, il tempio bruciato, il popolo stesso cacciato via dalla Terra Santa e disperso tra i pagani. Tutti i segni esterni dell’Alleanza tra Dio e il popolo sono spariti. Non c’era più nessuna liturgia, nessun contatto sentito con Jahvé. Molti potevano interpretare ciò che era accaduto come una rottura dell’Alleanza, come un abbandono da Dio. Una prova certamente terribile! Quelli che non sono stati spezzati hanno avuto una fede fortissima. Tutti i disastri della storia sono passati sopra di loro, ma loro sono rimasti incrollabili: “Omnia excelsa Tua et fluctus Tui super me transierunt” (Sal 41, 8b). Questi hanno sempre sperato nel Dio fedele. Non hanno mai ammesso che Lui potesse essere infedele alla Sua parola, e così hanno superato la terribile prova della loro vita.
II. Liturgica
1. Nativitas B.V.M. [13]
La nascita di un uomo è una festa per i suoi cognati. Anche obiettivamente è un evento grande, perché l’inizio di ogni uomo suppone un intervento diretto del Creatore, è quindi un avvenimento d’una profonda significazione religiosa. Ma la nascita umana non è santa siccome è macchiata dal peccato. Quello che nasce, che comincia a vivere in questo mondo, è un peccatore allontanato da Dio a causa del peccato originale. È vero, questa vita deve appartenere al Cristo, deve essere rapita da Lui e trasformata in Lui, deve diventare una corsa verso il Padre, sì, ma “hic et nunc” è rivolta dal Signore. Quindi, per un cristiano non la concezione né la nascita, ma il battesimo costituisce la vera festa dell’inizio.
Per San Giovanni Battista la Chiesa celebra la sua nascita credendo alla sua miracolosa purificazione e santificazione nel seno materno, ma non celebra la sua concezione, la quale non differiva da quella degli altri esseri umani. Invece per Maria la Chiesa celebra non soltanto la sua Natività, ma anche la sua Concezione Immacolata, e perfino questa solennità è più importante della festa odierna, giacché significa la totale esenzione di Maria dalla legge comune a tutti i rappresentanti dell’umanità caduta. La Concezione Immacolata è la festa della vittoria totale di Maria sul peccato dell’uomo e su quello che in virtù del peccato esercita un potere tirannico sull’uomo caduto. La festa della Natività appartiene allo stesso mistero dell’inizio della Santissima Madre di Dio e il suo oggetto è l’apparizione in questo mondo dell’Immacolata vincitrice del peccato. La venuta di Maria in questo povero mondo significa l’aurora del gran Mistero di Salvezza. Questa è la ragione della grande gioia di questa festività. Perciò la Chiesa canta oggi alla Madonna: “Nativitas tua, Dei Genitrix Virgo, gaudium annuntiavit universo mundo: ex Te enim ortus est Sol iustitiae, Christus Deus noster: qui solvens maledictionem, dedit benedictionem; et confundens mortem, donavit nolis vitam sempiternam.” (La Tua nascita Vergine Madre di Dio,/ ha annunziato la gioia / al mondo intero: / da Te è nato il Sole di giustizia, / Egli ha tolto la condanna / e ha portato la grazia, / ha vinto la morte /e ci ha dato la vita eterna).
La Santissima Vergine Maria è quella beatissima creatura umana che non ha mai resistito alla grazia di Dio. Non c’è stata nessuna, anche la più tenue e delicata, mozione dello Spirito Santo alla quale Lei non avesse obbedito subito e pienamente. E così lo Spirito Santo, non trovando in Lei nessuna resistenza alla sua azione, ma sempre una perfetta apertura e una docilità senza fallimento, ha potuto trasfomarLa in se stesso. Nel mondo immerso nelle tenebre del peccato Maria fu l’unica altissima cima irradiata dal Sole che cominciava già a sorgere sull’umanità. Lei fu il punto di contatto tra l’immensità di Dio e la piccolezza dell’uomo. Come la colomba di Noè, non potendo trovare su tutta la terra un luogo secco per riposarsi, venne all’Arca di Noè, così lo Spirito di Dio, trovando tutto il mondo immerso nel peccato, venne a Maria: “Spiritus Sanctus superveniet in Te”. Maria fu quindi il punto di incontro dell’uomo con Dio. Noi abbiamo potuto andare incontro a Dio veniente soltanto in Lei. Ma è una causa di fierezza per tutto il genere umano aver potuto andare incontro a Dio in un modo così magnifico.
Se Dio ha voluto incontrarsi con l’umanità in Maria, si può dire che Lei è diventata in un certo senso la forma di questo incontro. Non si deve capire questo nel senso che ogni cristiano non può incontrare Dio nella preghiera direttamente senza prima rivolgersi esplicitamente a Maria, ma che per incontrare Dio si deve in una certa maniera diventare Maria. Più l’anima cristiana rassomiglia a Maria, diventa Maria, tanto più incontra Dio e diviene un vivente incontro con Dio, cioè un tempio vivente del Signore. Se Maria è l’incontro di tutta l’umanità con Dio, ne segue che tutto ciò che riguarda l’unione degli uomini con Dio appartiene in una certa maniera a Lei. L’unione con Dio è la cosa sua. Dove si tratta dell’unione dell’uomo con Dio, Maria è sempre presente. Donde questa meravigliosa appellazione di “Madre della divina grazia”. Come quella che non ha opposto nessuna resistenza all’ispirazione e all’azione dello Spirito Santo, Lei è divenuta quasi la concretizzazione di questa azione, la forma concreta della grazia, modello per tutti e per la Chiesa stessa. In Maria vediamo quali dobbiamo essere e come dobbiamo vivere per ricevere Dio e vivere in unione con Lui.
Ci sono molti Santi nella Chiesa, in essi vediamo l’enorme ricchezza spirituale della Chiesa. Ma tra i Santi possiamo fare una scelta. Non tutti sono a un grado uguale adatti alla nostra spiritualità personale. Alcuno vuole imitare San Francesco da Assisi, per un altro Santa Teresa del Bambino Gesù sarà più adatta all’imitazione. Maria invece è per tutti, Maria è universale, una luce spirituale per tutti, una medicina per tutti, una gioia spirituale per tutti. Nessuno può sottrarsi al suo fascino spirituale, al suo profondo e delicato incanto, al suo odore ineffabile.
La vera storia dell’uomo non consiste nella successione degli eventi che formano la trama esteriore della sua vita. La vera storia dell’uomo è la sua storia spirituale, la storia della sua vita con Dio o lontano da Dio, la storia delle sue fedeltà e delle sue infedeltà, dei suoi congedi dal Signore e dei suoi ritorni a Lui con umiltà e lacrime di contrizione. Questa è la vera storia di ogni cristiano, in sostanza è la Storia dell’Alleanza. Come vediamo nella Sacra Scrittura, la vera storia del Popolo di Dio Israele non tratta degli affari politici, non si ferma alla successione degli eventi esterni, ma si concentra sull’Alleanza e sul problema della fedeltà a questa Alleanza. Ci mostra Dio sempre fedele e ci mostra Israele che talvolta rompe il suo contatto col Signore, abbandona Dio per cercarlo di nuovo e ritrovare la sua infinita e instancabile misericordia. Questa storia di Israele si riproduce in ciascuno di noi. Per ciascuno di noi la cosa essenziale è l’Alleanza; dico la cosa essenziale, perché l’Alleanza con Dio costituisce il senso stesso della nostra vita.
Ma si può dire senza inesattezza che esiste anche una storia Mariana della nostra vita, cioè la storia di questo misterioso incontro personale del cristiano con la Madre di Cristo e Madre sua. Di questa grazia importante e piena di soavità è bene essere consapevoli. Alla devozione verso Maria che tutti abbiamo si deve lasciare una grande libertà nei limiti della fede cattolica. Questa relazione filiale del cristiano con la sua Madre Celeste può avere diverse espressioni e diverse forme. Tutte sono buone e salutari se concordano con la fede e la dottrina della Chiesa. Si propongono diverse forme, ma si deve conservare una grande delicatezza per non voler inquadrare in un sistema ciò che è semplicemente vita di amore e di fiducia filiale.
2. La venuta del Signore [14]
L’Avvento sta finendo e ci avviciniamo alla grande solennità della Nascita del Signore, del Figlio Unigenito di Dio che si è degnato di nascere come Figlio dell’uomo dalla purissima Vergine Maria. Mai potremo capire la profondità di questo mistero del divino Amore. Per poco che vogliamo approfondirlo il nostro spirito si sente oppresso da una luce troppo grande per lui.
Il Prologo del Vangelo di San Giovanni ci rivela l’eterna nascita del Verbo prima di parlarci della sua Incarnazione. All’inizio della Bibbia, il primo versetto del libro Genesi segna l’inizio del tempo, quando tutte le cose cominciarono ad esistere. L’Evangelista San Giovanni va oltre l’affermazione di Genesi. Quando le cose cominciarono ad esistere, il Verbo di cui lui ci parla già era in possesso di un’esistenza senza principio e senza limiti. È il Verbo di Dio, perché Dio in Lui si esprime, in Lui esprime tutto se stesso, tutto ciò che Lui è, tutta la sua infinita Essenza.
Dio è semplice, Lui non si esprime parzialmente, ma si dice tutto in una Parola che procede da Lui eternamente e costituisce la Persona del Figlio. Noi, quando parliamo, esprimiamo qualche cosa del nostro pensiero. Ma anche usando molte parole non possiamo esprimere tutto ciò che pensiamo e tanto meno siamo capaci di esprimere tutto il nostro essere nelle nostre parole. Il Verbo di Dio è dunque il Figlio Unigenito di Dio uguale al Padre.
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio (Gv 1, 1-2). Nel testo greco abbiamo (pròs tòn theòn) che possiamo tradurre come nel testo generalmente annesso e come abbiamo citato: “e il Verbo era presso Dio”; ma possiamo anche capirlo altrimenti. Pròs tòn theòn può essere tradotto anche: “Verso Dio”; “il Verbo era verso Dio”. Il Figlio sta davanti al Padre, rivolto a Lui. Questo suo eterno atteggiamento si esprime anche nella sua Umanità assunta. Tutta la sua vita umana è verso il Padre: il suo cuore, i suoi pensieri, la sua volontà, la sua attività, tutto era sempre verso il Padre. Questa idea si trova nella Lettera agli Ebrei, dove la vita del Cristo è rappresentata come una entrata del sommo sacerdote nel santuario celeste con l’offerta del proprio sangue verso il Padre. L’orientamento essenziale della vita cristiana è anche pròs tòn theòn. Resi figli di Dio per adozione, andiamo o corriamo insieme con Cristo verso il Padre. Questa idea del Figlio di Dio Sommo Sacerdote pròs tòn theòn, verso Dio Padre, era espressa meglio nell’antica forma degli altari liturgici che non erano verso il popolo.
Tutte le cose per mezzo di Lui furono fatte, e senza di Lui nulla fu fatto di ciò che fu fatto (Gv 1, 3). Fonte prima e universale dell’essere il Padre, dandosi totalmente al Figlio, gli comunica anche la sua potenza creatrice creando tutto per mezzo di Lui. Così San Giovanni sottolinea che quello che si è fatto piccolo e debolissimo pargoletto è l’Onnipotente Creatore dell’Universo visibile e invisibile. L’Universo è suo e porta la traccia di Lui.
In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini (Gv 1, 4). Qui parla di quella vita che da principio era in Lui, quella vita che si identifica con Lui: “sicut enim Pater habet vitam in semetipso, ita dedit et Filio habere vitam in semetipso” (Come, infatti, il Padre ha in se stesso la vita, così ha dato al Figlio d’aver la vita in se stesso) (Gv 5, 26). Dice dunque San Giovanni che quella vita che in Lui era, era la luce degli uomini, ciò significa che da principio l’uomo era creato in vista di partecipare a quella vita divina. Meravigliosa rivelazione sull’uomo, sul senso profondo dell’umanità nel pensiero del Creatore. L’uomo fu destinato a partecipare alla vita stessa di Dio, la quale doveva farsi la sua luce, cioè la norma della sua vita e la sua condotta.
Questo stupefacente pensiero si trova confermato nel versetto nono dello stesso Prologo che dice: La Luce vera che illumina ogni uomo stava per venire nel mondo (Gv 1, 9). L’uomo è un essere così divino nel pensiero del suo Creatore, che la sua vita deve ricevere la sua norma dalla vita interna di Dio stesso. Vita Dei erat lux hominum (Gv 1, 4).
e la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno sopraffatta (Gv 1, 5) In questo versetto scendiamo dal cielo sulla terra. La luce di Dio entra in contatto con le tenebre. Questa brevissima frase: “e la luce splende nelle tenebre”, costituisce una potente sintesi di tutta la storia umana. La lotta tra la Luce e le tenebre riempie la storia e la rende così intricata e difficile da capire. Ci sono tante cose terribilmente tenebrose in questo mondo, ma insieme ci sono tanti ambienti lucidi, tante sorgenti di luce vera, di luce eterna. In noi stessi si svolge questa guerra tra la luce e le tenebre. Il Vangelo di San Giovanni ha per tema principale questo drammatico scontro: la Luce di Dio riscontra la resistenza delle Potenze tenebrose, resistenza che si fa di più in più incoercibile. Ma finalmente quando le tenebre sembravano già trionfare è venuta la piena vittoria della Luce – la Risurrezione del Cristo. “e la Luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’ hanno sopraffatta”. Il testo greco accetta una doppia interpretazione: le tenebre non hanno vinto o le tenebre non l’ hanno capito. Ambedue questi sensi si possono giustificare per il testo del Vangelo.
Vi fu un uomo mandato da Dio, e il suo nome era Giovanni. Questi venne come testimone per dar testimonianza alla Luce, affinché tutti credessero per mezzo di Lui (Gv 1, 6-7). Viene la Luce divina in questo mondo e comincia la testimonianza umana. Come è possibile che un uomo dia testimonianza alla Luce divina? Pare veramente impossibile che un uomo abbia un tale incarico. Infatti non c’è nessuna proporzione tra un uomo e la Luce divina. Naturalmente è impossibile per l’uomo diventare un testimone di Dio. Ma l’Evangelista dice: “fu un uomo mandato da Dio... Questi venne come testimone per dar testimonianza alla Luce”. Se non fosse “mandato da Dio” sarebbe totalmente incapace di eseguire un tale incarico. Giovanni Battista fu il primo testimone del Dio Incarnato dinanzi al mondo. Fu il primo, ma non l’ultimo. Da lui comincia la testimonianza che non dovrà più tacere fino alla fine del mondo.
La testimonianza (martyría), idea importantissima nel cristianesimo che nella Chiesa dei primi secoli era molto viva. Poi, nei secoli posteriori non se ne parlava molto. Oggi assistiamo a una vera rinascita di questa idea. Il mondo, ricaduto nel paganesimo e minacciato di sprofondarsi nell’ateismo, ha un urgente bisogno di testimoni. Si ricorda che il Signore prima di lasciare i suoi discepoli disse loro: “eritis mihi testes” (Sarete miei testimoni) (At 1, 8). Non ha detto: “sarete per me teologi, o predicatori…”, ma sarete miei testimoni. I giovani oggi vogliono questo, essi cercano i testimoni di Cristo. Chi può essere testimone di Cristo? Una condizione essenziale per essere testimone di alcuno è di conoscerlo personalmente. Soltanto chi conosce personalmente può essere testimone. Chi conosce Cristo soltanto per mezzo dei libri o per mezzo delle testimonianze altrui non può essere testimone di Cristo. San Paolo doveva incontrare personalmente il Signore per poter essere il suo Testimone e il suo Apostolo. La rinascita odierna di questa importante esigenza cristiana costituisce certamente uno dei segni di un vero rinascimento nel seno della Chiesa. Anche oggi lo sviluppo della Chiesa esige molti testimoni, cioè molti cristiani che conoscono il Signore personalmente. Questo non è una cosa straordinaria, perché ogni cristiano vivente veramente e profondamente la sua fede conosce il Cristo personalmente e può essere suo testimone.
Non era egli la luce ma doveva dare testimonianza alla luce (Gv 1, 8). Giovanni Battista è un modello di testimone. Lui era pieno di Cristo e vuoto di se stesso. Lui guardava soltanto il Cristo, gridava il Cristo, e quando i Giudei vennero e gli domandavano: “Chi se tu”, lui fu meravigliato di questa domanda. Si meravigliava come avessero potuto interessarsi a lui, e nel primo momento non poteva trovare una risposta. E poi ha risposto citando il Profeta Isaia: “io sono la voce di uno che grida nel deserto” (Gv 1, 22-23). Dunque sono niente, perché la voce da sé è niente, la voce è tutta per il Verbo che annunzia gridando. La cosa più pericolosa per un testimone di Cristo è pensare di essere qualche cosa. Il primo testimone è puro di questa passione. Ma non tutti i suoi discepoli furono come lui. Quando vedevano che molti seguivano Gesù e non venivano più al loro maestro, si sono lagnati con Giovanni provocandolo a rendere quella bellissima testimonianza a se stesso, testimonianza di una perfetta trasparenza spirituale: “Giovanni rispose: Nessuno può prendere nulla se non gli è stato dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: non sono io il Messia, ma sono stato mandato innanzi a Lui. Chi ha la sposa è sposo, ma l’amico dello sposo, che l’assiste e l’ascolta, è felice alla voce dello sposo. Questa dunque è la mia gioia, ed è giunta al colmo. Lui deve crescere, io diminuire” (Gv 3, 27-29). Gli Apostoli di Cristo non avevano ancora questa trasparenza, né questa gioia della trasparenza quando domandavano al Signore: “Chi sarà più grande nel Regno dei Cieli?” Essi certamente pensavano ancora di essere qualche cosa. Guardando la Luce, contemplando la Luce e perdendo se stessi si diviene testimoni di Cristo secondo il modello di San Giovanni Battista.
La Luce divina che illumina ogni uomo stava per venire al mondo. Egli era nel mondo, e il mondo per mezzo di Lui fu fatto, e il mondo non lo riconobbe. È venuto nella sua casa e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno ricevuto, ha dato il potere di diventare figli di Dio; a quelli che credono nel Suo Nome, i quali non da sangue, né dal volere della carne, né da volere d’uomo, ma da Dio sono nati. E il Verbo s’è fatto carne ed ha dimorato tra noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria che come Unigenito ha dal Padre, piena di grazia e di verità (Gv 1, 9-14).
3. Natale [15]
All’inizio della Bibbia il primo versetto del libro Genesi segna l’inizio del tempo, quando tutte le cose cominciarono ad esistere; l’Evangelista San Giovanni va oltre l’affermazione di Genesi. Quando le cose cominciarono ad esistere il Verbo di cui lui ci parla già era in possesso di un’esistenza senza principio e senza limiti. In principio era il Verbo,/ e il Verbo era presso Dio,/ e il Verbo era Dio./ Egli era in principio presso Dio.
Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla Luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la Luce ma doveva rendere testimonianza alla Luce (Gv 1, 1.6-8.19.28). Tre domande al Battista: “Chi sei tu?”; “Che cosa dici di te stesso!”; “Perché battezzi?”. Tre domande che hanno risonanza anche in noi. Risposta del Battista alla seconda domanda: “Io sono la voce, parola che invita alla conversione”. “In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete”. Alla terza domanda il Battista risponde che battezza nelle acque del fiume Giordano per invitare le anime convertite a conoscere “uno che viene”, cioè il Messia, di cui si proclama servo indegnissimo (cf. Gv 1, 19-23). E tu, sei testimone di Gesù Luce del mondo?
In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città (Lc 2, 1-3). Un fatto politico dà il via al più grande avvenimento della storia: la nascita del Figlio di Dio a Betlemme. Il popolo Ebreo aveva pregato per secoli: “Oh, se tu squarciassi i cieli e scendessi!” (Is 63, 19). Vieni Signore a liberarci! Nella pienezza dei tempi Dio risponde in modo inaudito a questa lunga attesa: “Sì, Dio ha tanto amato il mondo da donargli il suo Figlio Unigenito” (Gv 3, 16).
Anche Giuseppe che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta (Lc 2, 4-5). Betlemme da “Beth-Lehem” significa “Casa del Pane”. L’Incarnazione è legata all’Eucarestia. Gesù dirà: “Io sono il Pane vivo disceso dal cielo” (Gv 6, 51). Il segno dell’Incarnazione è la povertà totale, lo spazio vuoto per Dio. Il segno dell’Eucarestia è la piccola Ostia, l’umiltà totale.
Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compivano per Lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo Figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro all’albergo (Lc 2, 6-7). Nella nascita di Gesù la Madonna compare in primo piano come Vergine Madre e tuttavia è avvolta di silenzio. Tutte le cose grandi si compiono nel silenzio e nel nascondimento. La Vergine dell’Incarnazione è adoratrice perfetta del Verbo divino, tutta raccolta in Dio nell’interno del suo cuore Immacolato, così bella nella grazia di quella Maternità divina, così soffusa di luce, perché tutta inondata dall’Amore delle Tre Persone divine. La Vergine dà alla luce Gesù, “primogenito” di molti fratelli e sorelle che siamo noi.
C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un Angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento (Lc 2, 8-9). I pastori (in ebraico “am ha ares” = “popolo della terra”) sono gli umili, i disprezzati. E proprio a loro viene dato il primo annuncio di gioia. Echeggia già il piccolo inno di giubilo di Gesù: “Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti (= gli autosufficienti, i superbi) e le hai rivelate ai piccoli!” (Lc 11, 2-5), agli umili. Chi è umile attira in sé Dio e comincia già a vivere il Cielo.
ma l’Angelo disse loro: “Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore” (Lc 2, 10-11). Anche gli Angeli della Risurrezione diranno: “Non temete”. Il termine, il vertice della vita di Gesù è la Risurrezione. Sarà così anche per noi. Ma già adesso inizia la cosiddetta “Risurrezione anticipata”, che coinvolge anche il nostro corpo, ogni volta che noi risorgiamo dal peccato alla Grazia. Il perdono di Dio nella confessione ci rende allora capaci di accogliere il dono divino della gioia. Se Gesù è presente nelle profondità del nostro cuore, sgorga in noi quel grido di gioia che ci permette di attraversare i deserti e i tempi di siccità di questa breve esistenza.
4. La passione del Signore [16]
Sta scritto nel Vangelo di San Luca: Avvenne poi che, compiendosi per Lui il tempo di essere tolto dal mondo, egli fece il viso duro e si diresse verso Gerusalemme (9, 51). Quando si legge il Vangelo, fa certamente impressione una cosa: questo orientamento di tutta la vita di Cristo verso la sua Passione. Come uomo doveva temerla. Per la natura umana la previsione certa delle sofferenze che lo aspettavano era difficile da sopportare. E perciò il testo del Vangelo dice: “Egli fece il viso duro e si diresse verso Gerusalemme”. Là si preparava già l’altare per l’Agnello. “Il mio cibo è di far la volontà di Colui che mi ha inviato, di compiere l’opera di Lui”(Gv 4, 34). Tutta la volontà di Gesù era tesa verso questo momento che Lui chiamava la Sua Ora. La terribile sofferenza, il dolore, la crudelissima morte, l’umiliazione…, tutto questo era quasi niente dinanzi alla volontà del Padre e il compimento del Suo ordine.
Con grande sollecitudine Gesù preparava i suoi discepoli alla comprensione e all’accettazione di questa volontà del Padre, tanto contraria a tutte le loro speranze e aspettative. La sua vita e il suo ministero sulla terra dovevano finire con la più umiliante sconfitta, con un vero disastro. Tutto questo ministero del loro amatissimo Maestro, ministero così glorioso, pieno di miracoli e di manifestazioni dell’Onnipotenza di Dio, doveva finire in una umiliazione la più profonda. L’Uomo di tutte le loro speranze, l’Uomo di Dio, il Salvatore di Israele, quell’Essere straordinario nel quale presentivano la natura divina, doveva essere umiliato e calpestato, doveva essere ridotto a nulla e tutta la sua opera doveva essere ridotta a niente quasi in un istante. L’orgoglio e la brutalità di questo mondo doveva essere per un momento vincitrice su Dio stesso che ha potuto calpestare e schiacciare.
Il Cristo con la sua volontà umana accetta questo e va coraggiosamente dinanzi. Ammiriamo la calma fermezza della sua volontà che non esita né torna indietro, ma abbraccia amorosamente la volontà del Padre. In tutta la vita di Gesù Cristo vediamo questa meravigliosa semplicità che consisteva in questo, che c’era un solo semplicissimo motivo che reggeva tutte le sue azioni, e questo motivo era la volontà del Padre. Se alcuno lo interrogava: “Perché fai questo o quello?” il Signore Gesù poteva sempre dare questa semplice risposta : “Perché così vuole il Padre, perché per questo sono stato mandato…” Questa semplice intenzione di totale obbedienza rende conto di tutte le azioni, tutte le opere di Cristo. Questa semplicità di intenzione, mantenuta con una intransigenza e una fedeltà invincibile, Lo farà finalmente vincitore su questo mondo aggrovigliato nella menzogna.
Una delle numerose lezioni che la Passione di Cristo apporta all’uomo è certamente quella della semplicità: la volontà del Padre e nient’altro. Questo attaccamento alla sola volontà di Dio rende l’uomo limpido e forte, capace di vincere il mondo e il diavolo. Ma è vero che la volontà del Padre rimane sempre un mistero terribilmente sconcertante per l’uomo. È naturale per l’uomo considerare la sua vita come uno sviluppo, di desiderare il successo, di temere l’insuccesso e la sconfitta. Ma questa è appunto la saggezza del mondo che Dio ha voluto distruggere per la predicazione della Croce. San Paolo dice: “Dacché infatti, il mondo non seppe con la sua saggezza conoscere Iddio nelle manifestazioni della sapienza divina, Iddio si compiacque di salvare i credenti mediante la stoltezza della predicazione. E, dato che i Giudei reclamano miracoli e i Greci vanno in cerca di sapienza, noi, all’opposto, predichiamo un Cristo crocefisso, oggetto di scandalo per i Giudei e follia per i pagani, ma per quelli che sono chiamati, siano essi Giudei o Greci, un Cristo che è potenza di Dio e sapienza di Dio. Poiché la follia di Dio è più sapiente degli uomini, e la debolezza di Dio è più forte degli uomini” (1 Cor 1, 21-25).
Per noi tutti la salvezza è nella Croce di Cristo. Ma la Croce di Cristo reclama da noi una partecipazione personale. Come dice un poeta polacco: “La Croce piantata sul Golgota non salverà colui che non vorrà piantare la croce nel suo cuore”. Ogni cristiano è segnato dal Mistero della Croce, la grazia che riceviamo mediante il battesimo è una grazia di morte: “in morte illius baptizati sumus” (Rm 6, 3), noi siamo battezzati nella morte di Cristo, siamo immersi nella morte di Cristo. Altrimenti non si diviene cristiani. Apparteniamo dunque a questo mistero. E questa è appunto la ragione per la quale la Croce ha un tal fascino per l’anima cristiana. Sentiamo che la nostra relazione personale alla Croce di Cristo è la vera misura del nostro valore personale come cristiani, la vera misura del nostro cristianesimo. Sento che sarò veramente un cristiano quando sarò capace di guardare il Crocefisso in faccia e potrò dire in ogni verità che amo il Crocefisso e che amo la Croce del mio Signore e la ricerco nella mia vita. Quando potrò dire questo in ogni verità? Quando avrò la grazia di non avere più questa scappatoia, questa codardia davanti alla Croce, ma un atteggiamento francamente cristiano e coraggioso. Se vediamo un fratello cristiano che si sacrifica totalmente, che realizza nella sua vita la Parola del Signore di odiare la propria anima in questo mondo, sentiamo un movimento di gelosia perché sentiamo che questo fratello ha trovato la pienezza e l’autenticità del cristianesimo, sentiamo che lui è veramente libero.
L’Uomo di oggi parla sempre di un cristianesimo “positivo”, mette l’accento sulla risurrezione e non ama pensare alla Passione e alla morte. È vero che il fine è sempre la vita. “Christus resurgens ex mortiis iam non moritur, mors illi ultra non dominabitur (Cristo una volta risuscitato dai morti, più non morrà, non avendo la morte più alcun dominio su di lui). Chi è morto, è morto al peccato una volta per sempre: e chi vive, vive ormai per Iddio. Così voi pure consideratevi morti sì al peccato, ma vivi per Dio in Cristo Gesù” (Rm 6, 9-11). Sì, la vita eterna è già una realtà in noi, perciò dice l’Apostolo: “Se siete risorti con Cristo cercate le cose dell’alto, dove Cristo è assiso alla destra di Dio” (Col 3, 1), ma in questo mondo rimane totalmente il programma del Signore che dice nel Vangelo di S. Giovanni, nel capitolo dodicesimo: “Se il chicco di frumento non cade in terra e vi muore, resta solo; se invece muore, porta molto frutto. Chi ama la sua vita, la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo, la conserva per la vita eterna” (Gv 12, 24-25). Se il chicco di frumento fosse intelligente, temerebbe di cadere nel solco umido e tenebroso. Così anche il cristiano sente un timore davanti al mistero della morte che lo attira e lo affascina in virtù della sua grazia battesimale. Noi dobbiamo pensare che la nostra vocazione monastica è un appello speciale alla Croce di Cristo. La rinuncia che fa penetrare nel mistero della morte costituisce l’elemento caratteristico di questa vocazione. La vita monastica è la prolungazione e lo sviluppo il più naturale della grazia ricevuta nel battesimo. Pensiamo a questo, Fratelli, e preghiamo il Signore che per mezzo della celebrazione liturgica della sua Morte generatrice di vita ci rinnovi in questo spirito.
5. Pasqua (sabato in albis) [17] Carissimi Fratelli,
Siccome il Tempo Pasquale dura fino alla Pentecoste, dobbiamo sforzarci di approfondire un po’ spiritualmente questo grandissimo Mistero meditando il suo senso e la sua importanza per noi. Domanderemo a San Paolo di aiutarci nella nostra meditazione; è stato lui invero che sotto l’ispirazione dello Spirito Santo ha potuto per primo insegnarci la significazione teologica e spirituale di questo fatto meraviglioso di tutta la Storia della Salvezza, e il punto centrale di essa.
Prima di tutto l’Apostolo presenta la Risurrezione di Gesù Cristo come un fatto storico bene stabilito da molti testimoni. Ai Corinzi che avevano molti dubbi relativamente alla Risurrezione scrive: Vi trasmisi invero quanto anch’io ho ricevuto, che, cioè, Cristo morì per i nostri peccati, conformemente alle Scritture; e che fu sepolto e risorse il terzo giorno, conformemente alle Scritture; e che apparve a Cefa e poi ai Dodici. In seguito apparve a oltre cinquecento fratelli in una sola volta e, di questi, la maggior parte resta tuttora in vita, mentre alcuni sono morti. Apparve quindi a Giacomo, poi a tutti gli Apostoli. In ultimo, dopo tutti, apparve anche a me, come all’aborto. Si, io sono il minimo degli Apostoli, neppure degno di essere chiamato Apostolo, perché perseguitai la Chiesa di Dio… Tanto io, dunque, quanto essi così predichiamo e voi a questa fede avete aderito (1 Cor 15, 3-9.11).
Il pensiero dell’Apostolo è chiaro: la fede della Chiesa nella Risurrezione di Cristo riposa su fatti storici bene attestati da molti testimoni oculari. L’Apostolo parla chiaramente con grande insistenza come se avesse previsto i nostri tempi. Oggidì assistiamo a uno sforzo ostinato di molti esegeti critici della Bibbia che mirano a sradicare la fede cristiana dal suo suolo storico. Il mondo della fede sarebbe secondo loro un mondo spirituale fuori dalla storia e senza realtà storica. L’Apostolo Paolo invece insiste sulle prove storiche della Risurrezione del Signore. Ma S. Paolo non si ferma qui, ma subito ci fa entrare nelle viscere del Mistero. Ora – dice – se si predica che Cristo è risorto dai morti come mai ci sono tra voi alcuni che dicono che non c’è risurrezione dei morti? Se non c’è risurrezione dei morti neppure Cristo è risorto! (1 Cor 15, 12-13).
Abbiamo già qui un’interpretazione teologica del fatto della Risurrezione che non si capisce da sé. Un ragionamento puramente umano avrebbe detto: “Se io ammetto il fatto della Risurrezione di Cristo perché è attestato da molti che Lo hanno visto vivo dopo la sua morte sulla croce, da questo non risulta che gli altri morti potrebbero anche risorgere. Ragionamento umano giusto”. Ma qui entra già la dottrina soprannaturale dell’Apostolo ricevuta dallo Spirito Santo. Nessun altro potrebbe sapere questo. L’Apostolo ci insegna l’esistenza d’un misterioso legame tra noi e Gesù morto e risorto. Se Lui è risorto, dobbiamo risorgere anche noi. Questa è una necessità a ragione di questo legame, una necessità tale che, negando la risurrezione dei morti, si deve negare anche quella di Gesù, perché la sua non avrebbe senso senza la nostra. Quindi, negando la risurrezione dei morti si deve arrivare alla negazione di tutta la religione cristiana: Se non c’è risurrezione dei morti, neppure Cristo è risorto! Ma se Cristo non è risorto allora la nostra predicazione è vana, vana anche la nostra fede… Voi siete ancora nei vostri peccati. Non solo: anche quelli che si sono addormentati in Cristo si sono perduti, e noi che in questa vita abbiamo posto speranza in Cristo soltanto, siamo tra tutti gli uomini i più degni di commiserazione (1 Cor 15, 13-14.17-19).
Pertanto da questo misterioso legame che ci unisce al Cristo morto e risorto, San Paolo continua sviluppando la sua profonda dottrina sulla Risurrezione: Ora invece Cristo è davvero risorto dai morti, primizia di quelli che si sono addormentati nel sonno di morte. Poiché la morte venne per opera di un uomo, anche la risurrezione dei morti viene per opera di un uomo (1 Cor 15, 20-21). In questa grandiosa visione teologica l’umanità è presentata come in uno stato di mietitura. In questa ingente mietitura l’Uomo Cristo è la primizia, seguono migliaia e migliaia di uomini dei quali la morte è qui presentata come un sonno: “Christus primitiae dormientium”.
Come infatti tutti muoiono in Adamo, così pure tutti in Cristo saranno richiamati in vita. Ciascuno però nel suo ordine: primizia è Cristo; quindi quelli che alla sua venuta saranno di Cristo; poi la fine! (1 Cor 15, 22-24). In questa immagine della prima Lettera ai Corinzi vediamo tutta l’umanità in via verso la fine che sarà la risurrezione dai morti. L’Umanità della quale il Cristo si è fatto capo e primizia; l’Umanità rapita da Dio in Cristo si trova in via verso la gloria del Risorto. La prospettiva della 1 Cor riguarda il problema della risurrezione finale.
Ma la teologia pasquale di San Paolo non si ferma qui. Nell’Epistola ai Colossesi lui scrive: Se siete risorti con Cristo, cercate le cose dell’alto, dove Cristo è assiso alla destra di Dio, pensate alle cose dell’alto, non a quelle della terra. Voi siete morti, infatti, e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati nella gloria (Col 3, 1-4 ). Qui vediamo qualche cosa di nuovo. Non si parla soltanto di una risurrezione futura già assicurata per la Risurrezione di Cristo, ma non ancora effettuata. Qui si parla dello stato attuale del cristiano che è uno stato di risurrezione, e, siccome “agere seguitur esse”: l’agire segue l’essere, corrisponde all’essere, così a questo stato di risurrezione deve corrispondere un agire. Nella Lettera ai Corinzi San Paolo disse che risorgeremo dopo la morte per opera di Cristo che è risorto come nostra primizia; qui invece insegna che già siamo risorti, la risurrezione è una realtà già attuale in noi, una forma di vita che ci è stata data da Dio tramite i sacramenti della Chiesa e alla quale dobbiamo sottomettere tutto il nostro agire. Dobbiamo dunque cercare le cose dell’alto non soltanto perché sono migliori, ma perché questo cercare delle cose dell’alto è una esigenza di questa nuova vita proveniente dal Signore Risorto, con il quale siamo uniti misteriosamente ma realmente. Dobbiamo quindi “cercare le cose dell’alto dove Cristo è assiso alla destra di Dio”. Dove Cristo è, là devono dirigersi i nostri desideri.
Ma nella Lettera agli Efesini San Paolo dice ancora qualche cosa di più. Ecco le sue parole: Dio ricco in misericordia, per la grande carità con cui Egli ci ha amati, morti come eravamo per le nostre colpe, ci ridonò la vita con Cristo… e con Lui ci risuscitò e ci fece sedere nelle regioni celesti, in Cristo Gesù (Ef 2, 4-6). I nostri desideri devono dirigersi “dove Cristo è assiso alla destra del Padre”. Poiché in Lui siamo già in queste “regioni celesti” anticipatamente. Ma in questo mondo il pensiero della risurrezione non è mai totalmente separato da quello della morte. Nella sua Lettera ai Colossesi l’Apostolo trova una bellissima forma sintetica per esprimere il mistero della vita del cristiano: “Voi siete morti, e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio” (3, 3).
6. L’incontro in Galilea (Mt 28, 16-20) [18]
Quando Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salomone sono venute al sepolcro per imbalsamare il corpo di Gesù, il sole era già levato. Il vero Sole dell’umanità, la luce del mondo brillava già sopra il firmamento con tutto il suo splendore. Esse dicevano tra loro: “Chi ci rotolerà la pietra dalla porta del sepolcro?” (Mc 16, 3). Ma alzati gli occhi, videro che la pietra era stata già rotolata; eppure era molto grande. Questo era un senso simbolico. Anche noi in questo Tempo Pasquale siamo invitati ad alzare gli occhi e vedere con una grandissima gioia che l’ingente pietra della nostra tomba è stata già rotolata e possiamo uscire dalla morte verso la vita piena ed eterna nella luce del vero Sole. Questo Mistero contempliamo con una fede illuminata, con una gioia sempre rinnovata.
Nel Vangelo di San Matteo, e anche in quello di San Marco, le donne sono mandate dall’angelo annunziatore della Risurrezione del Signore agli Apostoli con l’ordine per loro di recarsi in Galilea per incontrare Gesù. Questo misterioso appuntamento era già stato dato da Gesù ai discepoli prima della sua Passione. Difatti, dopo l’ultima cena, strada facendo verso il monte degli Ulivi, disse loro: “Tutti voi patirete scandalo a causa mia questa notte; sta scritto infatti: Percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse; ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea” (Mt 26, 31-33). Sappiamo dal Vangelo che il Signore si è incontrato coi suoi discepoli più volte dopo la Sua Risurrezione. La maggioranza degli incontri riferiti dagli Evangelisti aveva luogo a Gerusalemme e nei dintorni. Soltanto due incontri troviamo nei Vangeli che hanno avuto luogo in Galilea: uno raccontato da San Matteo e l’altro da San Giovanni. Ma quello del quale parla Giovanni aveva un carattere piuttosto privato. Gesù si è mostrato ai discepoli al lago di Genezareth. Quello invece del quale parla Matteo ha una importanza speciale. È un appuntamento ufficiale, fissato dal Signore stesso ancora prima della Sua Passione, al gruppo ristretto degli Apostoli.
San Matteo dice che l’incontro ha avuto luogo su un monte designato da Gesù e accenna alla presenza degli Undici. Gli interpreti suggeriscono il monte Tabor o il monte delle Beatitudini, ma l’Evangelista non lo dice. La sua relazione è laconica: Vedendolo, gli si prosternarono; mentre alcuni avevano dubitato. Gesù avvicinatosi, parlò loro dicendo: A me fu dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque, istruite tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco io sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo (Mt 28, 18-20).
Questo discorso di Gesù ha un carattere molto solenne. Tutto qui ha una grande importanza. Prima abbiamo qui una solenne affermazione e una proclamazione che il Cristo risorto ha ricevuto dal Padre un assoluto ed illuminato potere sopra tutte le creature. Questo potere si estende a tutto l’universo visibile e invisibile. L’Uomo Figlio di Dio ha pieno potere anche sugli Angeli del Cielo e sulle potenze infernali, come scrive San Paolo ai Filippesi: “perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi in cielo, sulla terra, nell’inferno e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è Signore” (Fil 2, 10-11). Da questo potere del Risorto non esiste nessuna esenzione. Questo assoluto e universale potere di Gesù Cristo e questa necessità di sottomettersi totalmente a Lui esistono dal momento della Sua Resurrezione. Nel momento quando dice queste parole agli Apostoli Lui è già il Sovrano universale; ma la sottomissione effettiva del mondo sotto il suo scettro costituisce un lungo processo che comincia solamente nel momento quando Cristo parla agli Undici.
La Lettera agli Ebrei dice citando il Salmo 8: “Che cosa è l’uomo che Tu te ne ricordi o il figlio dell’uomo che Tu lo riguardi? L’hai fatto per poco più piccolo degli angeli, di gloria e d’onore l’hai coronato, tutto hai assoggettato ai suoi piedi. Dicendo che tutto è assoggettato a Lui, nulla ha lasciato a Lui non soggetto! Ora però non vediamo ancora assoggettate a Lui tutte le cose” (Eb 2, 6-8). Nel capitolo decimo della stessa Lettera agli Ebrei Cristo ci è presentato come aspettante la piena realizzazione della sua dominazione universale: “Offerto un unico sacrificio per i peccati, in perpetuo si assise alla destra di Dio, attendendo ormai fino a che i suoi nemici siano posti a sgabello dei suoi piedi” (Eb 10, 12-13). Così anche in ciascuno di noi il suo potere è già pieno e assoluto, ma la realizzazione del suo pieno dominio in noi si effettua gradatamente per l’azione dello Spirito Santo e la nostra sempre più perfetta sottomissione a questa azione. Il Regno di Dio è dunque già realizzato nella Risurrezione di Cristo. Lui è veramente il Re, e il suo potere è assoluto e universale. Ma d’altra parte il Regno di Dio si trova “in statu fieri”, si svolge nel tempo in mezzo a molteplici ostacoli e difficoltà. E perciò dobbiamo sempre pregare: “Venga il Tuo Regno!” (Mt 6, 10). Questa evoluzione dinamica, questo misterioso sviluppo del Regno di Dio nel mondo costituisce uno spettacolo affascinante per la fede che si sente fortemente e profondamente impegnata.
S. Paolo nella prima Epistola ai Corinzi ha un bellissimo passo che ci mostra la fine di questa evoluzione del Regno che non si fa senza una lotta terribile contro le potenze diaboliche: “Poi la fine, quando Egli rimetterà il regno di Dio, il Padre, dopo aver distrutto ogni principato e ogni dominazione e potenza. Bisogna infatti che Egli regni finché non abbia posto tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L’Ultimo nemico a essere eliminato sarà la morte. Dio infatti tutto ha posto sotto i suoi piedi. Ma quando dice che tutto gli è stato sottomesso, fa evidentemente eccezione colui che tutto gli ha sottomesso. Solo quando tutto gli sarà sottomesso, allora anche lo stesso Figlio si sottometterà a colui che gli ha sottomesso tutte le cose, affinché Dio sia tutto in tutti” (1 Cor 15, 24-28). Vediamo quindi che il potere assoluto e universale dato al Cristo Risorto deve realizzarsi poco a poco in lotta contro le potenze contrarie. La nostra preghiera: “Venga il Tuo regno” è piena di senso anche dopo la Risurrezione di Gesù Cristo e dopo la solenne proclamazione del suo potere universale dinanzi agli Apostoli in Galilea.
Continuando il suo solenne discorso agli Apostoli, Gesù dice: Andate dunque, istruite tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo (Mt 28, 19). Gesù manda gli Apostoli nel mondo in virtù di questo stesso potere universale. Ma come può il Signore mandare i suoi discepoli in un mondo non ancora sottomesso al suo soavissimo giogo? Come può mandare i suoi discepoli ideali in un mondo dove le potenze diaboliche non sono ancora rotte e occupano le posizioni chiave? È certo che queste potenze terranno duro e non cederanno senza una terribile resistenza. Nondimeno Gesù li manda “come pecore dai lupi” (Mt 10, 16). Il mondo non vuole sottomettersi al Cristo. Ecco la radice del martirio! Cosa normale nella storia dell’apostolo cristiano. Come nell’Antico Testamento Dio diede la Palestina agli Ebrei, ma essi stessi con l’aiuto divino dovevano conquistarla, così anche nel Nuovo Testamento il mondo deve essere sottomesso al Cristo, conquistato per Lui con un impegno personale dei discepoli di Cristo durante tutta la storia fino alla fine del mondo.
In questa prospettiva possiamo capire meglio il senso profondo della nostra professione monastica e della Regola di San Benedetto. San Paolo ha scritto ai Romani: “Per la disobbedienza di un solo uomo gli altri furono costituiti peccatori, per l’obbedienza di uno solo gli altri saranno costituiti giusti” (Rm 5, 19). L’Apostolo insegna il valore soteriologico dell’obbedienza di Cristo che costituisce una forza di sottomissione che piega l’uomo ribelle verso l’obbedienza a Dio. L’obbedienza monastica non ha un senso solamente ascetico, ma ha anche un senso soteriologico. Essa costituisce un aumento nella Chiesa di quella forza di sottomissione che vince la forza di ribellione, minuisce gli influssi diabolici nel mondo e avvicina il momento della sottomissione universale. Gli Apostoli sono mandati a tutti popoli della terra senza nessuna eccezione. Tutto il mondo deve riconoscere in Cristo il suo Re e Signore. Per questo incarico enorme e sopraumano gli Apostoli non sono lasciati con le sole forze umane.
Il Vangelo parla di una doppia armatura: (1) Istruite tutte le Genti – la Parola di Dio; (2) battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo – battesimo e tutta la ricchezza sacramentale della Chiesa.
(1) La Parola di Dio è una potenza sopranaturale, una potenza divina, data alla Chiesa per il suo grande combattimento spirituale per la salvezza del mondo. S. Paolo parlando del Vangelo dice: “Certo io non mi vergogno del Vangelo: Esso è potenza divina per la salvezza di quanti sono credenti” (Rm 1, 16). La Parola di Dio è una potenza non di distruzione, ma una potenza di luce e di amore, che salva l’uomo adducendolo alla conversione. Più la Parola di Dio sarà pura nella predicazione dei sacerdoti, non mescolata con una sapienza mondana, tanto più fortemente agirà per mezzo di essa la potenza salvatrice di Dio. Noi possiamo indebolire l’azione salvatrice della Parola di Dio, se non ci sottomettiamo noi stessi a questa Parola e non la trasmettiamo nella sua purezza.
(2) battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Queste parole hanno una grandissima importanza dottrinale. Non c’è un altro testo nel Novo Testamento ove sia così chiaramente espressa l’uguaglianza tra le Tre Persone divine. Il battesimo ricevuto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo significa che l’immersione visibile nell’acqua battesimale invisibilmente immerge l’uomo nella vita ineffabile della Santissima Trinità. Senza il battesimo l’uomo può soltanto adorare Dio come unico Dio suo Creatore. Invece, immerso nella vita interiore di Dio per il battesimo, entra in speciali relazioni in rapporto al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo e può rivolgersi a ciascuna di queste Santissime Persone. Pensiamo a questo ineffabile mistero dell’immersione nella Trinità.
7. Ascensione [19]
La solennità che comincia questa sera appartiene alle grandi solennità liturgiche della Chiesa. Il Signore Gesù Cristo dopo la più dolorosa morte, dopo la più profonda umiliazione della Sua Passione, è stato onorato da Dio. Il Padre L’ha glorificato nella vita eterna alla sua destra per tutti i secoli dei secoli. La Chiesa si rallegra nella gioiosa certezza che Gesù Cristo non soffre più, che le mani dei nemici non possono ormai raggiungerLo.
Durante l’Ultima Cena, parlando con gli Apostoli il Signore disse loro: Finora non avete chiesto nulla nel mio nome! Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia perfetta (Gv 16, 24). Queste parole del Signore possono essere capite come un delicato rimprovero ai discepoli perché non domandano in suo nome quando pregano. Alcuni difatti le capiscono così. Mi sembra invece più probabile che non vi sia nessun rimprovero, ma un senso teologico più profondo. I discepoli non chiedevano nel nome di Gesù e non potevano chiedere ancora così, giacché la preghiera nel suo nome non esisteva ancora, non era ancora nata. Il Sacerdote eterno doveva prima penetrare i cieli e riposarsi alla destra di Dio. Fino a questo momento il gran Mistero della Salvezza, il Mistero di Cristo, non era ancora compiuto. Non si poteva quindi pregare come oggi preghiamo noi: “Per il Nostro Signore Gesù Cristo Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell’Unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli”. Adesso lo diciamo con gaudio della nostra fede, sapendo che l’accesso nostro a Dio è una realtà.
Che cosa sarebbe la nostra vita, se questo accesso fosse ancora chiuso? Così non si può pensare, Fratelli. Il senso principale dei nostri eremi consiste appunto in questo accesso a Dio, in questa possibilità per l’uomo di accedere a Dio. Per questo abbiamo abbandonato tutto, per questo ci siamo chiusi in questi bellissimi eremi, per avvicinarci a Dio, per conversare con Dio, per essere con Dio. Questo costituisce anche la nostra testimonianza davanti al mondo, il nostro grido agli uomini, il messaggio degli eremiti. Essi dicono agli uomini: “Coraggio, non perdete la speranza, l’accesso è aperto, l’unione dell’uomo con Dio è ormai possibile. E forse questa forte proclamazione è il più importante impegno degli eremiti nel mondo. Se la vita nostra è un segno visibile ed eloquente di questa importantissima realtà dell’apertura dell’accesso a Dio per gli uomini, è normale che noi viviamo di questa realtà in una maniera specialmente intensa. Questo lo sappiamo tutti, ma ciascuno di noi nell’esperienza della propria vita sa che per l’uomo mortale il problema del contatto con Dio non è facile, anche se è essenziale. Non soltanto la nostra esperienza personale, ma anche l’esperienza degli altri, l’esperienza della Chiesa, l’esperienza delle diverse famiglie religiose durante la storia ci dice molto su questo punto. Quanti conventi, quanti monasteri che erano quasi radicati in Dio per la loro fede e il loro forte spirito di preghiera, poi si sono vuotati di questo spirito. L’architettura rimasta ne parla ancora, ma lo spirito non c’è più.
Tutto questo mostra nel mondo una lotta terribile. L’oggetto di questa lotta implacabile è appunto il contatto dell’uomo con Dio. Cristo ha aperto l’accesso nel glorioso giorno della Sua Ascensione, ma il diavolo fa tutto per chiudere questo accesso e tagliare il contatto dell’uomo con Dio. Il diavolo teme l’uomo che è in contatto con Dio. È l’unica cosa che lui teme. Tutte le altre grandezze dell’uomo non sono niente per lui. Nel Medio Evo i Cistercensi davano ai loro monasteri nomi molto significativi. Questi nomi, come Mellifont, Clairefontaine ecc…, significavano la presenza di Dio come sorgente di beni spirituali, abbondanti per quelli che pieni di fede e di santi desideri Lo cercavano nella preghiera e nella contemplazione.
Se la fedeltà alla preghiera è la causa universale di tutti i beni, così l’abbandono della preghiera, la perdita del contatto vivificante con Dio è la causa di tutti i mali. Come il contatto elettrico è in se stesso semplice, ma produce molti effetti diversi di luce, di calore, di movimento, di forza, così il contatto con Dio si manifesta diversamente nei suoi effetti, rimanendo semplice in se stesso. Qui, nella ripresa di questo contatto, non altrove, è la guarigione totale dell’uomo, sia considerato individualmente, sia come società. Il Profeta Isaia nel capitolo 64 ci presenta un’immagine raccapricciante della situazione morale del popolo. Dice: “Siamo divenuti tutti come una cosa impura, tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come vento – e la ragione –: Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si svegliava per stringersi a te” (Is 64, 5-6).
Carissimi, in questa gloriosa solennità dell’Ascensione del Signore vediamo da una parte la porta del cielo aperta per l’uomo, la santità di Dio meravigliosamente resa accessibile al povero vermetto della terra, e dall’altra parte sentiamo le questioni dei giovani olandesi rivolte al Papa che rivelano non solamente un abbandono della fede, ma anche della stessa umana natura. La coscienza di questi giovani non segnala più alle loro anime le esigenze elementari della legge naturale umana. Davanti a una tale miseria come non pensare alla situazione morale menzionata dal Profeta Isaia: “Perché, Signore, ci fai deviare dalle tue vie e hai indurito il nostro cuore, così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servitori, per amore delle tribù tua eredità. Perché gli empi hanno calpestato il tuo santuario, i nostri avversari hanno profanato il tuo luogo santo? Siamo divenuti come coloro su cui tu non hai mai comandato, sui quali il tuo nome non è stato mai invocato. Siamo divenuti tutti come una cosa impura, tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come vento. Nessuno invocava il tuo nome nessuno si svegliava per stringersi a te. Oh, squarciassi tu i cieli e discendessi!” (Is 63, 17-19)
Il monaco deve ricominciare sempre di nuovo il suo sforzo di preghiera, il rinnovamento continuo del suo vivificante contatto con Dio. L’importante è non scoraggiarsi. La dottrina della Scrittura e dei Santi ci avverte che le difficoltà su questa strada possono essere grandi. Per avere un contatto veramente profondo con Dio l’uomo deve essere purificato spiritualmente per l’esperienza nella fede della verità piena secondo la triplice relazione che esiste tra lui e Dio: Figlio – Padre; creatura – Creatore; peccatore – Santo. L’Esigenza della piena verità lo farà sperimentare non soltanto la vicinanza di Dio e il suo amore, ma anche l’infinita distanza tra il Creatore e la creatura e l’opposizione tra il Santo e il peccatore. Per tutto questo dovrà coraggiosamente passare. Uno dei testi scritturistici che esprimono in una maniera specialmente bella e profonda la dolorosa purificazione della preghiera è certamente il capitolo 3 delle Lamentazioni: “Egli mi guidò, mi fece camminare nelle tenebre, non nella luce. (...) Mi circondò tutt’intorno perché non uscissi, appesantì le mie catene. Anche se grido e chiamo il soccorso, egli soffoca la mia preghiera. Sbarrò la mia via con blocchi di pietra, sconvolse i miei sentieri. (...) Mi saziò con erbe amare, mi dissetò con assenzio. (...) Buono è Jahvé con chi spera in Lui, con l’anima che lo cerca. Buona cosa è aspettare con silenzio la salvezza di Jahvé. Buona cosa è per l’uomo portare il giogo fin dalla giovinezza. Sieda costui solitario e faccia silenzio quando egli gli impone il giogo. Metta nella polvere la bocca, poiché forse c’è ancora speranza” (3, 2.7-9.15.25-29).
8. Ascensione e Pentecoste [20]
Incominciamo oggi la celebrazione della Solennità dell’Ascensione del Signore e tra una settimana avremo la grandissima gioia di commemorare la venuta dello Spirito Santo nel nostro povero mondo. Siccome sabato prossimo non avremo il Capitolo a ragione della Messa Vespertina occorrente, è giusto unire nella nostra odierna meditazione le due grandi solennità. Invero non si deve fare una costruzione artificiale per considerare ambedue queste Solennità “per modum unius”, perché già da sé esse costituiscono una unità impressionante.
Nel giorno della sua gloriosa Ascensione il Signore Gesù Cristo, come Uomo, dopo aver subito la tremenda sofferenza e umiliazione della sua Passione e morte, salì “usque ad summum coeli”, penetrò nell’intimo segreto della sfera della vita divina: Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; adesso lascio il mondo e torno al Padre (Gv 16, 28). Ma sappiamo che Lui non ha fatto questo per se stesso, ma l’ha fatto per noi. La festa dell’Ascensione non è quindi una commemorazione soltanto della sua salita nel cielo e della sua glorificazione. Oggi si realizza anche per noi questo meraviglioso passaggio, questo ingresso nella sfera di vita e di realtà celeste. Questo si compie misteriosamente in noi grazie alla partecipazione che abbiamo nel Cristo, partecipazione che fa che i misteri del Cristo siano nostri misteri.
Queste parole che Gesù ha pronunciato parlando di se stesso devono realizzarsi anche in noi: “sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; adesso lascio il mondo e torno al Padre”. Tutti noi siamo usciti dal Padre per la creazione e per la divina filiazione, e per noi tutti è questo destino: “adesso lascio il mondo e torno al Padre”. Per noi, monaci ed eremiti che vogliamo seguire il Signore, che abbiamo udito la Sua chiamata e cerchiamo le formule semplici e forti di vita, non c’è un programma più semplice e più affascinante di questo: “adesso lascio il mondo e torno al Padre”. Il Figlio di Dio non è venuto in questo mondo soltanto per conoscerlo con la sua santissima presenza, non è venuto in questo mondo soltanto per essere più insieme con noi e darci la sua presenza; ma è venuto per prenderci con sé, per attirarci nella sua marcia forzosa verso il Padre. Carissimi Confratelli, appunto la vita eremitica costituisce forse sulla terra il segno più eloquente di questa realtà dell’Ascensione del Signore Gesù. Dobbiamo meditare questo.
La Lettera agli Ebrei chiama Cristo pròdromos, quello che corre primo, quello che apre la corsa e gli altri lo seguono. Tutti corrono, tutti si affrettano per seguire questo primo, questo (pròdromos – in greco). E dove corre Lui? Dove Lo seguiamo? “Usque ad interiora velaminis”, dice la Scrittura: “oltre il velo”. Che cos’è questo velo? Nell’Antico Testamento un velo separava il primo tabernacolo, chiamato “Santo”, dal secondo, chiamato “Santo dei Santi”. Nel primo tabernacolo entravano i sacerdoti per compiervi gli uffici del culto; ma nel secondo, il solo sommo sacerdote, una volta all’anno, non senza sangue. Questo velo era un simbolo eloquente che significava che l’uomo peccatore non aveva accesso all’intimità di Dio. La vita interna di Dio rimaneva inaccessibile all’uomo. Solo il sommo sacerdote poteva entravi, ma soltanto una volta l’anno e non senza sangue. Questa prescrizione della Legge di Israele era una profezia. Il sommo sacerdote entrante nel “Santo dei santi” con sangue prefigurava Gesù che doveva col suo proprio sangue entrare una volta per sempre nel cielo, aprendolo per l’umanità intera. E per ciò dice la Lettera agli Ebrei: “abbiamo un forte incoraggiamento, noi che troviamo scampo nell’attaccarci all’offerta speranza; la quale teniamo come àncora dell’anima, sicura e salda e che penetra oltre il velo, dove precursore per noi entrò Gesù, divenuto Sommo Sacerdote in eterno” (6, 19-20).
Siamo dunque già ancorati dietro il velo, nella misteriosa vita divina! Si parla qui di speranza, ma il sacro testo ci dà una speciale teologia della speranza. La speranza cristiana non è soltanto una virtù che aspetta da Dio la vita eterna e l’aiuto della sua grazia in questa vita appoggiandosi sulla divina infinita bontà e misericordia, la sua fedeltà e la sua potenza. La speranza è certamente tutto questo, ma è ancora di più, è un legame misterioso con Cristo glorioso nel cielo alla destra del Padre. Per la Sua Ascensione siamo stati ancorati “oltre il velo”. È bene, dunque – Carissimi Fratelli – di pensare spesso al cielo. Se gli Ebrei deportati in Babilonia dicevano: “Se mai ti dimenticassi, Gerusalemme, mi fallisca la destra; mi aderisca la lingua al palato, se non ti ricordo, se non esalto Gerusalemme in capo alla mia canzone gioiosa” (Sal 136, 5-6), tanto più noi dobbiamo spesso e intensamente pensare alla nostra Patria Celeste, alla nostra Vera Gerusalemme.
Che cosa può essere più consolante e più elevante per un autentico eremita del pensiero alla vita eterna? “Nella casa del Padre mio – dice il Signore Gesù – vi sono molte dimore… vado a preparare un posto per voi. E quando sarò partito e avrò preparato un posto per voi, ritornerò e vi prenderò con me, affinché dove sono io siate anche voi” (Gv 14, 2-3). È bello e molto conforme al nostro ideale di contemplativi di fermarci con interna compiacenza a queste immagini piene di luce e di splendore spirituale che abbiamo negli ultimi capitoli dell’Apocalisse, immagini dell’eterna bellezza che non avrà tramonto: “E vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Infatti il primo cielo e la prima terra passarono, e il mare non è più. E vidi la città santa, Gerusalemme nuova, che scende dal cielo, da presso Dio, preparata come sposa che è stata ornata per il marito. E udii una voce grande proveniente dal trono che diceva: Ecco la dimora di Dio con gli uomini…, e Dio stesso sarà con essi e tergerà ogni lacrima dei loro occhi, e la morte non sarà più, né lutto, né grido né dolore saranno più; ché le cose di prima passarono. E disse colui che sedeva sul trono: Ecco, faccio nuove tutte le cose. (…) e mi trasportò in spirito sopra un monte grande e alto, e mi mostrò la città santa Gerusalemme che scende dal cielo da presso Dio, avendo in sé la gloria di Dio. (...) e la città era di oro puro simile a vetro puro. (...) E la città non ha bisogno del sole né della luna che la rischiarino; poiché la gloria di Dio la illuminò e la sua lucerna è l’Agnello. (...) E nessuna maledizione vi sarà più (…) e vedranno la sua faccia, e il suo nome sarà sulle loro fronti (…) e regneranno per i secoli dei secoli.” (Ap 21, 1-3.4-6.10.18.23, e 22, 3.4.5).
Ma che cosa significa per l’uomo la partecipazione all’Ascensione di Cristo se non una assunzione nella vita divina? E questa assunzione nella vita divina si fa per il dono dello Spirito Santo. Se nella Solennità dell’Ascensione consideriamo l’elevazione dell’uomo in Cristo fino al cielo, la festa della Pentecoste ci rivela il cielo discendente sulla terra. Siccome lo Spirito Santo è Dio, ricevere lo Spirito Santo, partecipare nello Spirito Santo significa entrare nel cielo, penetrare nell’intimo santuario della vita divina. Quindi, quando Cristo è salito nel cielo, l’uomo doveva cominciare ad essere celeste, ad essere con Cristo nel cielo. Questo si è realizzato nella giornata della Pentecoste, quando il Cielo nella Persona dello Spirito Santo è disceso sui discepoli di Cristo assumendoli nella vita divina. Questo stretto legame tra la glorificazione di Cristo e la venuta dello Spirito Santo è sottolineato già da Gesù stesso: “Nell’ultimo giorno… della festa (delle Capanne), Gesù in piedi disse ad alta voce: Se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me. Come ha detto la Scrittura, fiumi di acqua viva scorreranno dal suo seno. Questo disse dello Spirito che dovevano ricevere i credenti in Lui; lo Spirito infatti non era stato ancora dato, perché Gesù non ancora era stato glorificato” (Gv 7, 37-39). La venuta dello Spirito Santo è la nascita della Chiesa come Corpo Mistico del Cristo glorificato. Le opere di Dio hanno una somiglianza tra di loro. Nella creazione dell’uomo Dio prese un elemento terreno e insoffiò la vita. Nella creazione della Chiesa Lui prese anche un elemento terreno – gli Apostoli, e poi insoffiò il suo Spirito e la Chiesa ha cominciato ad esistere come un corpo vivente.
Se abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, dobbiamo credere di averlo ricevuto e dunque dobbiamo vivere nello Spirito Santo. Una cosa molto importante per ciascuno di noi è sapere che lo Spirito Santo è colui che dirige la nostra vita. Si deve distinguere una doppia direzione dello Spirito Santo nella Chiesa: una esterna e l’altra interna. La direzione esterna dello Spirito si fa mediante la Rivelazione e la Chiesa. Nella Scrittura, nella Tradizione, nell’insegnamento del Magistero della Chiesa lo Spirito insegna e dirige gli uomini. Questa è la direzione esterna. Ma c’è anche una direzione interna. Lo Spirito insegna e dirige l’uomo attraverso interne inspirazioni. Tutto ciò che viene dallo Spirito di Dio è buono, sia che venga per la via esterna, sia che venga per la via interna. Tra la direzione esterna e quella interna non possono esistere dei contrasti giacché Dio non può essere contrario a se stesso. Ma ciò che viene per la via esterna della Chiesa è più sicuro, invece nelle nostre ispirazioni interne possiamo più facilmente sbagliarci attribuendole allo Spirito di Dio. La Chiesa però ha la missione e l’autorità dallo Spirito Santo di giudicare anche l’autenticità divina delle inspirazioni interiori delle anime, specialmente quando quelle ispirazioni riguardano un’opera esteriore nella Chiesa (fondazioni, ecc.).
9. San Benedetto [21]
Abbiamo celebrato questa settimana la festa del Padre nostro San Benedetto. Lui non fu il nostro fondatore, ma ben nostro Legislatore. Il nostro Santo Padre e Fondatore, San Romualdo, fu formato alla sua scuola e ha voluto che i suoi figli lo fossero ugualmente. La Regola di San Benedetto è il codice veramente ispirato che ci trasmette l’antico spirito monastico e l’antica disciplina monastica, maturata nei primi secoli del cristianesimo, da uomini santi e pieni della sapienza divina. La festa del nostro Santo Padre e Legislatore ci invita a fermarci un po’ per contemplare la bellezza divina della sua vocazione e della sua opera. La figura di San Benedetto ha qualche cosa di monumentale nella semplicità e nella serietà della sua totale appartenenza a Dio. Nella pienezza della sua paternità rassomiglia al Patriarca Abramo, e come questo Patriarca cammina con Dio con una straordinaria semplicità, realizzando quasi naturalmente la grande opera di Dio a lui affidata. È certamente utile e salutare per noi rinnovare questo nel nostro cuore per la meditazione nello spirito della Santa Regola che dobbiamo considerare come un dono preziosissimo del Signore: “Lucerna pedibus meis” (Sal 119, 105).
Il fondamento di tutta la spiritualità della Regola consiste nel contatto personale con Dio. Il libro della Genesi racconta nel capitolo 16 come Agar fuggente dalla severità di Sarai è consolatala Dio, dopo la sua visione alla sorgente d’acqua nel deserto, e chiamò quel pozzo Lakhai-Roi, cioè “al vivente che mi vede” (cf. Gn 16, 13-14). Il Santo Padre Benedetto vuole il suo discepolo a questo pozzo, davanti “al vivente che mi vede”. Da questo punto parte tutta la spiritualità benedettina. Già nel Prologo alla Regola troviamo questo confronto dell’uomo con Dio. Lo ritroviamo poi nel capitolo settimo sull’umiltà, della quale costituisce la sorgente e la base. L’umiltà benedettina non è frutto di esercizi di autodisprezzo, né di umiliazioni artificiali, ma essa scaturisce da questo confronto con Dio, da questo contatto vivo e spirituale col Signore alla sorgente Lakhai-Roi, dove San Benedetto vuole condurre e mantenere il suo discepolo.
Quando la vita si stabilisce sotto lo sguardo di Dio, nella viva presenza di Dio, davanti al suo volto splendente e maestoso, nasce nell’anima un profondo senso della grandezza di Dio, della sua infinità maestà. E allora si sveglia un ardente desiderio di adorazione, di sottomissione e di umiliazione. Appunto in un tale profondo e vivo desiderio consiste ciò che possiamo considerare come la vera personalità del monaco: un atteggiamento adorante, umiliato e sottomesso, cioè obbediente. Abbiamo qui le caratteristiche principali di una vera personalità monastica: spirito di religione, umiltà e obbedienza. Siccome il contatto con Dio costituisce l’unica sorgente di queste virtù fondamentali, ne risulta una personalità ben unita, armoniosa e coerente.
La visione dell’obbedienza di San Benedetto è più teologica e soteriologia che semplicemente ascetica, benché questo punto di vista non manchi. Le parole della Regola: ut ad eum per obedientiae laborem redeas, a quo per inobedientiae desidiam recesseras (Prologo) non spettano soltanto al candidato concreto che si presenta per essere ricevuto, ma a tutti, e possiamo dire all’umanità intera. L’uomo concreto che domanda di farsi monaco deve rendersi conto dello stato teologico dell’umanità alla quale appartiene. L’umanità si trova in uno stato di disobbedienza e di ribellione contro Dio. Questo stato, che può essere sanato solamente per mezzo di una amorosa e totale sottomissione al Signore e alla sua volontà, in parte ci perviene dell’obbedienza del Cristo. Ecco in un semplicissimo schema tutto il problema della santificazione: adorare, umiliarsi, sottomettersi perfettamente. A questo scopo deve servire la “Schola Dominici servitii” (Prologo).
Il candidato dunque, entrando nel monastero, assume in sé tutta la storia del genere umano caduto e redento per viverla in sé concretamente. San Paolo scrive ai Romani: “Per la disobbedienza di un solo uomo gli altri sono costituiti peccatori, per obbedienza di uno solo gli altri sono costituiti giusti” (Rm 5, 19). L’obbedienza del Cristo ha raddrizzato la linea di tutta l’umanità, resa storta per l’influsso dello spirito diabolico. Il monaco vuole partecipare in una maniera speciale e privilegiata a questo raddrizzamento dell’uomo per l’obbedienza del Cristo. Questa è la sua vocazione speciale nella Chiesa. In questa prospettiva profondamente teologica e semplice dell’obbedienza si capisce che San Benedetto tratta il candidato alla vita monastica non come uno che vuole sviluppare e perfezionare le sue qualità, ma come un peccatore che vuole convertirsi per ritornare a Dio mediante una perfetta sottomissione. La Regola di San Benedetto è più una Regola di ritorno a Dio che una regola di perfezionamento, anche se quest’ultima idea è presente al Santo Autore più forse sotto la forma di un’ascensione per diversi gradi verso l’abitazione di Dio.
Si parla spesso della “pax benedettina”, sottolineando una caratteristica impressione di pace che la vita benedettina fa su quelli che la incontrano. Questo si può capire bene se si pensa che ciò che possiamo chiamare “il movimento della Regola” è nient’altro che il ritorno a un ordine divino delle cose, un ordine obiettivo nel quale ciascun essere ha il suo posto, i suoi limiti, la sua autenticità. La pace non è altro che la “tranquillitas ordinis”. Non è dunque da meravigliarsi che appunto da questa Regola, che fa rientrare tutto nell’ordine eterno di Dio, emana un’atmosfera particolare di pace.
Ci sono delle concezioni della Regola di San Benedetto che, sottolineando i diversi atteggiamenti spirituali del monaco benedettino, dimenticano la forte ascesi personale insegnata da San Benedetto nella Sua Regola. Il capitolo 4: “Quae sunt instrumenta bonorum operum”, ci mostra il monastero come luogo di un lavoro ascetico personale, serio e fervoroso. Questo aspetto essenziale sarebbe da sottolineare nei nostri tempi.
È vero che San Benedetto si mostra molto misurato quando si tratta delle mortificazioni corporali. Dopo l’austerità dei Padri del Deserto, il suo codice può sembrare di introdurre un certo lassismo. Esaminando più a fondo il sistema ascetico della Regola vediamo che le sue esigenze spirituali sono fortissime. Nell’umiltà, nell’obbedienza, nella povertà San Benedetto mostra delle esigenze intransigenti. Il suo programma spirituale non ammette nessun minimalismo, nessuna mediocrità, il monaco deve umiliarsi fino al fondo dove la grazia di Dio lo troverà per esaltarlo.
Il monastero benedettino ha una struttura ecclesiale, una struttura teologica più di molte altre comunità religiose nella Chiesa. Ho assistito una volta a Varsavia a una conferenza sulla comunità religiosa secondo la dottrina del Vaticano II. Il conferenziere era un Redentorista. Parlava con entusiasmo sulla dottrina del Concilio Vaticano II. Secondo lui il Concilio ha scoperto una teologia della vita comune che prima non era conosciuta. È certamente vero che le Congregazioni Apostoliche come i Redentoristi, nelle loro piccole comunità totalmente organizzate in funzione del lavoro apostolico, non vivevano una teologia della vita comune e potevano praticamente ignorarla. Ma la comunità benedettina è teologica in tutta la sua concezione. Nella sua struttura essa è una concretizzazione della Chiesa. Il fondamento e il centro è l’Abate che rappresenta e prolunga la viva presenza del Cristo, su cui tutto si appoggia e da cui tutto riceve la vita e la coesione. L’Eucarestia e la preghiera liturgica con la Parola di Dio formano la spina dorsale della vita spirituale della Comunità. Tutta la giornata trova qui il principio della sua organizzazione e della sua santificazione in Cristo. I princìpi dell’unità, dell’autorità, del servizio, della partecipazione, della carità fraterna, del mutuo aiuto, tutti questi elementi della vita ecclesiale e della teologia della Comunità sono già presenti nella Comunità benedettina fin dal principio. Tutti questi principi si verificano anche negli eremi camaldolesi che sono vere comunità di eremiti, sono anche comunità di preghiera, nonostante la specifica ricerca da eremiti di una preghiera solitaria.
10. San Lorenzo [22]
Festeggiamo oggi uno dei più celebri martiri della Chiesa. La Chiesa ama i suoi martiri, li onora, si gloria di questi soldati che hanno combattuto fino alla fine senza cedere al male e l’hanno vinto nella morte. Dalle solennità dei martiri si possono trarre molti insegnamenti per la vita cristiana, ma oggi vorrei fermarmi su un pensiero che mi sembra importante, cioè che la vita cristiana è una prova. Questa verità è messa in rilievo speciale nei combattimenti dei martiri, ma non si può dubitare che ogni cristiano debba essere provato in questa vita per raggiungere la corona. A questo pensiero dobbiamo ritornare spesso per non addormentarci nel nostro sforzo ascetico quotidiano, per stimolare sempre di nuovo le nostre energie spirituali.
Dio ci prova. È un pensiero fecondo, Dio ci prova, Dio ci tratta sul serio. L’uno o l’altro avvenimento nella ma vita, un affanno, una umiliazione, una debolezza… che mi sembravano essere mali e costituire pure ostacoli sul mio cammino, hanno un altro senso, un altro volto quando penso: Dio sta provandomi. Allora tutto ha un senso, tutto diviene vivo. A noi tutti dice la Sapienza del Siracide: Figlio, se ti accosti al servizio del Signore, disponi la tua anima alla prova (Sir 2, 1). Quindi, secondo le parole della Sapienza c’è un relazione necessaria tra il servizio del Signore e la prova: “Figlio, se ti accosti al servizio del Signore, disponi la tua anima alla prova”. Se dunque hai preso un fermo proposito di servire Dio, non pensare di poter scappare dalla prova. Perché questa necessità della prova?
1. Perché servire Dio è sottomettersi alla Sua volontà e la Sua volontà è una volontà di perfezionamento e di santità per noi: “Haec est voluntas Dei: sanctificatio vestra” (1 Ts 4, 3). La santificazione richiede una trasformazione profonda dell’uomo, una purificazione totale della sua mente e del suo cuore, e questo non può realizzarsi senza dolorosi distacchi e molte sofferenze.
2. E poi il diavolo non è mai in vacanza. Egli, come nostro avversario accanitissimo e implacabile, è deciso a non lasciarci passare. Come i popoli nemici d’Israele non volevano lasciarlo passare per impadronirsi della Terra Promessa. Essi hanno detto duramente: “Non passerai!”, e sono venuti armati al suo incontro. Tutti questi popoli che volevano impedire al Popolo di Dio di passare il loro territorio per andare verso la Terra Promessa, simboleggiavano le potenze infernali. A ciascuno di noi l’Angelo infernale grida: “Non passerai!” È dunque chiaro che, se nondimeno vogliamo proseguire la nostra marcia, incontreremo la sua ferma resistenza.
3. Anche il Signore stesso vuole provare il nostro amore. Ci sono dunque delle prove che non risultano direttamente dalle difficoltà inerenti allo sforzo di perfezionamento, né provengono dall’ostilità del demonio, ma vengono direttamente dal Dio dell’amore che vuole provare l’amore del suo servo e figlio. La prova è dunque una realtà che sempre è presente nella nostra vita. È importante per noi riconoscerla e trovare un atteggiamento giusto verso di essa per approfittarne spiritualmente. Il Siracide ci dà un insegnamento profondo e pratico in materia. Ecco come ne parla nel suo capitolo 2: Figlio, se ti accosti al servizio del Signore, disponi la tua anima alla prova, abbi un cuore retto, sii costante e non turbarti sotto la prova. Tieniti unito a Lui intimamente e non separartene, perché tu ne resti avvantaggiato in seguito. Ricevi quanto ti invierà e sii longanime nelle vicissitudini delle tue afflizioni: poiché l’oro viene provato con il fuoco, e gli uomini graditi nella fornace dell’umiliazione. Affidati a Lui e ti prenderà in tutela, segui la retta via e spera in Lui (2, 1-6).
Dobbiamo analizzare un po’ questo bellissimo insegnamento della Sapienza di Dio, educatrice degli uomini! È una pedagogia santa, piena di serenità e di pace. Il primo che ci consiglia è un sereno realismo. Non considerare la prova che ci viene come qualche cosa di straordinario e di terribile. Il soldato volontario che si offre per andare alla guerra, capisce bene la sua propria decisione. Lui sa che alla guerra si combatte e si spara. Quindi non è sorpreso di trovare al fronte la sparatoria e un costante pericolo. Così quello che vuole servire Cristo non si nutre di pie illusioni, ma sa bene quale opera vuol fare. E dunque il primo consiglio ci spinge a una piena e realistica consapevolezza dell’opera che facciamo. Questo realismo non permette all’anima di turbarsi né di meravigliarsi di ciò che accade, perché si rende perfettamente conto che con la sua ferma decisione di servire Dio si è esposta alla prova. Con un tale atteggiamento dispone l’anima sua alla prova.
Poi dice: “Abbi un cuore retto, sii costante e non turbarti sotto la prova”. Ci sono qui tre raccomandazioni: (1) la rettitudine del cuore, (2) la costanza, (3) e la pace interna. L’Uomo deve assicurarsi della rettitudine del suo cuore, deve controllare questa rettitudine e raddrizzare ciò che non sarebbe dritto. Vediamo qui che le grandi prove costituiscono impulsi per controllare la propria coscienza e raddrizzarla. Senza una buona e retta coscienza l’uomo non può sopportare la prova senza esserne profondamente turbato. La coscienza retta e il cuore retto ci danno questa pace fondamentale, necessaria per poter attraversare le prove e uscirne vincitori. “Abbi dunque un cuore retto”, e poi “sii costante”. Le sofferenze inerenti ad una prova agiscono sullo spirito umano spingendolo a fuggire, quindi a cambiare sperando di trovare un alleviamento nel cambiare. È una illusione pericolosa. Nei continui cambiamenti l’anima non troverà l’alleviamento desiderato, ma un maggiore turbamento. Costanza nell’amore, costanza nella fiducia, costanza nell’impegno assunto, costanza nell’adempimento del dovere quotidiano, costanza in una pace serena sotto le ali di Dio, qualsiasi cosa avvenga. La pace non è soltanto un dono di Dio, ma anche un obbligo dell’uomo. Esiste una vera ascesi della pace. Molti sembrano non saperlo. Questa ascesi della pace conviene in una maniera tutta speciale ai monaci.
Ma tutti questi atteggiamenti spirituali non sarebbero niente e non avrebbero consistenza senza quello del quale parla nel versetto terzo: “Tieniti unito a Lui intimamente e non separatamente, perché tu ne resti avvantaggiato in seguito”. Ecco un’altra condizione indispensabile per poter uscire vincitore dalla prova della nostra vita: Essere unito a Dio. Senza l’unione con Dio è impossibile per l’uomo vincere nel combattimento della vita. Questo ammonimento appartiene già alla vita mistica come quello del Signore Gesù: “manete in me” (Gv 15, 4). Che cosa sia questo: “manete in me” e come praticamente obbedire a questo sublime precetto, ognuno deve a poco a poco arrivare, in collaborazione con la grazia divina, a capire che cosa questo significa per lui e come egli debba personalmente realizzarlo.
La vita cristiana non è mai puramente ascetica, ma è sempre radicalmente mistica, siccome l’unione con Dio ne è la sorgente e non soltanto il fine e il premio. È bellissimo ciò che ne dice qui la Sapienza: “Tieniti unito a Lui intimamente e non separartene”. È certo che, se l’uomo è unito a Dio, non può peccare, perché dove c’è Dio il peccato non è possibile. Prima di poter peccare l’uomo deve separarsi da Dio. L’Atto di separarsi da Dio è l’atto importantissimo che precede ogni caduta morale dell’uomo. Questo doppio stadio nella tentazione, la quale è la prova “par excellence”, troviamo nell’insegnamento di San Giacomo, che nel primo capitolo della sua lettera scrive: “Ciascuno è tentato dalla propria concupiscenza” (Gc 1, 14) e qui vengono due parole molto significative. Il testo della Vulgata ha: “abstractus et illectus”, è una traduzione buona del greco: ekselkómenos kaì deleazómenos. “Abstractus et illectus” sono quasi due momenti di una tentazione vincente. Primo momento: “abstractus”: la tentazione astrae la mente dalla presenza di Di,o dal contatto con Lui. Poi viene il secondo momento: “illectus”: la mente separata da Dio si lascia trascinare dalla concupiscenza verso un oggetto illecito.
Se nel caso d’una tentazione l’unione con Dio costituisce invero l’unica difesa decisiva (almeno se si tratta di forti tentazioni), la sua importanza è grandissima anche nelle altre prove della vita di chi vuole seriamente servire il Signore. La Sapienza parla di una intima unione con Dio: “Tieniti unito a Lui intimamente e non separartene”. Qui è la segreta e vera sorgente di ogni bene e di ogni perseveranza nell’autentico bene. A questo preziosissimo ammonimento il Siracide aggiunge una promessa riguardante il futuro: “perché tu ne resti avvantaggiato in seguito”.
Alcuni, infiammati dall’amore di Dio, hanno pensato che l’amore per essere perfetto non deve più pensare al premio, non deve più desiderare il cielo, né la vita eterna. Tra gli altri ha insegnato una simile dottrina Fenelon. La Chiesa non ha approvato questa dottrina e Fenelon si ritrasse. Non si deve mai pensare che la perfezione della carità esiga il sacrificio della speranza. Cristo non ha mai insegnato una carità senza speranza. Lui disse che dobbiamo avere il nostro tesoro nel cielo, non ci esorta di non avere nessun tesoro. Non pensiamo che ci possa essere un cristianesimo più perfetto di quello che ci è stato predicato e donato nel Vangelo. La vita cristiana perfetta consiste nella pienezza delle tre virtù teologali: la fede, la speranza e la carità. La speranza è una forte virtù, essa costituisce il dinamismo della nostra corsa verso la Casa del Padre e la vita eterna. Viviamo intensamente la speranza. Una continua promessa del bene a chi compie la volontà di Dio costituisce uno dei caratteri più risaltanti nella Parola di Dio e in ciò che possiamo chiamare “lo stile personale del nostro Dio”.
Le parole citate del Siracide: “perché tu ne resti avvantaggiato in seguito”, sono in perfetta armonia con questo stile divino. Gli ammonimenti della Sapienza divina, indirizzata a quelli che vogliono intraprendere il combattimento per la giustizia in questo mondo, indicano le condizioni di un combattimento vittorioso. La rettitudine del cuore, la costanza che sa perseverare tranquillamente senza fuggire, uno spirito pacato e calmo che non si lascia turbare, e con tutto questo un’intima unione con Dio che innanzitutto teme di separarsi da Lui.
III. Biblica
1. Commento al Salmo 2 [23]
Perché tumultuano le genti/ e i popoli progettano invano?/ Si accampano i re della terra/ e i potenti complottano insieme./ Dicendo: “Marciamo contro Jahvé/ e contro il Suo Unto./ Rompiamo le loro catene / e gettiamo da noi le loro ritorte! (Sal 2, 1-3).
Così il Salmo 2. Che cosa vede il Salmista? Certamente vede una ribellione, una grande ribellione. È forse una ribellione delle tribù di Israele contro il loro re? No, perché si parla delle genti che tumultuano, si parla dei re della terra che si accampano. La prospettiva è però più larga. Ma forse sono le nazioni inimiche che si preparano ad una invasione della Terra d’Israele? Non sarebbe dunque una ribellione, ma una preparazione di guerra contro il popolo d’Israele? Ma allora perché tutte queste genti personalizzate nei loro re direbbero: “Rompiamo le loro catene e gettiamo da noi le loro ritorte!” Non sono queste parole di guerra, ma bensì di ribellione. Vogliono ribellarsi a un potere che sembrava loro duro e insopportabile. Il Salmista cita le loro stesse parole: “Marciamo dicono – contro Jahvé e contro il Suo Unto”. Per l’Unto di Jahvé si potrebbe capire il re di Israele, siccome i re di Israele ricevevano una unzione. Ma Israele era un piccolo paese che non dominava su molte nazioni e su molti re.
Possiamo dunque vedere qui una visione profetica di una grande ribellione contro Dio e contro il suo unico Unto Gesù Cristo. Dio ha mandato il Suo Figlio nel mondo per instaurare il Suo Regno tra gli uomini. L’instaurazione del Regno di Dio sulla terra fu l’incarico del Figlio di Dio. Dallo stesso inizio della sua missione Gesù Cristo incontrò la resistenza, la durezza di cuore, la ribellione. Poi gli Apostoli furono perseguitati, trascinati dai magistrati, dai giudici, tormentati e uccisi. E così dal suo principio fino a oggi la Chiesa è sempre in stato di guerra contro il mondo, contro il principe di questo mondo e contro le ingenti forze del male che operano in questo mondo.
Questo stato di guerra continua è per sé un mistero. Naturalmente non si capisce l’odio che ha incontrato Cristo in cambio del suo amore, della sua bontà manifestata in tante guarigioni e tante opere di misericordia. Neppure si capisce perché la sua dottrina evangelica, dottrina di una sapienza sublime, di carità e di pace, ha trovato tanto odio in risposta. Il Vangelo, e specialmente quello di S. Matteo e di S. Giovanni, sono pieni del terribile e tenebroso mistero del male. Cristo, il Vangelo, la Chiesa hanno nemici implacabili, coi quali non sarà mai possibile una riconciliazione. Sono le potenze spirituali e invisibili che cercano di distruggere ogni bene. Ci sono oggi alcuni cristiani ingenui che vorrebbero riconciliarsi con tutti e sarebbero disposti a prendere un atteggiamento pacifico ed ecumenico anche verso i diavoli, che ne ridono. Questo mistero di odio si basa su una ribellione, la ribellione degli angeli caduti e perciò è così implacabile. Sono loro che dicono: “Marciamo contro Jahvé e contro il Suo Unto. Rompiamo le loro catene e gettiamo da noi le loro ritorte”.
Ma queste parole le sentiamo spesso assunte dagli uomini di oggi. È certamente vero che la crisi spirituale dei nostri giorni si manifesta in un rifiuto di obbedienza. La parola stessa di obbedienza provoca delle reazioni allergiche, come il concetto di potere o di autorità. Alcuni dicono apertamente: parlateci di amore, ma non di obbedienza. Non vogliamo sentire più di questo. Siamo liberi e siamo adulti. Di obbedienza parlate ai bambini… Chi sta dietro una tale mentalità, se non chi ha già rotto le catene del santo timore di Dio e della santa sottomissione alla sua volontà?
In presenza di questa grande ribellione che cosa fa il Signore? Chi siede nei cieli se ne ride,/ il Signore si fa beffe di loro (Sal 2, 4).
Per prima cosa il Salmista fa capire che la ribellione contro Dio è una cosa propriamente ridicola. Tutte le grandissime potenze dell’universo creato anche riunite insieme sono un nulla davanti al Creatore. Dio ride dell’impotenza orgogliosa delle creature che pensano di essere qualche cosa di importante anche dinanzi a Dio stesso. L’illusione di essere qualche cosa è sempre un atteggiamento semplicemente ridicolo in una creatura “ex nihilo”. Tutta questa terribile ribellione contro Dio può sembrare nella prospettiva del mondo una cosa impressionante, ma nella prospettiva di Dio, cioè nella verità, è semplicemente degna d’un sorriso di commiserazione.
Poi si volge a loro nella sua ira/ e nel suo furore li sgomenta (Sal 2, 5).
La Sacra Scrittura parla molto dell’ira di Dio in immagini spesso bellissime. Studiando i testi che ne parlano vediamo che l’ira di Dio è una manifestazione del suo amore. L’ira è l’amore respinto e contrariato. L’Amore di Dio è una forza infinita. Dio ama fortemente l’uomo. Questo amore che secondo le immagini bibliche è appassionato, non può cambiarsi in indifferenza quando l’uomo lo rifiuta. L’indifferenza è contraria alla natura divina. L’amore divino ferito è l’ira di Dio, l’ira che colpisce e punisce chi respinge l’amore ma che non cessa mai di essere amore e di essere misericordia.
Possiamo immaginare un grande fiume. L’ingente mole di acque scorre tranquillamente, pacificamente senza distruggere niente. Ma se si pone un ostacolo a questo enorme volume di acque scorrenti, esse divengono una forza terribile che rompe le dighe. Il grande errore della gente di oggi è di avere una concezione laicizzata della bontà e della misericordia di Dio, di pensare che le grandi pene sono incompatibili con la misericordia di Dio. Secondo la Rivelazione invece, quando il popolo di Dio s’immerge nel peccato, quando arriva ad un alto grado di ribellione e di sfacciataggine, si deve temere un intervento terribile dell’ira del suo Signore, cioè del suo amore geloso e forte: Poi si volge a loro nella sua ira/ e nel suo furore li sgomenta (Sal 2, 5).
La storia ci racconta diverse situazioni dell’umanità, anche le decadenze del popolo di Dio; c’erano delle persecuzioni della vera fede, ma la ribellione contro Dio in forma di una vera ostilità contro Dio stesso e contro l’atteggiamento religioso come tale, questo è una vera novità sconosciuta dalla storia. Si pensa che siamo arrivati al momento della grande apostasia predetta da San Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi: “È necessario che prima si verifichi l’apostasia, si manifesti l’iniquo, il dannato, l’avversario colui che si esalta al di sopra di tutto ciò che porta il nome di Dio o è oggetto di culto, fino a insediarsi nel tempio di Dio e a proclamarsi Dio… Il mistero dell’iniquità infatti già esercita la sua azione nefasta… La manifestazione dell’empio, per l’azione di Satana, sarà accompagnata da ogni specie di portenti, segni e prodigi ingannevoli e da ogni specie di seduzioni di cui l’iniquità è capace, a danno di quelli che si perdono perché non hanno accolto l’amore per la verità che li avrebbe salvati” (2 Ts 2, 3-4.7.9-10). L’ateismo moderno sembra essere già la manifestazione di questa orrenda apostasia generale escatologica. A tutto questo tumulto delle forze ostili Dio risponde non soltanto con la sua ira, non soltanto con il suo furore che sgomenta i nemici, ma con una decisione pacifica e ferma della sua volontà.
Ma io ho stabilito il mio Re,/ sul Sion mio Santo Monte (Sal 2, 6).
La volontà di Dio immutabile, immobile è la roccia contro la quale si frantumeranno tutte le forze contrarie. Dio ha fondato la Chiesa come Regno di Cristo suo Figlio e niente può contrapporsi alla forza di questo decreto divino. Il Salmista insegna che se Dio ha stabilito qualche cosa, ogni ribellione è vana, ogni discussione è vana. L’unica cosa che si può fare è di sottomettersi pienamente alla volontà di Dio. Ora la volontà di Dio è che Cristo sia Re e che tutto sia sottomesso a Lui.
Nei versetti seguenti udiamo la voce del nuovo Re promulgante il decreto divino:
Ho da annunziarvi il decreto di Jahvé. Mi disse: Mio Figlio sei tu,/ oggi io ti ho generato./ Chiedimi e Ti darò le genti in eredità/ e in possesso le estremità della terra./ Li romperai con scettro di ferro,/ come creta di vasaio li frantumerai (Sal 2, 7-9).
Parole piene di profondità. Mi disse: “Mio Figlio sei Tu, oggi io ti ho generato”. Secondo la natura un figlio oggi generato non è capace di assumere il potere regale. Si può dunque pensare alla generazione divina nell’oggi dell’eternità.
“Chiedimi e Ti darò le genti in eredità/ e in possesso le estremità della Terra.” Dice “Chiedimi e Ti darò”. Il Figlio di Dio ha dovuto chiedere per ricevere dal Padre il Regno. Quando ha chiesto se non nella Sua Passione? In Croce ha chiesto il Regno, che poi Gli fu dato dopo la Resurrezione, come Egli stesso dice nel Vangelo di San Matteo: “Mi è stato dato ogni potere nel/ cielo e sulla terra”.
“Li romperai con scettro di ferro,/ come creta di vasaio li frantumerai”. Questo ci pare severo, ma esprime una verità profonda della vita spirituale. Ciascuno di noi non può veramente avvicinarsi a Dio né appartenere al Regno di Cristo senza la grazia della contrizione. Dobbiamo essere contriti, cioè rotti e quasi frantumati interiormente per poter veramente ricevere in noi stessi la vita divina. Ci sono tante durezze nel cuore dell’uomo! Gli ultimi versetti sono una conclusione pratica del Salmo. Contro la volontà di Dio che stabilisce il Regno del Suo Figlio non si può far niente. L’unica via da seguire è quindi quella dell’umiltà e dell’obbedienza: Or dunque re, fate senno…/ servite Jahvé in timore/ ed esultate in tremore, portate doni/ che non si adiri…/ perché divampa per poco la sua ira./ Felici quanti si rifugiano in Lui! (Sal 2, 10-11).
2. Commento al Salmo 4 [24]
Quando ti invoco rispondimi, Dio, mia giustizia:/ dalle angosce mi hai liberato;/ pietà di me, ascolta la mia preghiera.
Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore?/ Perché amate cose vane/ e cercate la menzogna?
Sappiate che il Signore/ fa prodigi per il suo fedele:/ il Signore mi ascolta quando lo invoco.
Tremate e non peccate,/ sul vostro giaciglio/ riflettete e placatevi.
Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
Molti dicono: “Chi ci farà vedere il bene?”/ Risplenda su di noi, Signore,/ la luce del Tuo Volto.
Hai messo più gioia nel mio cuore/ di quando abbondano vino e frumento.
In pace mi corico e subito mi addormento:/ Tu solo, Signore,/ al sicuro mi fai riposare.
Il Salmo costituisce la preghiera di un uomo che ha esperimentato la bontà di Dio nella sua propria vita. Dice al Signore pieno di una santa riconoscenza: “dalle angosce mi hai liberato.” È proprio dell’azione divina di mettere l’anima al largo. Ogni operazione spirituale che serra, che stringe, non è di origine divina e non riflette la natura di Dio. Dio mette l’anima al largo, come dice il testo latino del nostro Salmo: “in tribulatione dilatasti mihi”.
Il Salmista, avendo sperimentato Dio e la sua straordinaria bontà nella propria vita, è pieno di stupore guardando gli uomini, come essi vivono, amando e ricercando cose vane, incoscienti dei veri valori. Vedere questo è per il Santo salmista un vero scossone. Lui si rivolge agli uomini con un grido sdegnato: “Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?”
A colui che conosce Dio, che vive in contatto con Lui, la vita come la vivono gli uomini moderni pare un assurdo. Il Salmo ci mostra che un’autentica esperienza di Dio è necessariamente apostolica. Essa spinge l’uomo che ne è beneficato a rivolgersi ai peccatori per predicare loro la necessità di una conversione a Dio. La caratteristica del peccatore è la durezza di cuore e la menzogna, cioè l’incapacità di giudicare le cose di questo mondo secondo il loro vero valore. Questa incapacità di giudicare le cose conformemente alla verità costituisce uno stato di menzogna. Un cuore implicato nelle cose mondane e nella loro continua ricerca diviene duro e incapace di capire, se si tratta di cose divine e grazia di Dio.
Il Santo invece sa bene che essi potrebbero esperimentare delle meraviglie dell’azione divina nella loro propria vita, se non fossero così appesantiti e inconsiderati. Di questo lui vuole convincerli:
Sappiate che il Signore fa prodigi/ per il suo fedele./ Il Signore mi ascolta quando lo invoco./ Tremate e non peccate,/ sul vostro giaciglio,/ riflettete e placatevi (Sal 4, 4-5).
Queste parole contengono una grande verità della vita spirituale: il cristiano potrebbe avere una esperienza personale della meravigliosa azione di Dio, se fosse aperto alla sua grazia. Ma l’attrattiva dei beni apparenti lo rende duro e pesante. In questo stato lui avrebbe bisogno di uno scossone salutare per liberarsene: “Tremate e non peccate”. Per essere liberato da un mondo fittizio e irreale egli ha bisogno di una percossa della verità. Dopo lo scossone che provoca alla conversione viene una calma riflessione che, in collaborazione con la grazia divina, apporta una modifica decisiva alla vita: “sul vostro giaciglio/ riflettete e placatevi”. Su questo problema importantissimo dell’apertura alla grazia e della durezza di cuore ciascuno di noi deve riflettere.
Dopo la conversione comincia una vita rinnovata, una vita totalmente rivolta a Dio. A questa vita nuova si riferisce l’ultimo consiglio del Santo salmista ai peccatori chiamati alla conversione e a un radicale rinnovamento della vita. Dice loro nel versetto 6: “Offrite sacrifici di giustizia/ e confidate nel Signore”.
Ecco un bel programma di vita rinnovata espresso in poche parole, due con solo “ sacrifici di giustizia”: sono tutti questi atti buoni che dobbiamo fare. Tutti hanno un valore religioso, sono “sacrifici”. Abbiamo qui una bella concezione della vita. L’uomo che compie i suoi doveri, l’uomo che fa la volontà di Dio, è un vero sacrificatore. La sua vita è un continuo offrire a Dio sacrifici graditi al Signore. Ma non meno importante è il secondo consiglio: “e confidate nel Signore”. Senza questo secondo neppure il primo si potrebbe adempiere. La fiducia in Dio deve pervadere tutta la nostra vita, tutti i nostri atti, giacché non possiamo fare niente di veramente salutare senza la grazia di Dio. Molte buone risoluzioni vengono meno perché non sono immerse nella potente grazia di Dio mediante una vera e profonda fiducia. Siamo di natura pelagiani incorreggibili. Ecco veramente un bel programma di vita proposta da un santo a peccatori desiderosi di conversione e di cambiamento di vita: “Offrite sacrifici di giustizia / e confidate nel Signore”.
Nel versetto 7 il Salmista introduce una obiezione umana contro il dovere di una vera conversione di vita: “Molti dicono: Chi ci farà vedere il bene?”
È una obiezione che si sente spesso ancora nei nostri tempi. Un dubbio sul vero bene, sul senso della vita umana, sulla retribuzione nella vita eterna, pervade l’umanità ancora oggi. Purtroppo si trova questo dubbio anche tra i cristiani. Questo dubbio, questa incertezza che si incontra nei cuori degli uomini fa male al cuore del Santo. Egli sente la sua incapacità di far passare la sua serena certezza di fede rinforzata dall’esperienza personale della bontà di Dio in questi cuori vacillanti. Si rivolge quindi a Dio in una ardente preghiera in favore del mondo non credente o fluttuante nella fede. È una preghiera bellissima che chiede l’unico ed essenziale rimedio per tutti, per tutta l’umanità ammalata che si dibatte nelle sue tenebre. “Risplenda su di noi, Signore / la luce del Tuo Volto!” Ecco la preghiera di Cristo per un mondo immerso nelle tenebre del peccato: “Risplenda su di noi, Signore,/ la luce del Tuo volto!” Non c’è altro rimedio, non c’è altra soluzione del problema dell’uomo. “Risplenda su di noi, Signore,/ la luce del Tuo volto!” Così anche un altro Salmo propone la soluzione del problema dell’uomo: “Dio degli eserciti, ristoraci;/ fa brillare il Tuo volto e saremo salvi!” (Sal 80, 8).
L’Uomo è creato per Dio, è creato per vedere Dio, e quindi la soluzione di tutti i problemi umani è il Volto di Dio, la rivelazione del volto di Dio come S. Giovanni dice nella sua prima lettera: “Sappiamo che quando si manifesterà, saremo somiglianti a Lui, poiché lo vedremo così come è” (1 Gv 3, 2). Ognuno di noi può con piena verità ripetere per se stesso questa ardente preghiera del Salmista: “Risplenda su di noi; Signore, / la luce del Tuo volto!”
Finito il suo discorso ai peccatori e la preghiera per loro il Santo si rivolge a Dio con un ringraziamento per il gran dono della gioia spirituale, della quale si sente ricolmo. È una gioia soprannaturale e misteriosa che non si può paragonare a nessun’altra gioia nel mondo. Per far risaltare il carattere imparagonabile e soprannaturale di questa gioia dice: “Hai messo più gioia nel mio cuore/ di quando abbondano vino e frumento”. La gioia della mietitura rappresenta ogni gioia umana naturale come gioia dell’abbondanza dei beni della Terra. Ma questa misteriosa gioia che riempie il cuore dell’uomo senza che egli sappia da dove viene, questa misteriosa gioia senza oggetto concreto che trasforma tutto in chiarore, questa è un dono di Dio: “Tu hai messo più gioia nel mio cuore”. È Dio solo che mette la sua gioia nel piccolo cuore della sua creatura. L’ultimo frutto della grazia di Dio è la pace profonda e la sicurezza sotto la protezione misericordiosa di Dio: “In pace mi corico e subito mi addormento:/ Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare”.
3. Salmo 23, 1-3 [25]
Il Creatore ha proprietà assoluta di tutto ciò che esiste, se l’esistenza stessa non è niente di più che l’effetto immediato d’un atto di volontà di Dio e non dura neppure un istante di più di questo atto. Tutto l’immenso cosmo, tutti gli esseri spirituali e materiali sono in ogni momento totalmente dipendenti dalla durata di questo atto che li ha chiamati dal non essere all’essere. Tutto questo ha fatto nostro Padre e tutto questo gli appartiene. Nella letteratura si incontra l’uomo che sente nell’universo come una forza nemica, terribile che lo fa sentire solo e abbandonato davanti a un mondo ostile e pericoloso. Tale atteggiamento non è cristiano. Questo universo è stato creato da nostro Padre e per noi le cose create sono beni di famiglia che ci fanno sentire a casa. Dunque:
Del Signore è la terra e quanto contiene, l’universo e i suoi abitanti (Sal 23, 1).
Il cristiano ama tutto questo e si sente, tra le creature, come nella casa paterna.
È Lui che l’ha fondata sui mari, e sui fiumi l’ha stabilita (Sal 23, 2).
I mari e i fiumi, come generalmente le grandi acque, significano potenze nemiche e pericolose. Si può dire dunque, pensando alla fondazione della terra, che Dio ha fondato la Chiesa sui mari e l’ha stabilita sui fiumi, che la forza divina ha dato alla Chiesa una stabilità miracolosa malgrado non ci sia nulla di stabile, e che l’essere naturale, tutto il mondo, si possono paragonare alle grandi acque dove tutto è fluido, niente è fermo, niente è stabile. Così, in questo mondo, la Chiesa appare come l’unico punto forte, l’unico punto stabile che Dio ha miracolosamente creato e fortificato e posto in mezzo a una realtà fluida che nulla ha di forte e stabile. Una tale visione della Chiesa nel mondo è impressionante e vera. Il Salmista mette in rilievo la misteriosa forza che mantiene la Chiesa nella forza di Dio, quando tutto è mobilità, cambiamento, debilità e inconsistenza.
Però possiamo dare un’altra interpretazione creando un’altra visione della Chiesa fondata sui mari e stabilita sui fiumi, considerando le grandi acque questa volta come simbolo della infinita abbondanza della grazia di Dio – Dio è il Bene infinito. Lui è il Ricco che fa tutto con una infinita generosità. Si può dunque insistere sull’infinita generosità di Dio e sull’abbondanza immensa della sua grazia. Dio fa tutto in modo divino, non si può esprimere con concetti umani ma, in parte, con simboli. Ciò che si dice della Chiesa si può anche riferire all’anima. L’anima è fondata e stabilita su grandi acque. E anche pensando all’anima le acque sono simbolo di forze selvagge elementari e ostili, simbolo della fluidità del mondo che non può dare alcun appoggio all’anima, ma le acque possono anche richiamare l’abbondanza delle grazie divine che inondano il cristiano in vita.
Chi salirà il monte del signore, chi starà nel suo luogo santo? (Sal 23, 3)
È vero, Signore, che Tu sei invisibilmente presente tra le Tue creature, ma Tu hai il Tuo luogo, infinitamente elevato, Tu abiti una luce inaccessibile. E nessuno può vedere Te e vivere. Come si può porre una tale questione: Chi salirà al monte del Signore, chi starà nel suo luogo santo? Il Salmo non solo pone tale quesito, ma dà pure una risposta! Questo è il centro meraviglioso del mistero cristiano: l’uomo abiterà nel luogo di Dio, abiterà in una casa con Dio, vivrà in Dio e di Dio. Questo è incredibile. Si deve dire che l’essenza del cristianesimo è costituita di incredibile!
4. Salmo 86 [26]
Salmo arduo e sublime. Canta il mistero della maternità universale di Gerusalemme. Di tutte le città del mondo, di tutte le città di Giacobbe la prediletta per il Signore è Gerusalemme, che i profeti hanno celebrato con mirabili vaticini sulla sua futura gloria.
Le sue fondamenta sui monti santi,/ Jahvé ama le porte di Sion/ su tutte le tende di Giacobbe/ cose gloriose si dicono di te/ città di Dio./ Posso citare Rahab e Babilonia fra i miei conosciuti,/ ecco i Filistei e Tiro con Cush/ questi è nato là!/ E di Sion si dice: “Questi e quelli è nato in essa;/ ed Egli la consolida, l’Altissimo./ Jahvé elenca nel registro dei popoli:/ questi è nato in essa./ E canteremo come danzatori:/ tutte le mie fonti sono in Te! (Sal 86, 1-7).
Ci sono state diverse città, diversi regni e imperi in questo mondo, imperi potenti suscitanti ammirazione tra gli uomini. Come l’Impero Romano con il suo spazio, con la sapienza delle sue istituzioni, con le sue leggi che ispirano ancora oggi legislatori moderni. L’Impero Romano ha potuto radunare molte nazioni sotto il suo potere e sotto il suo governo non solamente energico, ma anche prudente e misurato. Ma nel corso della storia del mondo, mentre diversi regni si succedono, Dio si costruisce una città, Dio si prepara il Regno definitivo. Gerusalemme come Città Santa, Città del Signore Dio, era soltanto un’immagine, un segno debole di questa somma realtà.
5. Salmo 92, 1-5 [27]
Il Signore regna, si ammanta di splendore; Il Signore si rivesta, si cinge di forza; rende saldo il mondo, non sarà mai scosso. (Sal 92, 1) Pensiamo al Regno di Dio, al suo splendore, alla sua gloria immensa. Essa è più reale in questo momento. Già posso vederla attraverso la fede, contemplarla, gioirla. Dobbiamo imparare a vivere di questa realtà invisibile (all’occhio), ma visibile alla fede. La nostra fede, già attraverso il velo, l’àncora della nostra speranza, già sta in questo splendore, già vive di questa potenza, di questa gioia invincibile. Tutto il mondo e le sue cose sono un soffio se paragonate a questa realtà così vicina e così nostra. Che cos’è tutta la nostra vita di fede se non una contemplazione continua della verità, della realtà invisibile ma presente, di questo splendore del Regno che è già nostro unico appoggio. L’educazione cristiana in stretta collaborazione colla grazia dello Spirito Santo non cerca altro che stabilire la nostra vita nella verità. Questa realtà che possediamo già invisibilmente per fede è il nostro unico appoggio, la nostra unica gioia, cioè la nostra vita è già un vero inizio della vita eterna. Se la nostra pedagogia non è questo, non è una vera pedagogia cristiana.
Questo Salmo è pasquale. Il Signore fu umiliato, oltraggiato, maltrattato, ucciso, ma ecco, Egli stesso regna, si ammanta di splendore: si rivesta, si cinge di forza. La Pasqua cambia tutto: ecco, sorge già un mondo nuovo, ma non come questo che un gran terremoto può distruggere, che uno scontro interplanetario può annientare. Il mondo nuovo – dice il Salmista – è differente: “Il Signore rende saldo il mondo, non sarà mai scosso” (Sal 92, 1). Ecco, scioglie davanti agli occhi della nostra fede un mondo eterno, un mondo in cui non esiste niente che non sia già avvolto dalla giustizia di Dio. Contempliamo con ammirazione il Re sul suo Trono celeste e diciamo: Saldo è il Tuo Trono fin dal principio, da sempre Tu sei! (Sal 92, 2)
Nella gioia della vittoria pasquale contempliamo il nostro Re vincitore. Ammirando la sua bellezza e la sua gloria il nostro cuore è rapito in una meditazione profonda. Riconosciamo nel Trionfatore pasquale il Re eterno, il Creatore delle cose visibili e invisibili e diciamo con vero stupore: “Saldo è il tuo trono fin dal principio, da sempre tu sei”! Noi abbiamo contemplato la Tua debolezza e la tua umiliazione, abbiamo visto la tua lotta terribile e la tua vittoria. Chi potrebbe capire che è vero anche questo: “Saldo è il tuo trono fin dal principio, da sempre tu sei”!
Alzano i fiumi, Signore, alzano i fiumi la loro voce, alzano i fiumi il loro fragore. Ma più potente delle voci di grandi acque, più potente dei flutti del mare, potente nell’alto è il Signore. (Sal 92, 2-4) Mi ricordo di aver contemplato la bellezza e la potenza del mare in Francia, nel punto in cui la catena dei Pirenei tocca l’Atlantico. La potente onda oceanica attaccava le rocce della costa. L’acqua infuriata entrando nella caverna della rupe faceva un fragore simile all’effetto di una grande bomba. La potenza delle grandi acque, meravigliosa e pericolosa, ha sempre impressionato l’uomo. Con questa immagine d’una forza infinita alla quale non si può resistere, nello scontro con la quale l’uomo può essere squarciato tra le rocce, il Salmista vuole aiutarci alla contemplazione della potenza irresistibile di Dio trascendente: “potente nell’alto è il Signore”. La parte finale sembra non appartenere a questo Salmo; pare scendere dalle alture a un tema più vicino alla vita umana:
Degni di lode sono i Tuoi insegnamenti, la santità si addice alla Tua casa per la durata dei giorni, Signore. (Sal 92, 5) Questo Signore, che si ammanta di splendore e di forza, che è trascendente a tutte le potenze create, in cui noi riconosciamo il Creatore eterno, non è rimasto nascosto nella sua trascendenza. Ciò che è grande è che Lui ha voluto scendere per insegnare agli uomini. Esiste dunque nel mondo un insegnamento di Dio, una saggezza trascendente a tutte le scienze, a tutte le filosofie, a tutte le conoscenze degli uomini. Oh uomo, cerca questa unica dottrina del tuo Dio! È il suo Amore che ha voluto fare questa opera straordinaria di scendere sulla terra per insegnarti la sua sapienza! Pensa che hai poco tempo, che la tua vita è breve, cerca, senza perdere tempo, di riempirti di questo insegnamento. Questo è il tesoro nascosto che un uomo trovò nell’agro e vendette tutto per comprare quell’agro. Non rimanere nella tua stoltezza avendo trovato la sapienza eterna!
Pensa che i Salmi devono salvarti strappando il tuo spirito dall’ambiente spirituale del mondo e dal suo relativismo essenziale per la contemplazione dei valori assoluti del Regno di Dio. La salvezza progressiva dell’uomo si fa per mezzo di una evasione dell’uomo, operata in collaborazione colla grazia di Dio, che opera come un rapimento dell’anima umana, vivente nel soggettivo, per stabilirla nell’ oggettivo e assoluto. Come guida in questo cammino il Salmo ci conduce a fissare la nostra mente e, a poco a poco tutta la nostra spiritualità, nei valori assoluti e immobili. Questa fuga della nostra anima dalla mobilità e relatività del mondo assomiglia alla fuga di Lot che gli angeli presero per mano tirandolo fuori da Sodoma, che doveva essere distrutta perché simbolo del sistema di valori mondani effimeri (1 Cor 7, 31). L’anima cristiana quindi deve trovare sempre più il gusto delle cose eterne, perché questa vita possa realizzare la sua destinazione che è il passaggio all’eternità. Molti cristiani non capiscono che tale è il senso della loro vita, ma i monaci devono capire le parole di San Paolo (2 Cor 4, 18).
Apprezzando la dottrina di Dio diciamo: “Degni di fede sono i tuoi insegnamenti, la santità si addice alla tua casa nella durata dei giorni, Signore”. Qualcuno potrebbe dire che non si devono insegnare queste cose, troppo sublimi, all’uomo che è un essere terreno... Ma qui espressamente il Salmo contraddice tale opinione dicendo: “la santità si addice alla tua casa”. Dio ha rivelato che noi siamo la casa di Dio e la casa di Dio esige la santità, allora è chiaro che tutti i membri della casa di Dio hanno bisogno di una dottrina sublime e devono essere educati nella contemplazione delle cose invisibili che sono eterne. È un imperdonabile sbaglio educare ad una dottrina terrena e non introdurre alla collaborazione con la potenza trascendente di Dio. “La santità si addice alla tua casa” già adesso “nella durata dei giorni di questa vita mortale”.
6. Salmo 130 [28]
Questo breve Salmo appartiene ai 15 Salmi “delle ascensioni”. Sono chiamati così probabilmente perché costituivano una collezione di canti che il popolo Ebreo cantava salendo, da ogni parte, verso la Città Santa Gerusalemme e il Tempio che era costruito a 740 metri di altezza. Queste grandi processioni verso la Santa Città si facevano tre volte l’anno, cioè nelle solennità principali: Pasqua, Pentecoste e Capanne, e in quei giorni il popolo si recava all’incontro del suo Dio Jahvé con grandissima gioia cantando Salmi. Queste salite in massa del Popolo Santo verso Gerusalemme e il Tempio, per incontrare Dio, udire la Sua parola e offrirGli sacrifici, erano colme di significato. In questi solenni pellegrinaggi, in queste grandi festività piene di gioia, la fede del popolo si rinforzava insieme con la sua coesione e unità. L’Amore di Dio cresceva e la coscienza comune di costituire il suo popolo privilegiato veniva rinvigorita.
Il nostro Salmo 130, appartenendo al gruppo di Salmi delle ascensioni, partecipa a questa atmosfera di gioia di appartenere a Dio e di poterLo così visitare nella sua casa per godere con Lui. Ma questo Salmo ha un accento speciale, una profonda spiritualità che sorprende essendo nel Vecchio Testamento. Noi monaci dobbiamo amarlo in modo particolare, perché in esso troviamo espresso, in modo perfetto, l’atteggiamento monastico, alla formazione del quale tende tutta la Regola di San Benedetto. Il Santo Patriarca non manca di citarlo:
Signore, il mio cuore non ha pretese né i miei occhi mirano troppo alto.
Non mi muovo tra cose troppo grandi
o troppo magnifiche per me.
Anzi, ho placato e acquietato la mia anima
come uno svezzato dalla madre,
come un bimbo tranquillo è il mio spirito in me;
Aspetta Israele Jahvé; da ora in eterno!
Il buddismo cerca la pace nel sopprimere tutti i desideri, il credente invece la trova nella piena e amorosa sottomissione a Dio. Il buddista non può condividere la soluzione cristiana perché non crede a un Dio personale, non ha quindi a chi far dono di se stesso, non trova a chi potrebbe dare tutto se stesso con tutti i suoi desideri e tutte le sue brame. Non trovando quindi in chi potrebbe amorosamente riposarsi, cerca di annientare se stesso per fuggire l’insopportabile dolore dell’esistenza. Il cristiano invece trova la soluzione nell’umiltà e nella fiducia piena di amore in un Dio personale.
Tutta questa sapienza si trova espressa nel nostro breve Salmo. Non bisogna annientare il desiderio, ma si deve dirigere bene. E come? Prima di tutto accettare i propri limiti. È questa una grande sapienza, un’autentica sapienza che tutta la natura creata osserva e insegna. Così piante e animali hanno le proprie dimensioni oltre le quali non si estendono; le membra di un corpo pure. Se un membro cresce oltre la propria misura, non è più perfetto, non è motivo di gloria, ma piuttosto di vergogna. Un naso di due metri di lunghezza non apporterebbe gloria al suo possessore. Il desiderio di grandezza, l’illusione del più è ciò che fa errare e soffrire l’uomo, inutilmente.
Del trattamento terapeutico del desiderio parla bene il Siracide: “Non ricercare ciò che è più alto di te; non scrutare ciò che ti è nascosto. Pensa a quanto ti è stato ordinato… Quanto più sei grande, tanto più umiliati e troverai favore innanzi a Dio ed Egli viene glorificato dagli umili! (Sir 3, 18. 21-22). San Benedetto nella sua Regola, nel sesto grado di umiltà, parla della contentezza del monaco: “Omni vilitate vel extremitate contentus sit monachus” (Cap. VII). Il monaco è contento – dice il nostro Santo Legislatore – perché sente sempre di aver ricevuto fin troppo.
Ci sono due atteggiamenti spirituali che importa discernere. Possiamo immaginare due pesci contemplanti l’immensità dell’Oceano. Il primo è triste perché vorrebbe inghiottire l’oceano e non lo può fare: può soltanto ritenere poche gocce d’acqua. L’altro invece non vuole inghiottire niente, contenere niente, possedere niente, vuole soltanto immergersi e così, perdendosi, gioire di tutta l’immensità dell’ Oceano non ritenendo nulla per sé. Questo è l’atteggiamento dei contemplativi. Anche nella vita monastica-eremitica può sopravvivere un certo spirito di carriera. Ma chi vuol essere importante perde la pace e non la può ritrovare. Monaci di questo genere rovinano la pace di intere congregazioni.
L’immagine del bimbo in braccio a sua madre è molto espressiva. Il bimbo è cosciente della sua debolezza, non cerca di liberarsi, non cerca di esser indipendente, di esser importante, vuol rimanere dove si trova, è placato e tranquillo, anche se svezzato: un’immagine bellissima e ispiratrice per la vita d’un monaco consacrato al Signore.
L’umiltà è piena di luce, piena di conoscenza di se stessa e di conoscenza di Dio. Con quel che so di me stesso – dice il Salmista – c’è poco da inorgoglirsi… Le “cose grandi” le fa solo il Signore. Con quale profondità e bellezza questo spirito si trova espresso nel cantico del “Magnificat” della Madre di Dio! Solo quando, riconosciuti e accettati i propri limiti come dimensione concreta del quotidiano cammino di perfezione, l’anima si sarà abbandonata, senza riserve, all’azione del Signore, solo allora sarà Lui la sua forza e la sua nuova e vera dimensione. Il paradosso della vita spirituale si trova in questo: solamente accettando i propri limiti si possono oltrepassare e si può così godere di ciò che non ha limiti.
7. Sul Libro dei Proverbi [29]
Gli Ebrei mostrarono di possedere dati eminenti nel genere sapienziale, in quella poesia didascalica, cioè il cui oggetto è la sapienza, ricercata direttamente o divulgata attraverso massime, sentenze, consigli ecc., redatti in prosa o in versi. Il termine sapienza per gli Ebrei non comprende un concetto unico, ma può indicare la virtù con la quale gli atti umani sono rettamente indirizzati al fine (i beni del corpo e della fortuna, i costumi), e allora abbraccia tutto il complesso delle virtù morali, poiché ha per base il timor di Dio, per strumenti la disciplina e la scienza, e come aiuto la prudenza, la riflessione e il consiglio. Si deve notare però che la sapienza ebraica non trae precetti e consigli dalla legge divina positiva o legge mosaica, ma dalla ragione, cioè dalla legge naturale e specie dall’esperienza: assomiglia alla filosofia etica e ne possiede perciò il valore universale. Nella legge mosaica erano già tramandate norme importantissime di vita retta e giusta; perciò qualche volta la sapienza viene identificata e personificata nella stessa legge mosaica, che in quel caso assurge a esempio e prototipo di sapienza. Ancora più importante però è la personificazione della Sapienza di Dio: la divina Sapienza, che è la sorgente di ogni saggezza e che risplende mirabilmente nelle opere della creazione, è presentata dagli autori sacri come persona che sta a sé e agisce indipendentemente da Dio.
Tutti gli esseri che Dio ha creato sono incarnazioni ed espressioni del suo pensiero e della sua volontà. In tutto l’universo si trova un ordine obiettivo e un senso, segno indubbio della Sapienza di Dio dalla quale tutto proviene. Tutto questo meraviglioso ordine dell’universo creato è una Parola di Dio all’uomo, una trasmissione del pensiero del Dio, dell’Amore che vuole condurre l’uomo e formarlo secondo la sua Sapienza eterna. Si può dire che già nell’ordine della natura l’uomo sarebbe condotto a una certa unione con il suo Creatore, poiché il suo compito sarebbe di inserirsi il più perfettamente possibile nell’ordine divino della creazione.
Gli esseri privi di intelligenza lo fanno, immancabilmente e perfettamente, ma l’uomo dovrebbe farlo con consapevolezza e libera volontà. I precetti della legge naturale sono dunque luoghi di incontro e mezzi di unione dell’uomo colla Sapienza di Dio Creatrice, cioè con Dio stesso. La sapienza dell’uomo è quindi una partecipazione della Sapienza creatrice di Dio, essa rende l’uomo capace di seguire le vie misteriose della Sapienza di Dio nel mondo e di sottomettere così alla Sapienza di Dio la propria condotta morale. Non si può dunque separare la santità e la giustizia dalla sapienza. Tutte e tre esprimono una sottomissione amorosa dell’uomo all’ordine divino dell’universo e una partecipazione dell’uomo all’operazione della Sapienza di Dio nel mondo.
Prima che si rivelasse il Figlio di Dio Incarnato come unica Sapienza, e prima che l’Universo fosse rapito nel turbine della vita Trinitaria, questa dottrina della Sapienza esprimeva bene il senso naturale e soprannaturale della vita e condotta umana. Tutto il Libro dei Proverbi costituisce una esortazione a vivere bene secondo i principi della sapienza per essere felice! Per primo ci colpisce il tono dell’esortazione divina, dove la grande serietà si mischia a una bontà e tenerezza paterna:
Figlio mio, non dimenticare le mie istruzioni/ e la tua mente conservi i miei precetti /poiché giorni lunghi, anni di vita/ e pace ti porteranno.
Bontà e fedeltà non ti abbandonino mai:/ legale al tuo collo,/ iscrivile sulla tavola del tuo cuore,/ così incontrerai favore e stima/ agli occhi di Dio e degli uomini (Pr 3, 1-4).
Gli ammonimenti di Dio sono pieni di una tenera carità, come un padre che ammonisce il suo figlio. Non c’è più nessuna aggressività, né amarezza, né irrequietezza, ma un desiderio ardente e pacifico di trasmettere il tesoro della sapienza e dell’esperienza paterna in un cuore giovane minacciato di leggerezza e di spensieratezza, esposto a numerosi errori, allo scopo di renderlo più forte e più sicuro nella via del Signore! Tutto qui respira la pace della verità tranquillamente posseduta, la pace che viene dall’inserimento nell’ordine obiettivo e assoluto di Dio e dell’universo, realtà indipendente da tutto ciò che può accadere. Ciò che è, è, ed è come è indipendentemente da tutto ciò che fanno e che vogliono gli uomini, indipendentemente da tutte le passioni che agitano questo mondo. La vera educazione è quella che radica lo spirito dell’uomo nell’ordine divino universale, nella verità che è insieme tenerezza e pace immensa.
Gli ammonimenti del Libro dei Proverbi possono essere considerati come modelli dell’ammonizione cristiana. Il loro clima di bontà e di pace sana le ferite dell’anima come un olio spirituale. Niente di aggressivo, niente di impaziente. Il maestro che ammonisce non lo fa solamente per compiere un dovere, ma lo fa per amore e con gran desiderio del bene del figlio a cui si rivolge. Non vuole soltanto farlo obbediente, ma sapiente e maturo. L’ammonimento è dunque una trasmissione di sapienza. Tutto ciò che Dio esige e comanda all’uomo è per il bene dell’uomo e per la sua felicità. Il gran desiderio del bene dell’uomo è la caratteristica della pedagogia divina nella Sacra Scrittura. Dio desidera che l’uomo con una piena consapevolezza e libertà scelga la via della sapienza. All’ordine che prende piuttosto la forma di un consiglio è giunta una promessa di un bene e della felicità, alla quale conduce la sottomissione a quell’ordine:
Figlio mio, confida in Jahvé con tutto il cuore/e non appoggiarti alla tua intelligenza./ In tutti i tuoi sentieri pensa a Lui/ ed Egli appianerà il tuo cammino./ Non essere saggio ai tuoi occhi,/ temi Jahvé e fuggi il male:/ sarà salute per il tuo corpo/ e ristoro per le tue ossa/. Onora Jahvé con i tuoi beni,/ con le primizie dei tuoi prodotti;/ allora i tuoi granai saranno ricolmi di grano/ e i tuoi tini traboccheranno di mosto./ Non disprezzare la disciplina di Jahvé figlio mio/ e non ti ripugni la sua repressione,/ perché Jahvé corregge chi ama/ e castiga il figlio più caro (Pr 3, 5-12).
Vi è una grandissima varietà di sentenze e di pensieri in questo Libro dei Proverbi. Ma ci sono due atteggiamenti principali, ai quali si riduce tutto, nel comportamento morale dell’uomo: la sapienza e la stoltezza. L’atteggiamento primo è essenzialmente religioso: riconosce Dio come Creatore, come assoluto Signore e anche come sorgente di ogni bene. L’atteggiamento secondo è essenzialmente irreligioso. Non vuol sapere niente di Dio e segue gli impulsi della sua natura corrotta. Come la benedizione della sapienza è di tutti i tempi, così è anche la tragedia della stoltezza dell’uomo. La stoltezza dei nostri tempi è specialmente pericolosa perché è non soltanto irreligiosa, ma pensa di aver trovato nella stessa sua irreligiosità una sapienza superiore.
Prendiamo adesso alcuni versetti del nostro Libro per ammirare la ricchezza e la varietà dell’insegnamento: In ogni luogo sono gli occhi di Jahvé e vedono i cattivi e i buoni (Pr 15, 3). Ecco la Sorgente della saggezza – “gli occhi di Jahvé”. Non basta controllare se stesso e vegliare sulla propria anima per essere sapiente. Se questa custodia dell’anima non sarà un confronto con Colui che è e che vede, non ci aiuterà a vincere la nostra debolezza e stoltezza. Sapiente si può essere soltanto vivendo in confronto con Dio. La tragedia dello stolto è nella carenza di questo confronto.
Una risposta calma acquieta l’ira,/ ma una parola pungente eccita la collera (Pr 15, 1). La parola calma è un frutto della sapienza e insieme la condizione. La parola calma ha una doppia azione sanante. Essa sana o conserva la salute di colui che parla, e sana colui a cui è indirizzata come un vero dono. Invece la parola pungente produce una doppia ferita. Vediamo qui che l’uomo sana gli altri sanando se stesso (una verità importante). Ci si deve quindi adoperare per calmare il nostro proprio interno, dominare le nostre proprie passioni, frenare i loro scatti esterni per arrivare alla parola calma e sanante. Nella nostra povera natura ammalata c’è molto veleno. Se non controlliamo le nostre reazioni spontanee, possiamo invelenire l’ambiente come un camino e ferire noi stessi e gli altri. Le reazioni spontanee non controllate sono caratteristiche della stoltezza. Il Libro dei Proverbi è poco utile per chi volesse leggerlo come altri libri “in lectione continua”. Ma scrutando un po’ le singole scritture, si può trovare una dottrina spirituale profonda e abbondante.
8. Lettera ai Filippesi [30]
Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù a tutti i Santi in Cristo Gesù che sono a Filippi con i vescovi e i diaconi. Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo (Fil 1, 1-2).
L’Apostolo Paolo è l’autore della lettera – associa il suo discepolo fedele Timoteo – non ha l’autorità dell’Apostolo – carattere fraterno della Chiesa – servi di Gesù Cristo – tutti sono servi (schiavi, doulej) di Gesù Cristo (cf. 2 Cor ) – 2 Pt: Servo e Apostolo – Giacomo – tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi. Santo dice più che cristiani. Il nome cristiano viene dai pagani di Antiochia che non conoscevano l’essenza del cristianesimo (partigiani di Cristo). I cristiani hanno conservato questo nome per amore del Cristo, dando un senso più profondo alla parola (unione con Cristo, pienezza) – Santi è più profondo = quelli che appartengono alla Santità di Dio, che sono dentro della sfera di Dio, che hanno ricevuto lo Spirito Santo. Fuori della sfera della santità c’è il mondo profano. Non si usa più questo nome per designare i cristiani (è peccato).
Con vescovi e diaconi evpiskopoi e presbu,teroi = superiori di chiese, terminologia ancora non stabilita definitivamente. Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. L’augurio buono precede ogni conversazione (così si dice in Colombia) – è umano e cristiano – la grazia di Dio e la pace (Cristo risorto). Augurio e dono? I cristiani possono comunicarsi a vicenda i beni che vengono da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo.
Ringrazio il mio Dio ogni volta ch’io mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi in ogni mia preghiera (Fil 1, 3-4).
Gioia e ringraziamento, saper gioire degli altri – coscienza della grazia.
a motivo della vostra cooperazione alla diffusione del Vangelo dal primo giorno fino al presente (Fil 1, 5).
La cooperazione alla diffusione del Vangelo è compito di ogni cristiano, immediatamente, quindi ogni cristiano è capace di maniera sua.
e sono persuaso che colui che ha iniziato in voi quest’opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù (Fil 1, 6).
Occhi aperti per vedere il bene di Dio, l’azione di Dio nelle persone – Dio ha iniziato, Dio porterà a compimento – nostra tristezza, pessimismo, scoraggiamento perché siamo pelagiani – giudicando gli altri – il giorno di Cristo Gesù.
È giusto, dal resto, che io pensi questo di tutti voi, perché vi porto nel cuore, voi che siete tutti partecipi della grazia che mi è stata concessa, sia nelle catene, sia nella difesa e nel consolidamento del vangelo. Infatti Dio mi è testimonio del profondo affetto che ho per tutti voi nell’amore di Cristo Gesù. (Fil 1, 7-8)
Questo passo è meraviglioso – la trasformazione interiore di S. Paolo – la potenza dell’amore – affetto trasformato nell’amore di Cristo Gesù – partecipi nella grazia (doppia)
E perciò prego che la vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni genere di discernimento perché possiate distinguere sempre il meglio ed essere integri ed irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quei frutti di giustizia che si ottengono per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio (Fil 1, 9-11).
Importanza della conoscenza di Dio. Ignoranza di Dio anche tra cristiani, tra religiosi e contemplativi (vergogna). Da questa conoscenza di Dio scrive ai Colossesi: “Non cessiamo di pregare per voi, e di chiedere che abbiate una conoscenza piena della sua volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore per piacergli in tutto” (Col 1, 9-10).
Di che conoscenza si tratta? 1. Arricchimento della carità; 2. Ogni genere di discernimento (a’’i[sqhsij) ed esperienza; 3. Volontà di Dio, il più perfetto. Relazione amore-conoscenza e la loro collaborazione. Tutto in preparazione per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia (per mezzo di Cristo). Tutto finalmente a gloria e lode di Dio.
Desidero che sappiate, fratelli, che le mie vicende si sono volte piuttosto a vantaggio del vangelo, al punto che in tutto il pretorio e dovunque si sa che sono in catene per Cristo (Fil 1, 12-13) [31].
Qui si deve dire qualche cose sulla prigionia di S. Paolo. Fino a pochi anni fa si pensava che S. Paolo avesse scritto questa lettera dalla prigione romana come le lettere agli Efesini, ai Colossesi e a Filemone. Oggi gli scienziati ammettono un’incarcerazione dell’Apostolo per breve tempo a Efeso durante il suo soggiorno in questa città negli anni 54 – 57. Fino a poco tempo fa si parlava anche solo di incarcerazione di S. Paolo a Cesarea (58 – 60), poi a Roma due volte, la prima volta per tre anni (60-63). L’Apostolo fu liberato nel 63 perché innocente. La sua prima detenzione a Roma non fu molto severa e non gli impedì i contatti apostolici. Liberato nel 63 compì alcuni viaggi dei quali sappiamo poco. Forse andò in Spagna come aveva progettato? La seconda volta fu imprigionato a Roma nel 67 e questo fu molto più grave. Nello stesso anno probabilmente morì martire di Cristo. Oggi si pensa che solo Efesini e Colossesi furono scritte nel carcere di Roma (durante la prima incarcerazione); invece Fiippesil e Filemone furono mandate dalla prigione di Efeso.
Può sembrare che questa teoria contraddica l’affermazione di S. Paolo nel v. 13: “al punto che in tutto il pretorio si sa che sono in catene per Cristo”. La presenza del pretorio sembra indicare Roma. La Bibbia di Gerusalemme dà il commento seguente: “Se S. Paolo scrive da Roma, si tratta della guardia pretoriana che si accampava presso le mura dell’Urbe. Se invece scrive da Efeso, bisogna allora pensare al personale del pretorio, e alla Residenza del governatore che si trovava in questa città”. Dunque non è necessario pensare a Roma e ci sono altri argomenti seri che fanno pensare piuttosto a Efeso.
L’Apostolo vuole che i fratelli di Filippi sappiano che la sua incarcerazione non ha cattivato la Parola di Dio e che, per l’azione provvidenziale di Dio, tutti gli impedimenti possono cambiarsi in mezzi, una fede indispensabile ai cristiani. Il cristiano ha una relazione speciale con l’impedimento quando si tratta dello sviluppo del vero bene. Ma ciò che l’Apostolo ci dice sull’atteggiamento di alcuni fratelli e le loro reazioni ha qualche cosa di strano. Questi versetti, come molti altri del NT, non ci permettono di idealizzare i primi cristiani. Certo molti erano pieni di fervore, ma i vizi delle natura umana caduta erano pure svegli e attivi. Vediamo ciò che ne scrive S. Paolo:
in tal modo la maggior parte dei fratelli, incoraggiati nel Signore dalle mie catene, ardiscono annunziare la Parola di Dio con maggior zelo e senza timore alcuno. Alcuni, è vero, predicano Cristo anche per invidia e spirito di contesa, ma altri con buoni sentimenti. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono stato posto per la difesa del vangelo. Quelli invece predicano Cristo con spirito di rivalità, con intenzioni non pure, pensando di aggiungere dolore alle mie catene (Fil 1, 14-17).
Un tratto positivo di questi giovani cristiani è che non sono stati scoraggiati dalle catene dell’Apostolo, ma al contrario, essi vi hanno trovato una sorgente di coraggio. La reazione ordinaria degli uomini è spesso contraria: quando è colpito il capo, tutti si rifugiano in una passività. Essi invece hanno mostrato l’amore di Dio e l’amore di Paolo.
Ma c’erano altri che agivano per invidia, spirito di contesa e rivalità, pensando di aggiungere dolore all’Apostolo perché lui non poteva predicare. Erano invidiosi perché non potevano uguagliarlo nella predicazione e pensavano di farlo soffrire suscitando in lui invidia. Invidia è il più diabolico dei vizi umani. L’invidia del diavolo ci ha fatto perdere il Paradiso. L’invidia è sorgente dell’odio.
La gelosia è più umana. Il geloso vorrebbe possedere il bene altrui, l’invidioso invece vorrebbe distruggere il bene e il suo possessore. L’invidia di Caino ha introdotto il primo omicidio nel mondo. Se Caino fosse stato solo geloso, avrebbe forse cercato di imitare il fratello per uguagliarsi a lui… Ma l’invidia non vuole imitare, vuole sopprimere il migliore assieme al suo bene. L’invidia dei fratelli di Giuseppe ha ispirato la sua vendita in Egitto, l’invidia di Saul ha generato il suo odio implacabile contro Davide…
I movimenti dell’invidia che possono essere presenti anche nelle anime avanzate nella vita spirituale, mostrano la profondità della nostra ferita spirituale, rivelano l’abisso del male che resta ancora nell’anima che Dio solo può salvare. L’invidia non sopporta la superiorità altrui, la perseguita, la vuole distruggere. Essa perseguita il bene divino negli uomini; ucciderebbe Dio, se potesse. L’invidia ha aspettato migliaia di anni che Dio si facesse mortale per ucciderlo (Mt 27). La parabola sugli operai nella vigna mette in risalto l’invidia. Il proprietario della vigna non ha fatto torto a nessuno. Tutti hanno ricevuto il salario convenuto, ma erano scontenti e mormoravano non perché avevano ricevuto troppo poco, ma perché gli ultimi avevano ricevuto una ricompensa uguale alle loro; non volevano ricevere di più, ma che gli altri ricevessero di meno. Ecco l’invida che il proprietario della vigna smaschera con queste parole: “Perché guardi con male occhio che io sono buono?” (Mt 20, 15). Per questo la nostra lotta contro l’invidia deve essere una “guerra totale”. Non possiamo permetterci un solo sentimento macchiato da questo vizio orribile. Non solo sopportare ma amare la superiorità altrui è un segno di carità molto generosa (S. Giovanni della Croce?).
La situazione umana di Paolo è un po’ complicata, ma lo spirito di Paolo, reso semplice per l’amore di Cristo, è l’assoluta fiducia in Dio. Non si ferma a tutte queste complicazioni degli uomini, ma con un colpo d’ala le trascende tutte e raggiunge la pura luce di Dio.
Ma questo che importa? Purché, in ogni maniera, per ipocrisia o per sincerità, Cristo venga annunziato, io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene. So infatti che tutto questo servirà alla mia salvezza grazie alla vostra preghiera e all’aiuto dello Spirito di Gesù Cristo. Secondo la mia ardente attesa e speranza che in nulla rimarrò confuso; anzi nella piena fiducia che, come sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia che io muoia (Fil 1, 18-20).
Le cose umane non lo interessano più. Come ha scritto ai Romani, “noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio” (Rm 8, 28). Adesso vive intensamente questa verità: “So infatti che tutto questo servirà alla mia salvezza grazie alla vostra preghiera e all’aiuto dello Spirito di Gesù Cristo”. Egli è cosciente che sia la preghiera dei cristiani che lo stesso Spirito di Cristo contribuiscono a questo unico, che lui stesso desidera con tutte le sue forze: “Secondo la mia ardente attesa e speranza che in nulla rimarrò confuso; anzi nella piena fiducia che, come sempre, anche ora, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia”. Parla molto della purezza del cuore. Ma quando si ha la purezza del cuore? Vediamo. Se l’unica e ardente attesa dell’anima è che Cristo sia glorificato nel corpo, sia che viva sia che muoia, possiamo dire che si ha una perfetta purezza del cuore. Nulla si può opporre a un cristiano così. Egli realizza invincibilmente ciò che vuole, malgrado tutti gli impedimenti che diventano mezzi, perché ciò che vuole è la gloria di Cristo.
Il versetto 21 spiega questa forza invincibile: Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa debbo scegliere. Sono messo alle strette infatti tra queste due cose: da una parte il desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; d’altra parte è più necessario per voi che io rimanga nella carne. Per conto mio, sono convinto che resterò e continuerò a essere d’aiuto a voi tutti, per il progresso e la gioia della vostra fede, perché il vostro vanto nei miei riguardi cresca sempre più in Cristo, con la mia nuova venuta tra voi (Fil 1, 21-26).
Per me il vivere è Cristo [32]. Questa formula breve e forte esprime la perfezione e la pienezza della vita cristiana. Non è solo imitazione di Cristo. L’imitazione suppone che ci siano due figure, suppone una certa distanza tra il modello e colui che lo imita. Sì, è vero, nell’imitazione gli occhi sono sempre rivolti verso il modello. Ma per San Paolo la distanza è ancora troppo grande. Egli vuole vivere il Cristo stesso, vivere in unione perfetta con Lui, sparire in Lui. Egli cerca la mistica identificazione con Cristo, perché l’ideale cristiano si trova a questo livello, come vedremo nel capitolo terzo. Questo è già perfezione.
È notevole come la Chiesa conduca i suoi figli a questa perfezione. La Liturgia della Chiesa, che ci educa a vivere cristianamente, mostra in sé come una ossessione di Cristo. Che cosa ci insegna la Chiesa nella sua Liturgia se non questa ossessione di Cristo? Di Lui parla l’Avvento, di Lui il Tempo di Natale, di Lui il Tempo Pasquale. Che cosa è la Quaresima se non la nostra partecipazione alla Sua Croce e l’attesa della sua Risurrezione? Anche il Tempo Ordinario è pieno di Cristo. Ogni giorno si celebra la Santa Messa per unirci con Lui e in Lui, per morire con Lui e per vivere con Lui, fin da ora, nella partecipazione alla Sua gloria eterna. Troviamo Gesù Cristo nei salmi e nelle letture del Vecchio Testamento. I Padri ne parlano, qualunque sia il tema dei loro discorsi. L’Amore li fa riferire sempre a Cristo, come se non potessero parlare di altra cosa. La formazione di questa mentalità costituisce l’autentica formazione del cristiano.
Nei salmi – malgrado i commentari dei biblisti scienziati – l’amore della Chiesa trova sempre il suo Cristo. Ecco ciò che leggiamo in un giorno feriale del Tempo Ordinario. Si tratta del commentario di Sant’Ambrogio sul Salmo 1: “Bevi dunque il calice di cui il profeta “disse: Il Tuo calice inebriante, quanto è buono!” Bevi l’uno e l’altro calice, quello dell’Antico e quello del Nuovo Testamento, perché in ambedue bevi Cristo. Bevi Cristo che è la Vita, bevi Cristo che è la pietra da cui scaturì l’acqua. Bevi Cristo che è la fonte della vita; bevi Cristo perché Egli è il fiume che allieta la Città di Dio; bevi Cristo che è la pace; bevi Cristo perché fiumi di acqua viva spargeranno dal tuo seno. Bevi Cristo per dissetarti col sangue da cui sei stato redento, bevi la sua Parola; sua Parola è l’Antico e il Nuovo Testamento. Si beve la Sacra Scrittura, anzi la si divora, quando fluisce nell’anima e le dà vigore la linfa del Verbo eterno”. In questo spirito, in questa santa ossessione di Cristo la Chiesa vuole formarci. È necessario deporre lo spirito mondano per poter ricevere questa formazione, questa ossessione di Cristo che, arrivando alla sua maturità, dice in San Paolo: “Per me vivere è Cristo”. È giusto quindi insistere sulla pedagogia liturgica della Chiesa che, per coloro che la seguono, è molto efficace per sviluppare questa visione e questo amore di Cristo che trasforma il cuore. Ma seguiamo il testo di S. Paolo.
Per me il vivere è Cristo, e il morire un guadagno (Fil 1, 21)
Come non sarebbe un guadagno il morire per chi vive così? Per l’Apostolo la morte significa l’unione perfetta con Cristo, nella visione. San Paolo pensa alla vita eterna con Cristo: per lui seguirà immediatamente dopo la morte. Quelli per i quali, ancor vivendo in questo mondo, Cristo è veramente la vita, non necessitano di una ulteriore purificazione dopo la morte: essi sono già maturi per la perfetta unione con Cristo. La morte per loro è quindi un guadagno.
Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa debbo scegliere. Sono messo alle strette infatti tra queste due cose: da una parte il desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; d’altra parte è più necessario per voi che io rimanga nella carne. Per conto mio, sono convinto, che resterò e continuerò ad essere d’aiuto a voi tutti, per il progresso e la gioia della vostra fede, perché il vostro vanto nei miei riguardi cresca sempre più in Cristo, con la mia nuova venuta tra voi (Fil 1, 22-26).
Che pensare di questo? È lecito all’uomo rinunciare alla propria salvezza per i fratelli? No. Questo non si può fare. Nessun essere può rinunciare al fine ultimo per cui è stato creato, sarebbe un disordine essenziale che Dio non può volere. La vita eterna con Dio è per ciascuno di noi la volontà di Dio indiscutibile. Il fine dell’uomo, stabilito da Dio, è la visione di Dio stesso per tutta l’eternità, come dice San Giovanni: “Noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremmo così come Egli è” (1 Gv 3, 2). L’uomo non può rinunciare, nemmeno per carità, a ciò che è l’eterna e immutabile volontà di Dio per lui. Come dunque possiamo capire ciò che San Paolo scrive ai Romani (9, 2), che sarebbe pronto a rinunciare perfino alla sua salvezza per il suo popolo Israele? “Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne?” (Rm 9, 3). In queste parole egli esprime il suo grande amore per il suo popolo e la sua profonda tristezza a causa della infedeltà degli Israeliti. Però non dice “voglio”, ma dice “vorrei” in condizionale, che si interpreta: “se fosse possibile questo, se fosse conforme alla volontà di Dio”. Nella nostra epistola San Paolo non rinuncia alla sua salvezza, ma, per il bene dei suoi fratelli, rinuncia a godere immediatamente della perfetta unione con Cristo. Questo è accettabile.
Però la nostra situazione è diversa da quella dell’Apostolo. Noi non abbiamo nessuna certezza della nostra salvezza. È un bene pensare a questo. Nella stessa Lettera ai Filippesi, San Paolo, che parlava della sua salvezza come di una cosa certa, ci esorta dicendo: Attendete alla vostra salvezza con timore e tremore (2, 12). Occorre avere una visione realistica di queste cose. Questo è oggi tanto più importante, poiché i cristiani moderni non sentono più la serietà di questi problemi. È spaventoso constatare con quale facilità e leggerezza i cristiani promettano oggi la vita eterna a coloro a cui Dio non la promette, ma al contrario, li minaccia di dannazione. È cosa caratteristica che quanto più negligente è l’uomo, quanto più disprezza i comandamenti di Dio, tanto più facilmente si promette la salvezza. “Perché Dio è Amore Misericordioso e non può rigettare nessuno, anzi sarebbe una sconfitta dell’amore di Dio, se un solo uomo si perdesse”. Questa “doctrina daemoniorum” si è fatta oggi quasi universale tra i cattolici. Però un altro fatto deve far pensare: i cristiani veramente santi hanno il timore di Dio e non pensano così. I santi pensano all’inferno con grande serietà. Essi che conoscono la Misericordia di Dio molto meglio degli altri (come per esempio la Beata Sr. Faustina, Apostola della Misericordia Divina) credono che il peccato grave meriti la pena eterna, come insegna la Scrittura e la Chiesa. Così ha parlato anche la Santissima Vergine nelle rivelazioni di Fatima.
Tutti quelli che hanno della Misericordia di Dio una conoscenza più profonda temono la pena dell’inferno per gli uomini. E chi ha conosciuto la Misericordia divina (che è un Mistero) meglio di Cristo che, molto chiaramente e più volte, parla dell’inferno? Ma noi, cristiani di oggi, sappiamo meglio di tutti questi e di Cristo stesso. Noi sappiamo che la perdita di un solo uomo sarebbe una sconfitta dell’Amore di Dio, e questo non si può pensare. Perché non si può pensare? L’Onnipotenza non può avere sconfitte, ma l’Amore sì. Egli non entra per forza, ma bussa alla porta. Dio non vuole salvarci senza la nostra volontà e la sua collaborazione. Egli non vuole trattare l’uomo come un pacco che si spedisce con indirizzo “cielo”. L’Amore può avere delle sconfitte perché è infinitamente delicato, non rassomiglia in niente ad una forza brutale. Si dimentica che gli angeli caduti erano anche oggetto dell’amore di Dio e di una sublime vocazione e caddero nell’abisso dell’odio perché lo vollero e la loro dannazione è dogma di fede. Viviamo dentro il Mistero di Dio che non comprendiamo, è dunque pericoloso prometterci ciò che Dio non ci promette.
Quando muore un cristiano non dobbiamo dire (come si sente spesso) che sta già in cielo. Preghiamo per la sua anima. Penso che S. Francesco di Sales disse una volta: “Quando morirò, non fatemi troppo presto Santo, perché mi lascerete troppo tempo in Purgatorio”. Che la nostra teologia sia seria, sia quella della S. Scrittura e della Chiesa, e non sia come quella del mondo che con una leggerezza spaventosa vuole sostituire la sapienza di Dio. Abbiamo questo atteggiamento nei nostri contatti coi secolari. Oggi, in un mondo più peccatore che mai, neppure i predicatori osano parlare della morte eterna che è il frutto naturale del peccato (Rm 6, 23). S. Paolo consente di fare un gran sacrificio per i suoi fratelli, ma spera che anche essi vorranno fare un grande sforzo per andare avanti:
Soltanto però comportatevi da cittadini degni del Vangelo perché nel caso che io venga e vi veda o che da lontano senta parlare di voi, sappia che state saldi in un solo spirito, che combattete unanimi per la fede del vangelo, senza lasciarvi intimidire in nulla dagli avversari. Questo è per loro un presagio di perdizione, per voi invece di salvezza, e ciò da parte di Dio: perché a voi è stata concessa la grazia non solo di credere in Cristo, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo la stessa lotta che mi avete veduto sostenere, e che ora sentite che io sostengo (Fil 1, 27-30).
S. Paolo esorta i cristiani a comportarsi come cittadini degni del Vangelo. “Cittadini” – il cristiano è cittadino del Regno di Dio, nel quale vige la legge del Vangelo. Una tale esortazione non ha niente di speciale, si può dire che sia ovvia. Che cosa infatti dovrebbero fare i cristiani se non vivere secondo il Vangelo? Purtroppo questa cosa, in sé evidente, non è evidente oggi. Quale parroco di oggi inculca ai suoi parrocchiani l’obbligo di vivere secondo il Vangelo, cioè di cercare la perfezione evangelica? La situazione sta forse già migliorando, perché lo Spirito Santo fa scaturire oggi non poche sorgenti di acqua cristallina (vita evangelica) nel deserto di questo mondo. Ma ancora adesso un cristiano che seriamente vuole essere fedele al Vangelo è considerato come un cristiano eccezionale. Cristo non è il maestro della maggioranza dei cristiani. C’è differenza tra un uomo buono, fedele ai principi morali e ai suoi doveri, e un cristiano che, in tutto ciò che fa, cerca l’ispirazione nel Vangelo.
Saldi in un solo Spirito (Fil 1, 27)
È certo una esigenza grave per giovani cristiani recentemente convertiti. Ma Paolo non sembra prendere questo in considerazione, non prevede tappe nelle esigenze cristiane. Si deve prendere il dono della vita cristiana nella sua integrità. Sembra che per S. Paolo la vita cristiana sia una realtà indivisibile, da accettare interamente: tutto o niente. Abbiamo perduto questa visione totalitaria del cristianesimo, la visione del puro Vangelo senza miscugli con altre ispirazioni (nostro astrazionismo). Quando si vede il cristianesimo come una “realtà viva” (per me vivere è Cristo), si capisce l’impossibilità dei compromessi, si deve ammettere che non c’è cristianesimo vivo senza questa esigenza: Saldi in uno Spirito.
che combattete unanimi per la fede del Vangelo (Fil 1, 27)
Abbiamo perduto e l’unanimità e la combattività per la fede del Vangelo. Oggi si desidera che tutto sia fiacco, altrimenti si è accusati di intolleranza. Si deve lasciare che ciascuno pensi ciò che vuole. Più pericolosa delle false dottrine è questa fiacchezza generale. Allora niente è importante, niente è assoluto. Tutto è relativo e il valore supremo non è la verità ma la tolleranza. Lo spirito moderno è contrario a ogni lotta (abisso di neutralità). Non si può colpire perché tutto è morbido. Non c’è niente di duro. Per la lotta é invece essenziale.
********************************************************************************************************************************
Piccola Sorella Magdeleine Hutin e Padre Pietro Rostworowski
Storia di un’amicizia
Piccola Sorella Magdeleine Hutin (1898-1989) e Padre Pietro Rostworowski (1910-1999) si incontrarono per la prima volta nell’estate del 1957 e col tempo crebbe tra loro una vera e profonda amicizia che durò oltre 32 anni. Questa storia è bella, affascinante e ormai è ricchezza della chiesa e della sua spiritualità del ventesimo secolo; testimonia una comunione profonda nella ricerca di Dio e dell’ascolto della sua Voce. La storia si potrebbe imperniare più sulla persona di Piccola Sorella Magdeleine – in tal caso Padre Pietro apparirebbe come uno dei tanti, tantissimi “piccoli e grandi” nel cosmo delle relazioni di questa donna straordinaria. Ma in questo saggio l’accento viene spostato più su Padre Pietro e la storia qui raccontata segue i suoi passi, anche se, paradossalmente, tutte (o quasi tutte) le informazioni su quest’amicizia provengono da Piccola Sorella Magdeleine (dai suoi diari e dalle sue lettere) e Padre Pietro è sì presente ma piuttosto tace[33]. Tutto è stato descritto da Piccola Sorella, è lei che ci racconta di Padre Pietro e lui emerge nel raggio dello sguardo di questa donna. Ma d’altra parte, essendo l’amicizia una relazione, in questa storia emergono ambedue e, in mezzo a loro, c’è l’Amico degli uomini e il Salvatore del genere umano.
I primi contatti
Piccola Sorella Magdeleine era più anziana di Padre Pietro di dodici anni e quando si incontrarono nel 1957, lei aveva 59 e lui 47 anni. In quegli anni Sorella Magdeleine fondava un nuovo ordine, che seguendo le intuizioni di Charles de Foucauld, godeva già di un certo riconoscimento e si sviluppava in modo assai dinamico. Ella nel tempo, come fondatrice seminava e visitava le sue nuove comunità in diversi continenti – superando anche la “cortina di ferro” che in quei tempi divideva l’Europa. Nel 1956 il Vicariato ha consentito la fondazione della “casa generalizia” sui terreni dell’abbazia dei trappisti di Tre Fontane. Padre Pietro invece aveva alle spalle oltre un quarto di secolo di vita monastica, di stampo benedettino, vissuta in Belgio (il monastero di San Andrea a Brugge), a Roma (Sant’Anselmo) e in Polonia (il monastero di SS. Pietro e Paulo a Tyniec vicino a Cracovia) di cui in quegli anni svolgeva tra l’altro la funzione di superiore.
Nel 1956 la politica e la vita in Polonia, fino ad allora dominata da un forte terrore stalinista, si cambiò avviando alcune aperture e riforme. Fu pertanto possibile, anche ad un ecclesiastico come Padre Pietro Rostworowski, ottenere i permessi necessari per recarsi a Roma passando per il Belgio, dove si trovava la “casa madre” del suo monastero polacco. Il suo viaggio durò dal 24 aprile al 27 luglio del 1957. Fu così che il 20 giugno 1957 apparve a Tre Fontane. Era il giorno in cui Piccola Sorella Magdeleine presentava di fronte a diverse persone della chiesa di Roma il suo nuovo progetto delle così dette “sorelle trubadure”. Non si sa perché e come Padre Pietro fosse arrivato proprio in quel giorno e per quella occasione a Tre Fontane. Forse voleva incontrarsi con l’allora Abate Generale dei Trappisti Dom Sortais che era presente? Forse cercava di vedere qualcun altro? O desiderava vedere e incontrare la comunità delle Piccole Sorelle e la sua fondatrice di cui sicuramente aveva sentito parlare? Oggi non siamo in grado di fornire una risposta a queste domande. Sappiamo solo che questo monaco apparve a Tre Fontane proprio in quel momento seminando pure un certo sconcerto (alcuni pensarono che fosse una “spia comunista” perché nonostante i cambiamenti avvenuti nell’est europeo, in Occidente si riteneva quasi impossibile attraversare “legalmente” la cortina di ferro e arrivare semplicemente a Roma). Non sappiamo nemmeno di che cosa avessero parlato Piccola Sorella Magdeleine e Padre Pietro. Di vita religiosa tradizionale e di quella nuova di cui la chiesa e il mondo avevano bisogno? Della situazione politica e della chiesa nell’est europeo?
L’unica cosa che abbiamo a disposizione è la foto in cui, di fronte agli edifici della comunità delle Piccole Sorelle a Tre Fontane, tra altre presenze ci sono proprio Piccola Sorella Magdeleine e Padre Pietro che conversano insieme. Lui nell’abito benedettino, con la testa leggermente inchinata getta lo sguardo in basso e lei che, appoggiata alla colonna del tetto, apertamente fissa il suo volto. Accanto a loro, forse partecipe del dialogo sta qualche sacerdote e ancora, vicino, un vescovo che guarda un cane tenuto da un altro prete. Tutto qua. Né Sorella Magdeleine né Padre Pietro in quel momento avrebbero potuto prevedere che quell’ incontro sarebbe stato l’inizio di una lunga e bella amicizia spirituale che sarebbe durata oltre 30 anni facendoli incontrare più di trenta volte in diverse occasioni e luoghi del mondo.
Due anni più tardi Piccola Sorella Magdeleine è di nuovo nell’est europeo per visitare le sue comunità e per prendere contatto con diverse persone della chiesa. Il 4 luglio del 1959 si incontra a Cracovia con il vescovo Karol Wojtyła e il filosofo di Varsavia Stefan Swieżawski. Cinque giorni dopo (9 luglio 1959), indirizzandosi ormai verso la Germania dell’Est, la troviamo ancora a Silesia nella città di Wałbrzych, dove si incontra con il vescovo Kominek di Wrocław e con Padre Tadeo Fedorowicz di Laski (vicino Varsavia). A questo incontro partecipa Padre Pietro e la Piccola Sorella annota nel suo diario (5 luglio 1959) la presenza de: “l’anziano priore dei benedettini di Tyniec”. Non si sa perché Padre Pietro sia stato chiamato “anziano” (aveva solo 50 anni) – forse perché appariva come un “anziano” o perché questa era ormai una “vecchia” conoscenza? Nei diari di Sorella Magdeleine non si trova niente di più riguardo a Padre Pietro. Il clima di questi incontri è segnato da clandestinità –persone che si ritrovano spostandosi in luoghi diversi, forse per sfuggire agli occhi della polizia (sono i tempi del comunismo in cui la vita ecclesiale è sempre ostacolata e le fondazioni di nuove comunità religiose sono vietate). Il nome di Padre Pietro è solo scrupolosamente segnato nel diario. Si può pure pensare che in questo periodo, considerando anche la presenza di altre personalità della chiesa polacca del tempo, dovevano ormai cadere tutti i pregiudizi su Padre Pietro come “spia comunista”. Dallo stesso anno (1959) si è conservata poi una lettera scritta da parte di Padre Pietro a Piccola Sorella Germane, una delle prime presente nelle fondazioni in Polonia, in cui risulta che già in questo tempo Padre Pietro ha capito molto bene il carisma della Fraternità delle Piccole Sorelle – ne aveva una intuizione profonda e corretta che sicuramente è stata pure alla base della fraintesa tra lui e Magdaleine.
La svolta
Una svolta radicale nel rapporto tra Piccola Sorella Magdeleine e Padre Pietro avviene nell’autunno del 1961 – più esattamente nel loro incontro del 9 settembre. È uno degli eventi più interessanti e pittoreschi della storia qui ricostruita. Un gruppo delle Piccole Sorelle tornando da un viaggio in Polonia, si dirigeva, in macchina, dalla città di Toruń attraverso Poznań, verso la Germania dell’Est. Partite la mattina presto non sapevano se là sarebbe stato possibile ricevere l’eucaristia. Ad un certo momento videro una persona sulla strada che agitando le mani cercava di fermare la loro auto. Come scrive Piccola Sorella Magdeleine: “Non credevamo ai nostri occhi riconoscendo in quella persona il Padre Piero, benedettino, che ci sorprese a Tre Fontane arrivando alla presentazione ufficiale delle Piccole Sorelle trubadure… E poiché lui è molto spiritoso, ci raccontò qualche storiella, a cui di fatti non abbiamo dato credito, e con cui lui stesso cercava di spiegare la sua presenza sulla strada proprio nel momento del nostro passaggio. Rimanemmo però molto contente che lui viaggiasse con noi”[34].
Questo frammento richiede un breve commento. Soprattutto sorprende l’atmosfera di una certa misteriosità. Magdeleine incontra Padre Pietro per la terza volta nell’arco di quattro anni ed ecco in questo momento si rende conto che una delle caratteristiche di questo uomo è il fatto di “apparire”. Non si sa né da dove né perché ma Padre Pietro “appare”. Piccola Sorella nota una analogia tra la sua “apparizione” in Tre Fontane e quella avvenuta ora sulla strada da Toruń a Poznań. Lei ha pure l’impressione che queste “apparizioni” avvengono sempre in mezzo a “qualcosa” di importante che si svolge: a Tre Fontane c’era la presentazione delle sorelle trubadure, qui il viaggio e una mancata eucaristia. La percezione di questa donna è duplice. Da una parte, secondo lei, Padre Pietro appare quando succede qualcosa di provvidenziale e d’altra parte proprio la presenza di questo monaco impregna la situazione con lo stigma della provvidenza e della presenza divina. Da ora in poi sempre Padre Pietro sarà visto in questa prospettiva, cioè come uno che appare carico della presenza divina mettendo tutta la situazione sotto la luce di una misteriosa provvidenza di cui tutti insieme si sentono “complici”.
Ma il racconto descritto nel diario prosegue: “Lui ci chiede dove andiamo… E noi rispondiamo che andiamo alla casa delle suore del Sacro Cuore. E poiché anche lui non ha celebrato la Messa in questo giorno, si combina tutto così che tre ore dopo la nostra prima colazione (consumata in automobile - MB) possiamo ricevere la comunione. Ma durante la Messa celebrata da lui, veniamo colpite dalla sua omelia, detta in francese, in cui collega l’eucaristia e la spiritualità della nostra fraternità, parlando di questo Sacramento come della fonte dell’unità e del Signore ormai sempre vittorioso sopra tutte le divisioni che di fatti sono nient’altro che mere apparizioni… Ci fermiamo con lui presso le suore di Sacro Cuore e poi ripartiamo verso la frontiera…”
Nel convento delle suore di Sacro Cuore di Poznań succede ancora qualcosa di importante. Le Piccole Sorelle e Padre Pietro celebrano insieme l’eucaristia e lui tocca i cuori di queste donne per il modo con cui celebra, come un predicatore commovente che con una profonda conoscenza spirituale parla di Cristo, dell’unità e dell’eucaristia. Da questo momento Padre Pietro diventa una persona importante e significativa non solo per la Piccola Sorella Magdeleine, ma attraverso di lei anche per tutta la comunità delle Piccole Sorelle. Purtroppo non siamo in grado di dire chi sia stata e chi sia diventata col tempo Sorella Magdeleine per questo monaco. Sappiamo solo che si è rinforzata l’amicizia e d’ora in poi cercheranno di incontrarsi quando possibile. Il loro contatto fu anche mediato dal fatto che Padre Pietro in qualche modo estese il suo interesse e la sua cura spirituale sul gruppo di Piccole Sorelle che, in quei tempi, si radicò sempre di più in Polonia. Spesso era Padre Pietro che andava ad incontrare Piccola Sorella Magdeleine quando si trovava nelle sue vicinanze. Lei invece, da parte sua, scrupolosamente annotava questi incontri nei suoi diari. E così sappiamo che ambedue si incontrarono la sera del 31 agosto 1963 nel monastero delle benedettine in Varsavia e ancora nell’anno seguente (30 luglio 1964) a Laski vicino alla capitale della Polonia. Ma i diari di Magdeleine non dicono niente di più oltre il tempo e il luogo dell’ncontro.
Una nuova tappa
Purtroppo questa catena di incontri regolari tra Magdeleine e Pietro viene interrotta per sei anni. Piccola Sorella Magdeleine in questo periodo visita alcune volte le sue comunità in Polonia, ma non può incontrarsi con Padre Pietro la cui vita ha subito alcuni bruschi cambiamenti. Tra il 1964-1967 Padre Pietro viene rinchiuso in prigione e poi, spinto dalle autorità ecclesiali, si lega con i due eremi camaldolesi (Bielany vicino Cracovia e Bieniszew nella parte centrale ovest della Polonia) cambiando in seguito appartenenza all’ordine religioso (da benedettino diventa camaldolese). Quando nuovamente si incontrano nell’estate del 1970, Piccola Sorella Magdeleine è ormai una settantenne, ben riconosciuta fondatrice di un nuovo e prominente ordine religioso sparso in tutto il mondo. Padre Pietro invece appare nell’abito bianco con una lunga barba e segnato da un ingiusto processo e imprigionamento, e dal peso delle nuove esperienza causate dal cambio della famiglia religiosa. Nonostante il contrasto: Magdeleine spazia i continenti e Pietro costretto a limitarsi nella cella (prima quella della prigione e poi quella dell’eremo), ambedue hanno la grazia e la forza di incontrarsi e i sei anni della “separazione” non hanno indebolito per niente la loro amicizia. Paradossalmente poi, nonostante l’età e l’appartenenza di Padre Pietro ad un ordine eremitico, cresce la qualità e la frequenza dei loro incontri. D’ora in poi si vedranno quasi ogni anno – sempre “in via” – in diversi posti del mondo.
Nel 1970 Piccola Sorella Magdeleine si reca, in Unione Sovietica, passando attraverso la Polonia. Durante il viaggio sosta a Laski vicino a Varsavia, dove allora si trovava anche uno dei centri delle Piccole Sorelle frequentato da diverse persone e personalità della chiesa polacca dell’epoca (cardinale Stefan Wyszyński, filosofo Stefan Swieżawski, sacerdote Tadeo Fedorowicz, ecc.). Dai diari di Piccola Sorella Magdeleine sappiamo che Padre Pietro viene informato della sua presenza in Laski, ma non è sicuro di poterla raggiungere. Finalmente però arriva nel monastero delle suore francescane situato nel centro di Varsavia il 20 luglio 1970. Sappiamo che durante questo incontro Padre Pietro racconta le sue esperienza di prigione e la Piccola Sorella è colpita dal suo cambiamento esteriore (la barba, l’abito bianco, il volto segnato dalla prigionia). È possibile solo immaginare il clima di questo incontro su cui si stendeva l’ombra del comunismo che ostacolava la vita della chiesa – si ricorda che le Sorelle questa volta andavano dalla Polonia in Russia Sovietica, cioè proprio nella tana del “orso russo”.
Un anno dopo avviene un altro incontro – questa volta in un altro centro delle Piccole Sorelle in Polonia, cioè in Częstochowa. Padre Pietro viene a sapere da un telegramma che la Piccola Sorella si sarebbe trovata là e, dal suo eremo, la raggiunge. Così almeno per il momento possono incontrarsi e stare di nuovo insieme con persone come: Padre Tadeo, Padre Martino Polpiel, le Sorella Caterina e Stefania e la famiglia Swieżawski, cioè “tutti – come scrive Magdeleine nel suo diario –motivo per cui la Polonia è cara alle Piccole Sorelle”.
Ancora, nell’anno seguente Padre Pietro nel suo eremo riceve per telefono notizia del passaggio di Piccola Sorella Magdeleine per Częstochowa. Immediatamente prende il treno e la sera è già in questa città. In questa occasione avviene anche un piccolo “incidente”. Bisogna a questo punto sottolineare o ripetere che questa amicizia e questi incontri, come anche tutta la storia degli inizi della vita della Piccole Sorelle in Polonia in cui Padre Pietro era coinvolto, sono stati segnati sempre da qualche “avventura”. Padre Pietro dunque, scende dal treno e cerca di raggiungere la casa delle Piccole Sorelle. E’ ormai buio e camminando non si accorge che nella vicinanze della casa è scavata una buca fangosa, in cui cade. Appare così alla porta tutto sporco di fango: vi invito ad immaginare la scena. Padre Pietro che si deve lavare, pulire, cambiare – tutto con un po’ d’imbarazzo e un po’ d’umorismo. Ma ciò che importa è che Magdeleine e Pietro si possono incontrare e parlare. La nota che ricorda tutto questo nel diario di Piccola Sorella finisce con la frase: “Ero profondamente commossa dal fatto, che lui (Padre Pietro) fosse riuscito a raggiungerci così presto e che siamo riusciti a parlare insieme a lungo” (Diari 1972, vol. 39, p. 49).
Negli anni seguenti Piccola Sorella Magdeleine e Padre Pietro si incontrarono regolarmente e almeno una volta all’anno. Le testimonianza di questi incontri è sempre riportata nei diari di Magdeleine. Talvolta non succedeva niente di rilevante, altre volte invece, dalle annotazioni emerge qualcosa di significativo. E così per esempio in data 10 agosto 1973 si legge, tra l’altro, che ormai Magdeleine si era abituata al ritmo di questi incontri annuali con Padre Pietro e che questa volta lui sarebbe arrivato in ritardo perché viaggiava col treno – Magdeleine nota che normalmente Padre Pietro viaggiava in auto-stop e così arrivava sempre in tempo (Cf. Diario, 1973, vol. 41, p. 54). Immaginiamoci questo uomo ormai più che sessantenne vestito in bianco e con una lunga barba mentre ferma le automobili per le strade di Polonia e si sposta da un luogo all’altro per raggiungere questa Francese che semina nel mondo le cellule di una nuova comunità religiosa. Un anno dopo, 30 luglio 1974, Piccola Sorella Magdeleine si trova di nuovo a Częstochowa dove di nuovo arriva Padre Pietro e lei, dopo questo incontro scrive: “Parlo per il momento con Padre Pietro (Père Pierre) che arriva qui ogni volta quando noi passiamo e per me la sua visita è sempre una grande gioia. Lui irradia la pace del Signore nonostante la sua vita sia stata assai tormentata perché ha dovuto passare alcuni anni in prigione” (Diario, 1974, vol. 43, 27).
Gli incontri dell’anno seguente si fecero più frequenti e ancora più avventurosi. Dapprima i nostri due protagonisti si incontrarono a Częstochowa, dove Padre Pietro arrivò la mattina di 14 luglio 1975. Magdeleine racconta che passarono il tempo insieme parlando della situazione in Polonia in cui, in quel momento, secondo Padre Pietro il problema non stava più negli ostacoli amministrativi che il governo avrebbe potuto esercitare di fronte alla chiesa. Secondo lui ormai si era passati ad un programma assai sistematico per lo sradicamento della fede del popolo. A questo scopo doveva servire il progetto del servizio militare prolungato e il cambiamento del sistema educativo che voleva tenere gli allievi a scuola per tutto il giorno desiderando con ciò diminuire l’influsso e il contatto con la famiglia. Pietro vedeva tutta questa situazioni nelle categorie di una battaglia in cui la fede doveva essere difesa (Diario, 1975, vol. 45, p.7). Questa relazione rivela anche il clima in cui si svolgevano sia questi incontri, sia l’instaurarsi delle Piccole Sorelle in Polonia. Con questo si spiega anche un certo radicalismo e la tenacità del pensiero di Padre Pietro, come si può cogliere nei suoi scritti. Tali fatti però non toglievano la gioia di stare insieme, di pregare, di celebrare l’eucaristia, di condividere il pranzo e di lasciarsi con la promessa di rivedersi entro una settimana. E di fatti Padre Pietro arrivò (21 luglio) di nuovo alla casa delle piccole Sorelle a Częstochowa alla vigilia della festa del 22 luglio (Santa Magdeleine) – nonostante fosse un giorno di pioggia si poté far festa e ancora una volta parlare, pregare e mangiare insieme. Padre Pietro ritornò all’eremo di Bielany vicino Cracovia dopo il pranzo – ancora una volta con la prospettiva di vedersi con Magdeleine entro qualche giorno. E così fu, perché le Piccole Sorelle prima di lasciare la Polonia andarono a visitare Padre Pietro nel suo eremo. Ma quest’esperienza si rivelò piuttosto dolorosa. Soprattutto perché il tempo si era cambiato, e nonostante il periodo estivo, faceva già freddo e pioveva. Quando le Piccole Sorelle arrivarono con la loro automobile (il famoso camioncino chiamato “Stella filante” che era insieme una macchina, una cappella, una sala da letto, uno studio, ecc) alla porta dell’eremo camaldolese, scoprirono che li era impossibile entrare, perché in quei luoghi erano impedito l’accesso alle donne. Faceva allora freddo e loro, sedute con Padre Pietro sulla panchina vicino all’entrata – pur essendo contente dell’incontro – temevano di ammalarsi. Ovviamente si discusse sulla stranezza di una tale regola e Padre Pietro cercò di giustificare la situazione con la mancanza di denaro per la costruzione di un parlatorio. Ma si sapeva che non di mancanza di denaro qui si trattava, ma piuttosto di una mancata sensibilità umana. Piccola Sorella Magdeleina nel suo diario finisce tutto questo con la frase “ Lui – cioè Padre Pietro – è certamente troppo buono per non soffrire in tutta questa situazione” (Diario, 1975, vol. 45, p. 14). Questo fatto come anche il commento di Magdeleine spiegano assai bene lo stato in cui Padre Pietro viveva nel sistema dell’ordine camaldolese. Alla fine, con quel freddo e non potendo riscaldarsi in nessun edificio del monastero, tutti si spostarono nell’auto delle Piccole Sorelle per continuare il colloquio fino a sera. Poi Padre Pietro ripassò la porta del monastero e le Piccole Sorelle rimasero a dormire nella loro macchina parcheggiata nella foresta accanto all’eremo. Il giorno dopo (27 luglio 1975) era Domenica giorno in cui anche le donne potevano entrare nello spazio dell’eremo che schiudeva le sue porte per i fedeli della zona per il tempo della celebrazione. Dopo la Messa ripartirono e Padre Pietro decise di accompagnare le Piccole Sorelle per un po’ di strada. Magdeleine scrive che questo fare la strada con loro da parte di questo monaco era ormai una tradizione (ibid., p. 15) – ma si può anche immaginare che il povero Padre Pietro avesse voluto anche appagare con questo gesto la mancata ospitalità che le Sorelle avevano subito nel suo eremo a causa della rigidità e stranezza delle regole (Magdeleine non dimentica di annotare nel suo diario di sperare in una modifica di tale regola entro qualche anno). Il gruppo partì dall’eremo e si indirizzò verso Oświęcim (Auschwitz) dove nel museo presente nel campo di concentramento visitarono insieme la cella in cui era morto Massimilano Kolbe. Dopo di che le Piccole Sorelle ripresero la loro strada verso la Germania e Padre Pietro – questa volta in auto-stop – ritornò al suo eremo. Su tutta questa avventura bisognerebbe solo dire – rifugiandosi in una espressione inglese: No comment.
Un anno dopo (17 luglio 1976), di nuovo a Częstochowa, Padre Pietro arriva la mattina – Piccola Sorella Magdeleine e il monaco si scambiano alcune informazioni e si aggiornano reciprocamente. Padre Pietro cerca di spiegare la situazione dell’ordine camaldolese e della sua difficoltà ad “eclissarsi” quando avrebbe voluto, pur non negando ma desiderando per sé la vita eremitica (lui vive nelle vicinanze di Cracovia e ormai da trent’anni). Magdeleine riprende il discorso sullo shock subito l’anno precedente circa la totale mancanza di sensibilità per gli ospiti di sesso femminile. Padre Pietro la informa sull’avvio di lavori per la costruzione di un parlatorio accanto all’eremo che avrebbe potuto almeno parzialmente rimediare ad una tale mancanza. Il pomeriggio Padre Pietro può ancora celebrare l’eucaristia nella casa delle Piccole Sorelle e riparte subito per trovarsi nel suo eremo vicino a Cracovia la sera stessa. Un simile, breve, incontro ebbe luogo dopo circa sei mesi, il 13 febbraio 1977 – ma il diario di Piccola Sorella Magdeleine non apporta niente di più oltre l’annotazione che è avvenuto e la gioia che lo ha accompagnato.
“Succede sempre che ci ritroviamo su qualche strada”
Il 14 settembre 1977 Piccola Sorella Magdaleine e Padre Pietro si ritrovano a Tre Fontane. Sono passati ormai 20 anni dal loro primo incontro in quello stesso luogo. Nel 1977 lui aveva quasi settant’anni e lei quasi ottanta – ambedue arricchiti da diverse esperienze vissute e viste. Magdeleine annota nel suo diario che Pietro, arrivato a Tre Fontane, ha un’aria così stanca che in un primo momento lei non lo riconosce e lo crede un barbone (bella questa! – cf. Diario, 1977, p. 64). Quel giorno si celebrava la festa dell’ Esaltazione della Santa Croce e non si sa perché Padre Pietro si fosse trovato a Roma (probabilmente per motivi legati alla congregazione camaldolese). Per la festa lui celebra nella casa delle Piccole Sorelle la Messa, e pronuncia l’omelia di cui si è conservata la registrazione e la trascrizione (ibid. 74-75). Durante il pranzo a Padre Pietro vengono presentate tutte le Piccole Sorelle dell’Est presenti in quel momento nella casa.
Nell’estate dell’anno seguente Magdeleine e Pietro si incontrano in Polonia per ben tre volte. La prima volta Padre Pietro arriva il 20 giugno 1978 a Częstochowa. Si tratta di una visita molto breve – si vedono, si scambiano qualche parola e Pietro si esprime dicendo che “oggi” non basta credere, ma bisogna anche confessare e testimoniare la propria fede in mezzo alla gente (in questo di nuovo risuona il suo radicalismo cristiano dovuto sia al suo atteggiamento interiore sia alla situazione storica in qui viveva). Poi celebrano la Messa di cui si è pure conservata la breve meditazione di P. Piotr che dopo un pasto breve e leggero riparte. (Diario, 1978, vol. 53, pp. 127-128). Magdeleine annota tra l’altro che lui nel frattempo aveva cambiato luogo di soggiorno – non abitava più nell’eremo di Bielany vicino Cracovia, ma a Bieniszew nella parte Nord-Centrale del paese. Dieci giorni più tardi (30 giugno 1978) Padre Pietro di nuovo è presente a Częstochowa. Arrivando la mattina, celebra la Messa (di cui di nuovo abbiamo le parole della sua omelia) e riparte dopo il pranzo.
Per la terza volta nell’anno 1978 le Piccole Sorelle e Padre Piero si incontrano: è l’8 Luglio – e questo fu uno di quegli incontri strani e sorprendenti, inventati del tutto da Padre Pietro. Le Sorelle si recavano in Russia Sovietica e ad un tratto Padre Pietro “apparve” loro seduto vicino la strada. Ma qui è meglio dare la voce a Piccola Sorella Magdeleine che scrive: “Come fummo soltanto due chilometri dalla frontiera, rimanemmo molto sorprese nel vedere sulla strada una persona vestita in un talare nero e con una lunga barba che era quella di Padre Pietro. Fummo colpite profondamente pensando che lui fosse venuto proprio là per darci l’ultimo saluto conoscendo forse il giorno del nostro passaggio” (Diario, 1978, vol. 53, pp. 153-154). In tutto questo colpisce il forte legame emotivo che univa queste persone. Le sorelle andavano in Russia – che era sempre a quei tempi pericoloso. Ma Pietro desiderava fortemente vedere Magdeleine con cui si era incontrato nell’arco di tre settimane ormai due volte. Ora lui si era recato dall’Ovest del paese dove si trovava il suo eremo alla parte dell’estremo Est… soltanto per salutarla e per vederla per un momento. Si possono immaginare le fatiche e le difficoltà delle strade che questo monaco (non più tanto giovane) doveva affrontare per giungere a quell’incontro. Tutto questo è sorprendente e bello e non dicendo niente dice molto sul legame che è esistito tra queste persone.
Ma ecco come Magdeleine continua il racconto: “La gioia di rivederci è mescolata con una certa inquietudine. Perché le vicinanze della frontiera russa (siamo sempre nei tempi del comunismo assai arduo – MB) sono talmente sorvegliate che fermarsi qui e per di più parlare con qualcuno è una cosa molto imprudente… Ma che importa… Offriamo allora a Padre Pietro una tazza di café, un biscotto e una crocetta fatta di eucalipto da una delle sorelle di Tre Fontane. Pensiamo che sia prudente che nessuno ci veda insieme. Lui invece ci dà la benedizione e ci lascia”. Ecco il clima dell’incontro: clandestinità, paura, apparizione, fretta – ma in tutto questo non manca un po’ d’umanità (café e biscotto) e un po’ di fede (croce e benedizione).
Poi Magdeleine continua: “Noi invece dobbiamo ancora aspettare a lungo, perché alla frontiera c’è una lunga fila di macchine. Arriva un poliziotto, e dopo averci chiesto i passaporti, ci fa domande su questo “pop” (così sono chiamati i preti ortodossi - MB) con la talare nera e con la barba bianca che ci ha raggiunto sulla strada (il poliziotto aveva pensato che questo poteva essere una spia o qualche contatto illegale – MB). Noi semplicemente rispondiamo che non era un “pop” ma un Padre Camaldolese che si chiama Pietro, ma di cui abbiamo dimenticato il cognome (piccola bugia – MB) perché è un polacco e i nomi polacchi sono difficili da ricordare per i Francesi… Noi lo abbiamo conosciuto nel suo monastero a Bielany che è un posto molto turistico” (ibidem). Poi le sorelle partirono per la Russia. In quel momento Padre Pietro era probabilmente già lontano – immerso nei suoi pensieri e nel suo viaggio di ritorno (sicuramente in auto-stop).
Nel 1979 Padre Pietro si trova a Częstochowa proprio nel tempo in cui in questa città e nel santuario ha luogo la visita di Papa Giovanni Paolo II. Nello stesso tempo è qui presente anche la Piccola Sorella Magdeleine che nel suo diario scrive: “Il 6 giugno Padre Pietro Rostworowski, il nostro grande amico, priore dei camaldolesi, è qui con i suoi quattro novizi per assistere alla Messa celebrata dal Papa Giovanni Paolo II a Jasna Góra per i seminaristi e i novizi di ordini religiosi” (Diari-Lettere stampati, vol. 16, p. 51). Poi loro due si rivedono ancora il primo luglio quando Padre Pietro ancora una volta ripassa a Częstochowa. Pietro celebra per le Sorelle l’eucaristia la sera del suo arrivo e il giorno dopo, e riparte poi per il suo eremo. Nelle note di Piccola Sorella Magdeleine risuona un certo tono melanconico causato da queste via-vai di diversi amici (Pietro incluso).
L’anno seguente (5 luglio 1980) visitando Polonia le Piccole Sorelle arrivano con la loro auto all’eremo di Bieniszew e ancora una volta si sorprendono quando sulla strada appare Padre Pietro che sta passando di li con la sua macchina, si ferma e le saluta. È un breve incontro e le Sorelle ripartono a sud del paese, dandosi però un appuntamento con lui in una delle strade vicino a Cracovia. Magdeleine commenta questo fatto scrivendo: “Succede sempre che ci ritroviamo su qualche strada” (Diario p. 147). Trovandosi a Cracovia con le Piccole Sorelle, Padre Pietro fa loro da guida – visitano insieme il centro storico della città e poi vanno a Tyniec – il monastero benedettino in cui prima di diventare camaldolese Padre Pietro aveva vissuto per anni.
Nel 1981 Magdeleine e Pietro si incontrano a Tre Fontane (25 marzo) e poi in Polonia a Częstochowa (22 luglio) – dalle note di Magdeleine risulta che il tema principale discusso all’occasione di questi incontri è soprattutto la situazione politica in Polonia e la posizione della chiesa in mezzo a tutti i cambiamenti che incominciano ad avvenire nel blocco dell’est europeo (si pensi all’elezione di un Polacco alla Sede di Pietro, alla rivoluzione di Solidarnosc, ecc.). Un ritmo simile segna l’anno seguente. Prima il 3 giugno 1982 Padre Pietro, come scrive Magdeleine “all’improvviso come sempre” (Diari stampati, vol. 20, 483), arriva a Tre Fontane fermandosi solo per qualche ora (tempo di mangiare e parlare insieme). Nel mese successivo si rivedono già a Częstochowa (22 luglio 1982) dove nel monastero di Jasna Góra Padre Pietro alla presenza di altri amici delle Piccole Sorelle (Padre R. Voillaume, Padre Marcin, Padre Tadeo, Signora e Signore Świeżawski) presiede la Messa. Poi si rivedono ancora una volta nel posto chiamato Zielonka, un nuovo centro questa volta per i Piccoli Fratelli in Polonia, il 20 agosto 1982.
L’ultimo giorno del giugno 1983 Magdeleine e Pietro si incontrano di nuovo a Zielonka dove tra l’altro stabiliscono che nei giorni successivi le Piccole Sorelle con la loro macchina (la famosa “Stella filante”) avrebbero trascorso qualche giorno nella solitudine della foresta vicino all’eremo di Bieniszew dove in quel tempo abitava Padre Pietro. E di fatti le quattro Sorelle (insieme con Magdeleine ci sono : Marie-Luise, Léon, Jeanne) arrivano a Bieniszew la sera del 4 luglio – Pietro indica loro un angolo nella foresta dove, secondo lui, sarebbero state al sicuro, celebra una Messa vespertina e le lascia nella loro auto-furgone nella solitudine e nel silenzio della foresta. La mattina del giorno dopo Padre Pietro arriva e celebra la Messa nella macchina (non è una domenica e le donne non possono invadere la clausura dell’eremo). Le Sorelle passano la giornata nel silenzio della foresta – la sera dedicano ancora un’ora all’adorazione del Santissimo sacramento esposto di nuovo… nella macchina. È bello immaginarlo: la foresta, la macchina che ha passato tante frontiere, un gruppo delle Sorelle, Santissimo Sacramento, un monaco-amico che viene ogni tanto dal suo eremo accanto, il silenzio, il mistero. Piccola Sorella Magdeleine non esita a confessare che “da almeno quarant’anni non avva mai avuto la possibilità di godersi una tale solitudine e una tale pace” (Diario, 1983, vol. 68, p. 56). Due Sorelle dormono nella macchina e due altre nella tenda sul tetto della macchina (si ricorda che Magdeleine allora aveva circa 85 anni! – e soffriva il calore dell’estate, la presenza delle zanzare e delle ortiche che in quella foresta si trovavano ovunque). Padre Pietro arriva solo alle cinque di sera per celebrare la Messa. Il giorno dopo le quattro Sorelle e Padre Pietro si rivedono la mattina: lui di nuovo celebra la Messa e poi tutti insieme partono – il monaco accompagna le Sorelle per un po’ mostrando loro la strada; poi lui fa ritorno al suo eremo e loro proseguono verso la frontiera della Germania. Magdeleine e Pietro si rivedono a Tre Fontane il 20 ottobre 1983 quando lui partecipa a Roma al Sinodo dei Vescovi dedicato al sacramento della riconciliazione. Nell’occasione Magdeleine nota – un tratto particolare – che a mezzogiorno, al suono delle campane, Padre Pietro spontaneamente inizia a recitare l’“Angelus” e le altre lo seguono (Magdeleine osserva che questa prassi, peccato, si era ormai persa tra le Piccole Sorelle…).
Poi la vita di Padre Pietro si cambiò – dovette spostarsi per vivere a Nola vicino Napoli ed essendo un secondo visitatore dell’ordine, dovette viaggiare tra Italia, Polonia e Stati Uniti passando ogni tanto un momento a Tre Fontane dove sempre più frequentemente risiedeva ormai avanzata nell’età e fisicamente indebolita Piccola Sorella Magdeleine. Così fu per esempio il 27 settembre 1984. L’anno seguente invece Magdeleine e Pietro si incontrarono prima a Częstochowa (30 giugno 1985) e poi a Regelsbrunn (5 luglio 1985) in Austria. Le Sorelle tornavano a Tre Fontane e Padre Pietro con un'altra macchina, passando per Roma andava al suo eremo di Nola vicino Napoli. Ambedue pur prendendo strade diverse riuscirono a mettersi in contatto e incontrarsi per una giornata nella cittadina austriaca. Tutto si svolse come di solito: incontro sulla strada, la Messa, il pranzo, il dialogo e la partenza.
L’anno seguente il loro incontro fu segnato da un altro colorito. Padre Pietro il 20 ottobre 1986 apparve senza annuncio a Tre Fontane così che Magdeleine lo trovò semplicemente nella sua stanza tornandovi dopo qualche altro incontro da fuori. Pietro rientrava dalla Polonia dove era stato, salutando tutti (Magdeleine scrive “per dire a Dio”) perché aveva ricevuto l’ordine di recarsi in Columbia per prendere cura delle nuove vocazioni eremitiche. La Piccola Sorella nota nel suo diario che Padre Pietro è per lei un esempio dell’obbedienza, del coraggio e del buon umore: scherza dicendo che si sente come Abramo che a 75 anni, obbedendo alla voce di Dio, dovette partire per terre sconosciute – e ora Padre Pietro avendo ormai 76 anni, con una salute danneggiata da reumatismi e senza conoscere lo spagnolo deve recarsi oltre l’Oceano Atlantico (tutto questo è raccontato nel Diario di Magdeleine). Le note di Magdeleine non dicono molto, ma sicuramente ambedue si rendono conto che quello forse poteva essere l’ultimo incontro: la Columbia era lontana, ambedue erano avanti negli anni e il futuro poco prevedibile. Rimaneva però il contatto epistolare – e così Padre Pietro mandò a Mgdeleine già il 24 ottobre – cioè subito dopo il suo arrivo – la lettera in cui descrive le sue prime impressioni delle vita in Columbia. Ad essa ne seguono altre: il 27 gennaio 1987 e il 16 maggio 1989.
L’ultimo incontro ebbe luogo a Tre Fontane nel 1989 – poco prima della morte di Magdeleine. L’8 settembre si celebrava il 50-esimo anniversario della Fraternità e il 13 settembre, andando al capitolo generale dei Camaldolesi a Frascati, Padre Pietro tornava dalla Columbia. Ma Mgdeleine era ormai molto debole ed esaurita –si videro “soltanto” e poi Padre Pietro ripartì. Così si chiude la storia di questi incontri. Tutto è incominciato a Tre Fontane nel lontano 1957 – ora lui la “vede” e parte.
Quando Padre Pietro seppe della morte della Piccola Sorella Magdeleine (6 novembre 1989) ha inviato il 26 dicembre 1989 dal suo eremo columbiano a Envigado alla casa di Tre Fontane una lettere in cui in qualche modo ha dato la testimonianza di questo che cosa era per lui la Piccola Sorella Magdaleine e la sua amicizia. Ne leggiamo:
“Sono rimasto profondamente impressionato e commosso dalla vostra lettera che mi ha annunciato la scomparsa della Piccola Sorella Magdaleine di Gesù, richiamata da questo mondo da parte del nostro Padre Celeste. E vero che già durante la mia ultima visita a Tre Fontane agli inizi dell’ottobre si notava la sua grande debolezza che faceva pensare di una sua fine vicina. Non di meno questa scomparsa è un evento spirituale non solo per la vostra Famiglia religiosa di cui lei era la Fondatrice e Madre, ma anche per me che da sempre mi sono sentito indegno della sua amicizia, però tutto in me mi dice che questa amicizia era autentica e sincera.
È una santa che ci ha lasciato visibilmente per rimanere con noi invisibilmente. Le sue ispirazioni, profondamente evangeliche, hanno arricchito la Chiesa di Dio; e il sue benefico influsso si può ritrovare persino nei documenti e nello spirito del Vaticano II e nella vita postconciliare della Chiesa.
La sua anima da una parte molto forte e inflessibile, fondata sulla fede e fiducia in Dio, possedeva d’altra parte una tenerezza straordinaria; questa era la tenerezza divina che sta nel fondo di tutte le cose create ed è il tono il più profondo e il più divina delle Scritture e di tutto questo che realmente esiste.
Essa (Piccola Sorella Magdaleine - MB) aveva una intuizione del tutto eccezionale del Vangelo e di questo che è evangelico; ma questa fedeltà al Vangelo, assai austera, non ha diminuito per niente la sua straordinaria bontà e dolcezza.
Per la sua comunità ora incomincia una nuova tappa. Gli apostoli non hanno capito immediatamente che la scomparsa di Cristo era allo stesso momento una grazia per loro. Questa grazia della scomparsa senza dubbio si mescola con il dolore. Ma dobbiamo scoprirla.
Preghiamo il Signore infinitamente Santo che nella sua immensa misericordia conceda all’anima della sua Serva la gioia della vita eterna.
Rimango profondamente unito alla cara congregazione delle Piccole Sorelle di Gesù in questo giorno e per sempre”.
Sarebbe difficile scrivere una conclusione di tutta questa storia. E forse non basta affermare che è una storia bella e affascinante. Si potrebbero scrivere tantissime altre storie parallele: cioè tantissime altre amicizie che hanno segnato la vita di Magdeleine e quella di Pietro. Ognuno di loro ne aveva tante – ma anche tra loro erano legati da una relazione molto particolare, profonda e fondata sul Vangelo e sulla simile passione per Dio. Aggiungere un tale saggio alla fine di questo libro ha uno scopo molteplice: 1. far conoscere questa storia; 2. mostrare la ricchezza della vita di Pietro Rostworowski di cui l’amicizia con Piccola Sorella Magdeleine è “solo” una (nel cosmo delle sue relazioni in Cristo ve ne erano tante, tantissime altre “grandi e piccole”); 3. ammonire i futuri storici che la vita di questo monaco era ricca, complessa, piena di sorprese e lontana da schemi – vedere, comprendere e descrivere tutto questo rendendone giustizia è un’impresa tanto bella quanto difficile.
Maciej Bielawski (2003)
[1] Eremo di Frascati 22.10.1995. Questa meditazione è stata scritta in polacco – la traduzione in italiano è di M. Bielawski.
[2] Eremo di Frascati: 11.05.1995.
[3] Eremo di Nola: 31.03.1984.
[4] Eremo di Nola: 7.04.1984.
[5] Eremo di Nola: 19.05.1984.
[6] Eremo di Nola: 26.05.1984.
[7] Eremo di Nola: 4.08.1984.
[8] Manca la data di questa conferenza.
[9] Eremo di Nola: 11.08.1984.
[10] Eremo di Nola: 25.08.1984.
[11] Eremo di Nola: 15.09.1984.
[12] Eremo di Nola: 17.08.1985 (vedi anche l’omelia per la festa di San Lorenzo, pp...)
[13] Eremo di Nola: 8.09.1984.
[14] Eremo di Nola: 22.12.1984.
[15] Eremo di Nola: 22.12.1984.
[16] Eremo di Nola: 30.03.1985.
[17] Eremo di Nola: 28.04.1984.
[18] Eremo di Nola: 5.05.1984.
[19] Eremo di Nola: 18.05.1985.
[20] Eremo di Nola: 2.06.1984.
[21] Eremo di Nola: 13.07.1985.
[22] Eremo di Nola: 10.08.1985.
[23] Eremo di Nola: 27.07.1985.
[24] Eremo di Nola: 3.08.1985.
[25] Eremo di Frascati: 27.02.1995.
[26] Eremo di Nola: 20.07.1985.
[27] Eremo di Frascati: 27.02.1995.
[28] Eremo di Nola: 17.03. 1984.
[29] Eremo di Nola: 14.07.1984.
[30] Eremo di Pasce Lupo: 24.04.1993.
[31] Siamo al v. 12 del cap. 1. L’Apostolo informa i fratelli di Filippi sulla sua situazione. Umanamente parlando, essa non è felice. Egli si trova in prigionia e non può predicare il Vangelo. Ma tutte le difficoltà per lui non sono niente. Il suo amore di Cristo e la sua speranza gli danno un ottimismo invincibile. (Nota scritta dal Padre Pietro)
[32] Eremo di Pasce Lupo: 12.06.93
[33] Tutte le informazioni provengono sia dai diari sia dalle lettere di Piccola Sorella Magdeleine conservate nell’archivio a Tre Fontane (Roma) e sono indicate nel testo. Nello stesso archivio si trovano tante fotografie che pure narrano questa storia. Esistono poi ancora vivi i ricordi che “girano” nella comunità delle Piccole Sorelle e che fanno parte della loro tradizione viva – ogni tanto questi racconti mi hanno aiutato di comprendere e di interpretare alcuni eventi. Bisogna menzionare il fatto che dopo la morte di Piccola Sorella Magdeleine, e a poca distanza della sua, Padre Pietro ha scritto un testo, una testimonianza su Magdeleine, ma questa per il momento, a ragioni diverse, non può essere resa pubblica.
[34] Diaire de Petite Soeur Magdeleine de Jésus, 9.09.1961, vol. 17, pp. 60-61 (traduzione italiana MB).
Adalberto Giovanni (in polacco: Wojciech Jan) Rostworowski nacque 12.09.1910 in Rybaczewice, nella diocesi di Lublino (Sud-Est di Polonia), in una famiglia nobile (suo padre era un senatore della Repubblica Polacca nel periodo interbellico). Adalberto nel 1930 entrò nel monastero benedettino di San Andrea vicino Brugge in Belgio prendendo il nome Pietro. Dopo il periodo previsto per la formazione e dopo l’ordinazione sacerdotale (1937), venne mandato a Roma per approfondire la sua formazione teologica nell’Ateneo benedettino di Sant’Anselmo sull’Aventino. Trascorso un anno, da Roma venne chiamato in Polonia, dove il suo monastero belga aveva avviato una nuova fondazione. Nell’estate del 1939 Padre Pietro fu nominato sotto-priore dei monaci e maestro dei novizi del monastero di SS. Pietro e Paolo a Tyniec, vicino a Cracovia. Un mese dopo la sua apertura scoppiò la seconda guerra mondiale. Il monastero è sopravissuto alle cavalcate sia degli eserciti tedeschi sia di quelli russi diventando anche, per alcuni (Polacchi ed Ebrei), luogo di rifugio e di nascondimento. In Polonia alla fine della guerra, si stabilì il governo comunista e, per la crescente intolleranza stalinista, i monaci belgi furono costretti a lasciare il paese. Su Padre Pietro cadde la responsabilità di guidare questa nuova fondazione (anni 1952-1958). Erano tempi difficili: la vita della Chiesa era ostacolata dal regime, il Primate cardinal Stefan Wyszyński venne imprigionato, alcuni monasteri furono chiusi, altri sorvegliati dalla polizia segreta, ecc. Padre Pietro in questo periodo, oltre a guidare il monastero di Tyniec, agiva in diversi campi: resistenza al comunismo, attività pastorale; uomo di appoggio e di consiglio, divenne una delle figure più imponenti della chiesa in Polonia. Per toglierlo di mezzo e screditare la sua autorità, il regime trovò motivi di accusa e lo imprigionò per circa quattro anni (1964-1967).
Uscito, in qualche modo libero e staccato dagli impegni precedenti, gli si chiese di aiutare il processo di rinnovamento negli assai indeboliti eremi dei monaci camaldolesi della congregazione di Monte Corona presenti in Polonia. Dopo il 1968 il clima politico nel paese cambiò e la Chiesa, monasteri inclusi, entrò nel processo di rinnovamento post-conciliare in cui Padre Pietro venne coinvolto. Nel 1972 formalmente si fece camaldolese e la sua figura, in abito bianco e con lunga barba grigia, si ripresentò nel mondo monastico ed anche oltre le mura degli eremi. Fu un periodo molto fecondo della sua vita: scriveva, predicava, ascoltava, dava consigli e i due eremi camaldolesi in Polonia si riempivano di monaci e riprendevano la loro vita. Dopo l’elezione del cardinale Wojtyła di Cracovia alla sede petrina, le visite di Padre Pietro in Italia, dove tra l’altro a Frascati si trovava la casa generalizia del suo ordine, divennero più frequenti finché, nel 1983, gli fu assegnato l’incarico di superiore dell’eremo di Nola vicino a Napoli. Nel 1986 si aprì ancora un altro capitolo del tutto nuovo nella vita di Rostworowski – l’ordine lo incaricò dell’organizzazione di una nuova fondazione in Columbia. Nei successivi otto anni, sotto la sua direzione, furono aperti gli eremi a Envigado (vicino Medelin – poi chiuso) e, in seguito, quello di Santa Rosa esistente tutt’oggi. Nel 1994 Padre Pietro ritornò dal continente Sud-Americano e si stabilì nell’eremo di Frascati. Qui per un certo tempo condusse la vita di recluso che però gli venne impedita per ragioni di salute. Dopo la crisi causata da un ictus si riprese per un po’ ma, ormai indebolito e invecchiato, si spense nell’ospedale di Albano il 30 aprile 1999.
Già da questa breve nota biografica si intravede una personalità ricca e straordinaria. La sua opera, possiamo chiamarla così, aspetta ancora di essere veramente scoperta, portata alla luce e conosciuta. Scrivere la biografia di questo monaco, che potrebbe fornire gli elementi per un giudizio completo ed equilibrato, non sarà un compito facile – ma tali iniziative sono state già felicemente avviate. La stessa cosa riguarda l’edizione dei suoi scritti e il giudizio del suo messaggio teologico e spirituale, che non sono meno eminenti della sua biografia.
Padre Pietro scrisse – molto e lungo tutta la sua vita; pubblicò poco, perché non volle, ma il suo patrimonio letterario, così come oggi lo conosciamo, è immenso. In esso si trovano tanti “commenti” biblici, o piuttosto le meditazioni che lui scriveva per se stesso o con il desiderio di condividerle con altri. Scrivere questi commenti era per Padre Pietro un modo di pregare, di comprendere ed approfondire la Parola di Dio. Nell’insieme essi coprono forse tutti gli scritti del Nuovo Testamento (alcuni commentati più volte), i Salmi (forse tutti) e diverse altre parti dell’Antico Testamento. In questo patrimonio si distinguono temi diversi: preghiera e vita interiore, direzione spirituale ed educazione alla vita con Dio, vita monastica in genere, dogmi e liturgia; non mancano traduzioni (per esempio La nube della non conoscenza), ma anche il Cantico che, nella versione di Padre Pietro, entra nella traduzione ufficiale e liturgica polacca della Scrittura. Tanti di questi scritti sono su quaderni, su vecchi calendari o sui fogli di carta strappati e sparsi qua e là – centinaia e migliaia di pagine coperte con una scrittura regolare, chiara e senza correzioni; altre scritte a macchina; non mancano anche registrazioni delle sue conferenze e prediche. Insomma il materiale è immenso e fortunatamente ben conservato nell’archivio del monastero di Tyniec – grazie alla premura di persone ben consapevoli del valore in esso racchiuso. Già oggi, nonostante la raccolta non sia ancor terminata, si possono distinguere circa quaranta blocchi tematici per più di 4 o 5 mila pagine. A tutto questo si devono aggiungere le lettere: quasi 30 mila (sì!) per le quali Padre Pietro tenne un registro preciso – una parte di esse si riferisce al suo lavoro di visitatore, la maggioranza ha valore spirituale (si trovano ad esempio lettere indirizzate a singole persone con cui aveva corrisposto per diversi anni).
Lo stile dei suoi scritti è limpido – il pensiero scorre in modo semplice e profondo, senza correzioni, il che denota nell’autore una perfetta padronanza del tema che tratta (questo fatto è legato alla sua stupenda disciplina mentale coltivata e sviluppata nei lunghi anni di vita monastica). Tutto qui parte dall’esperienza e dalla ricerca di Dio – ogni tanto si ha pure l’impressione che l’autore di questi testi sia stato proprio rapito da Dio e scriva sotto una sua ispirazione: il suo pensiero, e la sua personalità, sono impressi da un forte teo-centrismo. La Parola di Dio occupa in tutto questo un posto privilegiato: Padre Pietro la commenta e scrivendo cerca di capirla, ma d’altra parte la stessa Parola schiude nel suo cuore una esperienza di Dio e lui stesso si vede in essa. Una volta scrive per salvarsi, un’altra perché si sente salvato. Ogni tanto scrive perché sa e in altri momenti perché desidera di sapere. Comunque i suoi testi possiedono la forza e l’autenticità dell’esperienza di Cristo e sono intrisi di passione per il suo amore. Qui viene presentata solo una piccola parte della sua eredità letteraria; si tratta di scritti, in lingua italiana – in particolare i testi di Nola sono su un quaderno, quelli di Frascati sono su diversi fogli e quaderni. Se ne riporta una scelta secondo un ordine diverso da quello dato da Padre Pietro e con le minime e limitate modifiche linguistiche, ritenute necessarie. Il presente lavoro vuole essere solamente la premessa a un’opera ben più vasta e profonda, ma forse già da questo libretto il lettore potrà cogliere grandezza e bellezza del personaggio e del suo pensiero. Forse a qualcuno piacerà – forse aiuterà qualcuno ad appassionarsi di Dio (ancora di più).
Maciej Bielawski 2003
Indice
Introduzione
I. Monastica
1. Su me stesso
2. Quattro pilastri della vita monastica
3. Umiltà
4. Ispirazioni di Dio (I)
5. Ispirazioni di Dio (II)
6. I comandamenti di Cristo (I)
7. I comandamenti di Cristo (II)
8. Imitazione di Dio
9. Immutabilità di Dio (I)
10. Immutabilità (II)
11. La pazienza di Dio
12. La pazienza (hypomoné)
13. La prova
II. Liturgica
1. Nativitas B.V.M.
2. La Venuta del Signore
3. Natale
4. La Passione del Signore
5. Pasqua – sabato in albis
6. L’incontro in Galilea
7. Ascensione
8. Ascensione e Pentecoste
9. San Benedetto
10. San Lorenzo
III. Biblica
1. Salmo 2 75
2. Salmo 4 78
3. Salmo 23 81
4. Salmo 86 82
5. Salmo 92 83
6. Salmo 130 86
7. Sul Libro dei Proverbi 88
8. La Lettera ai Filippesi 1 91
Maciej Bielawski: Piccola Sorella Magdeleine Hutin e Padre Pietro Rostworowski.
Storia di un’amicizia 100
I. Monastica
1. Su me stesso [1]
Io sono monaco sin dalla giovinezza. Già a dodici anni ero convinto che questa fosse la mia vocazione. Ora sono entrato nell’ottantaseiesimo anno della mia vita e fra una settimana sarà anche il sessantacinquesimo anniversario della mia entrata in monastero. Sono sacerdote da cinquant’otto anni. Oggi colgo l’urgente necessità di riformare la mia vita. Dio mi offre chiara coscienza di quante grazie ho sprecato, per mancanza di prudenza e di sapienza, e che sarebbero state importanti per condurre la mia vita.
Dio mi ha dato una buona famiglia e buone condizioni per vivere. Nella mia giovinezza non ho conosciuto il peso né della povertà né di sfide materiali o morali. La mia famiglia era credente e unita e la disciplina della vita si fondava sulla carità, sul reciproco rispetto e sulla fiducia. Non si richiedeva da me molto. Dio mi ha dato una buona intelligenza e così lo studio non era per me difficile: raggiungevo ottimi risultati senza sforzo. Ero segnato da una forma di nobiltà del vivere. Mi piaceva quanto era nobile, avevo un’inclinazione spontanea all’amicizia e alla misericordia, ma anche alla pigrizia, al conformismo e poca solidità. Nel mio ambiente ero ben accettato e stimato. Sin dalla mia gioventù mi rispettavano e godevo di una certa autorità e fiducia. Sinceramente desideravo essere buono e mi sembrava di esserlo, allora non facevo caso al fatto che dovevo assolutamente combattere i vizi del mio carattere. Il primo campo di battaglia, di cui mi resi conto, fu quello della castità. Questa battaglia ravvivò il mio contatto con Dio e mi preoccupavo di vivere in stato di grazia. Mi mancava però una ascesi sistematica e una vita spirituale più ordinata.
Quando nel 1930 ho iniziato la vita monastica, mi sono sottomesso subito alla disciplina della vita comunitaria e liturgica. Sono stato ben accettato dalla comunità. I superiori hanno ben apprezzato la mia cultura e la mia sincera buona volontà, perché anch’io ho accettato l’ordine monastico con fede semplice e simpatia. Ma non mi sono avviato verso la prassi sistematica dell’ascesi. Non ero cosciente di tale necessità. Speravo piuttosto che i miei sforzi di scendere sempre più profondamente nella preghiera, lentamente mi trasfigurassero – e desideravo questa trasformazione.
Nell’ordine monastico del mio tempo non esisteva la direzione spirituale fatta in modo sistematico. Ovviamente un giovane monaco poteva chiederlo a un sacerdote che sceglieva. Non si praticava un’obbedienza che negava la propria volontà. E io, che in modo assai naturale e molto facilmente mi adattavo all’ambiente, anche perché non mi attirava l’essere ribelle e seguire soltanto la mia volontà, sono entrato nella vita monastica liscio e senza ostacoli. Tutto questo nell’insieme, il mio “carattere facile”, ha impedito che io mi rendessi conto di quanta superbia e volontà propria si trovavano in me. Ho accettato allora la cornice della dipendenza monastica, ma dentro questa cornice, di fatto, facevo quanto volevo o organizzavo la mia vita da solo – devo dire che lo facevo in un modo poco prudente e stupido. Avrei dovuto avere un maestro saggio, qualcuno capace di sorvegliare la mia vita spirituale e la mia formazione intellettuale. L’ordine monastico lo faceva in modo solamente esteriore – decidendo, per esempio, che dovevo studiare a Roma. Là frequentavo i corsi e superavo gli esami, ma in quale direzione “concretamente” doveva svilupparsi la mia formazione intellettuale e spirituale decidevo io, completamente da solo e per tutti gli anni della mia vita monastica. Mi era stata lasciata una grande libertà, che da parte mia, era stata impiegata in modo del tutto sbagliato. Mi mancava la prudenza e l’orientamento per scegliere la direzione migliore per me – e devo dire che avevo possibilità stupende. In tutto questo il peggio era che non possedevo lo spirito dell’umiltà e dell’obbedienza per lasciarmi dirigere dagli uomini saggi che incontravo sulla via della mia vita. Il risultato è che, oggi, avendo ottantacinque anni, sono una persona con una vita sprecata, sono una persona senza una vera conoscenza teologica o biblica, non possiedo né una scienza spirituale, né una virtù provata da un’ascesi stabile. E poiché credo che il Padre Celeste sia buono e paziente nei miei confronti, che non abbia perso la sua pazienza e sia pronto a darmi la grazia della vera conversione anche se il tempo che mi rimane è molto breve, voglio ora umiliarmi totalmente di fronte a Lui e supplicarLo perché abbia misericordia della mia vita peccaminosa.
Quanto ho scritto sopra è stato detto secondo una prospettiva molto umana. Ma a Dio non piace un tale ragionamento. Perché è dal punto di vista umano che la mia vita è stata sprecata. Che cosa è stato sprecato? Forse avrei potuto ottenere una formazione teologica ottima e ho perso questa occasione? Questo significa che mi dispiace perché non ho raggiunto una certa grandezza, io che sono un niente e tutta la mia vita tende alla kenosis? Che cosa voglio allora? Certamente qui si tratta del fatto che ho perso alcuni valori apprezzati agli occhi degli uomini, e persino alla Chiesa. Ma l’acquisto di questi valori avrebbe potuto solo aumentare la mia superbia, ne sono certo. E allora? La mia vita può essere definita una frana o una vita sprecata in quanto ho offeso Dio (l’ho fatto tante volte). D’altra parte mi chiedo: è mai esistita una vita più sprecata di quella del buon ladrone, che stando di fronte alla morte, non poteva contare di avere tempo per la conversione e per la penitenza? Ma la vita di questo uomo fu un successo fatto da Dio, questa vita fu pienamente affermata da Cristo e dalla sua Redenzione. Non bisogna allora dire che la vita è sprecata fin quando ancora dura.
2. Quattro pilastri della vita monastica. [2]
Carissimi Fratelli.
Tutti siamo venuti all’Eremo per vivere intensamente nella presenza di Dio, nel pensiero delle cose eterne, e prepararci a una buona morte che sappiamo essere molto vicina. Abbiamo tutti i nostri peccati, tutti dobbiamo far penitenza, tutti dobbiamo convertirci e umiliarci davanti al Signore fino in fondo, e poi sperare nella Sua infinita Misericordia. Il monaco è colui che prende questo programma con grande serietà. Morto con Cristo nel battesimo e risorto con Lui nello stesso sacramento, vuole realizzare questo mistero di morte e di vita nella propria esistenza. Per poter vivere più profondamente e più intensamente questo mistero, il monaco si chiude nella solitudine cercando di approfondire, nella preghiera e nella meditazione, l’ammirevole economia del divino Amore che ci salva.
I. Ciò che caratterizza il contemplativo è la passione di Dio e del divino, della grandezza di Dio, della sua gloria. È vero che il cristiano può santificarsi in mezzo al mondo, avendo una famiglia, un mestiere, un inserimento nella società. Ma l’amore del contemplativo dice che il Signore è degno di essere l’unico fine, l’unica preoccupazione dell’esistenza umana. Dio è degno che si abbandoni tutto per Lui solo, per occupasi di Lui solo, per lodarLo, per adorarLo e amarLo ogni giorno e tutto il giorno.
Il mondo moderno ha dimenticato il primo precetto dell’amore ancora più del secondo. Se si parla di carità, si pensa ordinariamente all’amore del fratello, ma quasi mai all’amore di Dio. Benché l’amore di Dio non sia separabile dall’amore del prossimo, rimane sempre vero che l’amore di Dio è il primo e principale. Esclusivamente di questo amore diretto e personale per Dio la Scrittura dice: “Ascolta, o Israele, Jahvé è il nostro Dio, Jahvé è uno solo. Ama Jahvé, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutta la forza” ( Dt 6, 4-5 ). La vocazione particolare dei contemplativi nel mondo è di essere in modo speciale un segno e un ammonimento, un grido per far ricordare il primato assoluto dell’amore di Dio stesso, amore con tutto il cuore, tutta l’anima e tutte le forze. Per poter offrire a Dio tutto il nostro cuore, il nostro pensiero e le nostre forze, lasciamo le molteplici distrazioni del mondo, quelle che riempiono l’immaginazione e la mente e quelle che trascinano il cuore e la volontà. È questa misteriosa passione di Dio che ci ha condotti qui in questo eremo.
È certo che la vocazione alla vita contemplativa è una speciale vocazione all’intimità con Dio. Essa è come una anticipazione della vita eterna. Ha un’importanza speciale nella Chiesa poiché realizza in modo eminente l’essenza stessa della Chiesa – Comunità di preghiera in via verso il supremo incontro con Dio nella vita eterna. In questo sta la bellezza e la sublimità, ma anche la difficoltà della vita contemplativa. Vivere “facies ad faciem” con l’Invisibile, l’Infinito, perseverare davanti all’insondabile Mistero tutta la vita e non scoraggiarsi, non fuggire verso le cose mondane che sono della nostra natura materiale, è una cosa non solamente difficile per l’uomo ma, senza l’appello e la potente grazia di Dio che ci attrae misteriosamente al suo cuore, una cosa veramente impossibile, tanto più che noi siamo non soltanto esseri umani, ma anche peccatori. Di questa forma di vita, senza dubbio sovrumana, siamo responsabili giacché ne abbiamo ricevuto la grazia.
II. Ma qui viene il secondo elemento essenziale della vita contemplativa. Il primo – abbiamo detto – è una caratteristica passione per Dio e per il divino, propria dei contemplativi. Questa passione di Dio si ritrova in modo eminente nella nobile figura del nostro Fondatore, il Beato Paolo Giustiniani. È amore per Dio totale, intransigente e senza compromessi. Il secondo elemento è fiducia in Dio, assoluta e totale. Siamo convinti – Carissimi – che la nostra vocazione sia totalmente soprannaturale, che non sia affare di forze umane, né di capacità umane, né di calcoli umani, ma una chiamata personale del Signore onnipotente e fedele. Non cerchiamo il nostro appoggio in noi stessi, la nostra gioia, la nostra contentezza in noi stessi, nelle nostre forze e capacità che abbiamo ricevute da Dio. Non è però questo il nostro sostegno. Tutto questo può esserci e può anche mancare, come pure la nostra salute corporale. Osserviamo che nella S. Scrittura non c’è forse niente che Dio domandi da noi con maggior insistenza che la fiducia, di riporre in Lui tutta la nostra fiducia, tutta la nostra speranza.
Se Dio è venuto nel mondo per essere con noi, l’uomo non ha più diritto di sentirsi solo nei suoi combattimenti, nei suoi problemi, nelle sue difficoltà personali. Il Signore chiama: “Venite a me” (Mt 11, 28). Andiamo dunque, non siamo soli, non siamo soli mai, se è vero che il Signore ha voluto venire nel mondo per essere con noi. Il Cristo è la risposta, l’unica risposta divina a tutti i nostri problemi, a tutte le nostre difficoltà. Non cerchiano nient’altro. È la nostra risposta alla divina vocazione, è una risposta di fiducia senza limiti. Penso che, alla maggioranza di coloro che non hanno perseverato nella vocazione eremitica, sia mancata proprio questa fiducia.
Vediamo questa fiducia eroica nella vocazione di Abramo. Dio gli disse: Esci dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre…(Gn 12, 1) E lui partì senza sapere dove andava, ha abbandonato tutto senza ricevere niente, nessun appoggio umano fuori della fedeltà di Dio che non delude mai. La fiducia perfetta è come un salto da un aereo senza paracadute nelle braccia aperte di Dio. Ispiriamoci dunque nella nostra vita alla grande fiducia dei Santi e non dimentichiamo mai, e specialmente nei momenti duri della tentazione, dello scoraggiamento, del buio, la presenza di Dio e la sua indefettibile fedeltà.
III. Il terzo elemento essenziale a una vita veramente monastica è l’accettazione della dottrina evangelica sul vero sviluppo dell’uomo. L’uomo vuole svilupparsi o – come si dice oggi – “realizzarsi”. Di questo parlano spesso i giovani religiosi, ma spesso dimenticano l’insegnamento di Gesù Cristo in questa materia. La divina dottrina sul vero sviluppo spirituale dell’uomo si trova nel cap. 12 del Vangelo di San Giovanni. Il Signore ci parla e dice: In verità, in verità vi dico: Se il chicco di frumento non cade in terra e vi muore, resta solo; se invece muore, porta molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna (12, 24). C’è nel nostro cuore un misterioso desiderio di questa morte. Non uccidiamo questo delicato anelito – è l’istinto della grazia. Forse saremo felici di poterlo realizzare un giorno. È lo Spirito che ci dice: “Non temere il sacrificio della tua vita. Non temere di perdere la tua vita in questo mondo per vivere in pienezza, non temere di sacrificarti a Dio nei tuoi fratelli, di sacrificare il tuo proprio benessere alle necessità della tua Famiglia eremitica. Non temere di rinunciare a questo… a quello… non temere”. Lo Spirito ci dice di non temere perché non sono i buoni desideri che ci mancano, ma il coraggio delle forti decisioni. Rimane però la verità che si deve morire per vivere, per “realizzarsi” veramente, si deve perdere la propria vita. Questa è la sapienza del Vangelo. Mai l’egoismo che cerca di conservarsi arriverà alla contemplazione.
IV. Il quarto elemento della vita monastica contemplativa è l’umiltà. S. Benedetto, volendo istituire una scuola del servizio di Dio, ci mostra una via dritta per arrivare alla gloria celeste. Questa via è l’umiltà. È vero che veniamo alla vita camaldolese per umiliarci davanti al Signore fino in fondo. L’ascensione spirituale dell’Eremita è realmente una umiliazione sempre più profonda dinanzi a Dio e una sottomissione sempre più perfetta, totale e amorosa alla sua volontà. Questo atteggiamento di totale umiliazione e sottomissione a Dio fa entrare nella vera pace di Dio, dove una profonda contemplazione si fa possibile.
3. Umiltà
Il capitolo settimo della nostra Santa Regola è d’importanza capitale. Si può in questo capitolo vedere come un sommario della vita spirituale del monaco, un itinerario dell’anima monastica a Dio. È la via dell’amore, siccome – secondo la bella espressione di San Francesco di Sales – l’umiltà è “un amore che scende”. San Benedetto ci presenta un tipo di monaco tutt’altro che raggomitolato su se stesso in un atteggiamento di timidezza e di affettata modestia. L’umiltà fa dei monaci una vera stirpe dai tratti netti e vigorosi, temprata nelle dure battaglie della fede e nella diuturna fatica del ritorno a Dio per la via dell’obbedienza; una stirpe di servi, allenati al superamento dell’egoismo e pur sempre consapevoli di essere inutili e – come tutti gli altri uomini – peccatori. Monaci autentici, dunque, sono coloro che non vanno “in cerca di cose grandi” (Sal 130, 1c), ma, al contrario, guardano con animo da bambini a colui che solo è grande e che tuttavia si è fatto l’ultimo di tutti, per dare l’esempio da seguire: Imparate da me che sono mite ed umile di cuore (Mt 11, 29). L’insegnamento fondamentale messo in programma nella scuola del servizio divino è proprio quello che fa apprendere a camminare umilmente con Dio.
Noi dovremmo distinguerci soprattutto in questo, ma spesso non sappiamo nemmeno capire quanto ci manchi per essere almeno un po’ riconoscibili quali appartenenti alla stirpe dei miti e umili di cuore! Miti non sono i “rassegnati” ma i “forti” che sanno piegare se stessi, con l’aiuto di Dio, sempre guardando al Cristo che si è abbassato fino all’estrema umiliazione. Se vogliamo essere sinceri dobbiamo riconoscere che tutte le nostre punte di risentimento sono dovute a mancanza di umiltà; tutti i nostri scoraggiamenti, le nostre malinconie, le nostre tristezze, i nostri abbattimenti sono dovuti a mancanza di vera umiltà, perché non sappiamo accettare come normale la via della Croce. Vorremmo camminare comodamente, senza rimetterci troppo; anche nell’impegno della Santità siamo sempre tentati da questa paura; santi sì, ma non a troppo caro prezzo!
Chi si esalta, sarà umiliato… (Lc 14, 11; 18, 14): quanti sono i modi in cui ci si esalta, si resiste o, ci si affanna in ciò che non è la pura ricerca di Dio! C’è un modo di esaltarsi che consiste nel non saper accettare con amore e profonda convinzione di fede le situazioni dure e contrarianti ma provvidenziali, che ci impongono distacco e sacrificio nel rapporto con gli altri o nel nostro cammino interiore. C’è un orgoglio che consiste nel non avere la giusta conoscenza della propria realtà, nel non accettare la verità su se stessi, e quindi nel fare in modo di “tenersi su” di fronte agli altri, rifuggendo da tutte le situazioni che potrebbero mettere in evidenza i nostri limiti.
Ecco come si comporta chi vuole camminare nell’umiltà: davanti a qualsiasi trattamento o situazione, si sente in certo modo fortunato e prova gratitudine profonda, sincera, perché è convinto che gli altri fanno sempre troppo per lui. Chi invece non è umile o almeno desideroso di diventarlo, è sempre scontento; ha sempre l’impressione di non ricevere quanto merita. L’orgoglio ha reso Lucifero, angelo della luce, scontento di Dio e invidioso della sua gloria. Quando anche noi siamo scontenti degli altri e di tutto, non illudiamoci, è segno chiaro che siamo egoisti e superbi. Ogni esaltazione è una specie di superbia… (Regola, cap. VII): esaltazione sono gli atteggiamenti contenziosi di chi non si mette mai al suo giusto posto, o non ritiene mai di esservi messo. Si può perfino trascorrere tutta una vita rammaricandosi per la mancanza di circostanze favorevoli (o di persone illuminate) che mettano in risalto le nostre vere capacità! C’è un modo di pretendere stima o premura che può anche non sembrare amor proprio, ma di fatto lo è. “Ogni esaltazione…”: torniamo a dirlo: ogni “tentativo di tenerci su”, di non lasciarci buttare giù dalle nostre illusorie altezze, si oppone allo spirito del Vangelo, del Cristo. Occorre dunque acquistare la mentalità della Croce; abbassandosi si viene innalzati, innalzandosi da se stessi si precipita invece nel vuoto. Con Gesù Cristo, Dio fatto uomo, è avvenuto un capovolgimento dei valori.
Se, dunque, fratelli, noi vogliamo toccare le vette della più grande umiltà, se noi vogliamo giungere rapidamente a questa celeste altezza, cui si può salire mediante l’umiltà della presente vita, dobbiamo innalzare – ascendendo con i nostri atti – quella scala che apparve in sogno a Giacobbe, sulla quale egli vedeva angeli scendere e salire. Certamente questa visione vuole significare che l’esaltazione dell’orgoglio fa discendere, mentre l’abbassamento dell’umiltà fa salire (Regola, cap. VII). Tutta la spiritualità monastica, se può aver avuto interpretazioni diverse circa l’ascesi corporale, o circa la forma della preghiera, ha però sempre ritenuto l’umiltà quale valore fondamentale che ci pone alla radice di qualsiasi vocazione a Dio. “Il monachesimo – dice Padre Adalbert De Vogüé – si è sempre manifestato come una via di umiltà. Nell’ambito cenobitico questa umiltà si realizza nella dipendenza economica (povertà); nell’obbedienza (non auto-determinazione); nel nascondimento, nella pazienza che è un modo di mettersi sotto gli altri”.
Il primo grado di umiltà consiste nel porsi sempre davanti agli occhi il timor di Dio, per evitare nel modo più assoluto di vivere da smemorati. Occorre infatti ravvivare sempre il ricordo dei divini comandamenti e considerare ogni momento la realtà dell’inferno che – come fuoco divorante – consuma, per i loro peccati, i disprezzatori di Dio, mentre per coloro che li temono è preparata la vita eterna (Regola di S. Benedetto, cap VII). Ecco dunque qual è il contenuto del primo grado dell’umiltà: è consapevolezza della presenza di Dio; rinnovare continuamente il ricordo di Lui per fuggire la smemoratezza dell’uomo superficiale e svagato. Secondo San Benedetto l’umiltà è una virtù essenzialmente contemplativa. Non si arriva all’umiltà – come Lui la capisce – per esercizi di auto-disprezzo e di umiliazione. Essa scaturisce direttamente dal contatto con Dio e dalla meditazione della verità totale su Dio e sull’uomo.
Il primo grado di umiltà ci dice che la pratica dell’umiltà si inizia con un esercizio continuo e paziente di mettersi davanti agli occhi la pienezza di questa verità. Questo deve essere un vero esercizio ascetico: “Sibi ante oculos semper ponens, oblivionem omnino fugiat”. Contrariamente a ciò che caratterizza l’uomo moderno, che non tratta Dio con serietà, San Benedetto vuole che il suo monaco viva davanti al Signore e davanti a tutto ciò che Dio ci ha rivelato. Per i moderni Dio è così misericordioso che i peccati non costituiscono nessun pericolo per la salvezza. In ogni caso una onesta mediocrità può sempre bastare per contentare il Signore… S. Benedetto mette il suo monaco davanti a tutta la pienezza del problema della salvezza dell’uomo. Anche il monaco deve meditare la realtà dell’inferno come pena del peccato e, d’altra parte, deve elevare il suo spirito con la speranza e il desiderio ardente della vita eterna. Così al principio del suo cammino spirituale il monaco deve trattare Dio, la sua volontà, i suoi comandamenti, il suo giudizio e le sue sanzioni con una serietà diciamo estrema.
Nella Regola di San Benedetto i gradini dell’umiltà riguardanti l’atteggiamento esteriore dell’uomo si trovano alla fine della sua scala. Un lettore superficiale della Regola può essere sorpreso di trovare prescrizioni sul parlare e sul riso – che sembrano essere molto più facili e accessibili – dopo il settimo grado che contiene la vetta dell’umiltà spirituale. Questo ordine mostra l’intenzione dell’Autore della Regola di formare prima di tutto lo spirito, affinché le manifestazioni esteriori dell’umiltà siano emanazioni di una umiltà interiore autentica e profondamente vissuta, e non soltanto atteggiamenti formati per un’ascesi esteriore priva di contatto con Dio e priva del timore di Dio, che ne deve essere la sorgente e l’anima. Quindi, l’ascesi benedettina è costruita su una piena e costante consapevolezza della verità rivelata. Un contatto spirituale costante con questa verità totale è nell’anima umana la sorgente di un dinamismo speciale, il quale come semplice affermazione di Dio è amore, e, come una sottomissione a Dio, atteggiamento che sempre e in tutto conta con Dio e con la volontà di Dio, è il timore di Dio. Da questi due risulta l’umiltà, che è insieme un’affermazione totale di Dio e una sottomissione anche totale a Lui.
Una vita fuori della verità e fuori della presenza ardente di Dio non può essere purificata. Abbiamo quindi in questo primo grado di Umiltà una dottrina della purificazione spirituale, una salda e provata dottrina della via purgativa. Ma questa potenza purificatrice agisce se il monaco “fugge in tutti modi la dimenticanza”; se invece non è consapevole di tutte quelle grandi realtà, la fiamma di Dio non lo purifica e rimane nei suoi peccati siccome manca di lucidità per conoscerli e di forza per combatterli. Stando davanti a Iddio l’uomo comincia a rendersi conto dei suoi peccati e poco a poco diviene capace di scorgere e di controllare i diversi movimenti del suo cuore.
E guardandosi in ogni istante dai peccati e dai difetti dei pensieri, della lingua, delle mani, dei piedi e della propria volontà, ma anche dai desideri della carne, l’uomo consideri che Dio dal cielo lo guarda sempre, e che le sue azioni in ogni luogo sono osservate dallo sguardo della Divinità, e gli sono riferite continuamente dagli angeli (Regola, cap. VII) L’uomo senza raccoglimento interno, senza consapevolezza della presenza di Dio, l’uomo che si lascia vivere così in superficie, non arriva mai alla conoscenza di se stesso. Egli non sa niente dei diversi movimenti che agiscono nella sua anima. Un tale uomo è incapace di purificazione. Per lui entrare nel sistema ascetico di San Benedetto con gli esercizi del I° grado di umiltà significa una vera e profonda conversione.
4. Ispirazioni di Dio (I) [3]
Carissimi Confratelli!
Una cosa che è essenziale per la nostra vita eremitica è ciò che chiamerei l’ascolto continuo di Dio. È cosa propria della vita cristiana, cosa che la distingue da tutte le altre concezioni di vita. La ragione di questa differenza radicale consiste in questo, che la vita cristiana è una convivenza con Dio. La formulazione più vecchia di questa realtà si trova già nell’Antico Testamento. Nel primo dei nostri Sacri Libri, nella Genesi, si dice parlando dei Patriarchi: Cum Deo ambulavit. Cioè, “camminava con Dio” (6, 9). È la formula più antica e più semplice della perfezione. Si dice per esempio di Noè: Noè era uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei, Noè camminava con Dio (Gn. 6, 9). Camminare con Dio, essere con Dio, fare tutto insieme con Dio… Come si potrebbe dire più semplicemente ciò che difatti costituisce la perfezione spirituale del cristiano?
Nelle concezioni puramente naturali della perfezione umana si parlerebbe piuttosto della formazione del carattere, dell’acquisto delle virtù. È certo che un carattere nobile, elevato e vigoroso, dotato di un insieme di virtù che rendono l’uomo giusto, prudente, casto, temperante, coraggioso, forte e paziente… costituisce un bene che potrebbe essere presentato come ideale e scopo della vita e degli sforzi morali di un uomo. Nel cristianesimo tutto questo conserva il suo valore, ma non basta.
La Rivelazione divina ci insegna che l’uomo non è chiamato a costruire la propria perfezione morale, ma è chiamato a vivere con il suo Dio in amore e unità con Lui. È vero che questa unità con Dio esige una trasformazione profonda dell’uomo, esige la perfetta purificazione del suo essere, la trasformazione del suo carattere, però non come condizione previa che si dovrebbe compiere con le sole forze umane, prima di incominciare con Dio.
L’unione con Dio non è solamente il fine, lo scopo di tutti gli sforzi del cristiano, ma è insieme il mezzo indispensabile per raggiungere questo ideale, la via per la quale si arriva a questo fine. Noi vogliamo arrivare all’unione con Dio usando come mezzo essenziale la stessa unione con Dio. Cristo non è soltanto la Verità che cerchiamo, non è soltanto la Vita alla quale aneliamo pervenire; Egli è ancora la Via, e l’unica Via per la quale possiamo sperare di pervenirvi. La vita del cristiano che vuole arrivare all’unione con Dio deve cominciare dall’unione con Dio, altrimenti non arriverà al fine al quale mira di pervenire.
Cristo è quindi il primo e non esiste una preparazione a Cristo che sia senza Lui. O Lui è il primo, o non arriveremo mai a Lui. Se la peccatrice del capitolo settimo di S. Luca avesse voluto prepararsi a purificarsi prima di giungere al Signore, non sarebbe mai andata perché una preparazione a Cristo non esiste. Lui per opera di Dio divenne per noi sapienza e insieme giustizia e santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto: “colui che si gloria si glori nel Signore” (1 Cor 1, 30-31). Questa è la caratteristica della vita cristiana a confronto con tutte le altre concezioni di vita e di perfezione umana. Per il cristiano la vita è fin dall’inizio una convivenza con Dio. Se è veramente così, ne risulta che il contatto vitale con Dio è il fondamento, la sorgente dalla quale scaturisce tutta l’evoluzione della vita spirituale umana.
Ma se questa misteriosa convivenza con il Dio Vivente è una realtà, ne risulta un’altra verità che manifesta chiaramente la grandissima differenza tra la vita cristiana e la vita umana concepita come uno sviluppo naturale. Questa verità consiste nella direzione interna dello Spirito di Dio che è il vero Pedagogo, il vero Maestro ed Educatore del cristiano. Questa direzione spirituale compiuta dallo Spirito Santo è doppia: una esterna, che si fa per la Rivelazione e la Chiesa, e l’altra, interna, che si realizza per l’ispirazione personale.
Su questa pedagogia interna dello Spirito, cioè sull’ispirazione, vorrei insistere oggi. È una cosa di importanza grandissima e San Benedetto ne parla nel Prologo della sua Regola, ove attira l’attenzione del monaco sul “deificum lumen” e sulla voce di Dio “quotidia clamans”, la voce di Dio che grida ogni giorno e parla all’anima del monaco. La ragione principale della nostra ricerca di solitudine e di silenzio è appunto questa, che vogliamo metterci in atteggiamento di poter sentire questa voce di Dio poiché, senza udirla, è impossibile per l’uomo progredire nella perfezione spirituale. Il Salmo 27 dice: “A Te, Jahvé, io grido, mia rocca; non farti sordo con me! Affinché facendoti unito con me, io non sia come quelli che scendono nella fossa” (27, 1). Senza questa collaborazione intima con lo Spirito Santo non è possibile alzarci sopra una mediocrità. Le virtù eroiche dei Santi sono manifestazioni della potenza di Dio che opera liberamente nella loro anima sensibile e aperta alle Sue ispirazioni.
Ora dobbiamo riconoscere che la nostra vita eremitica, solitaria e silenziosa è molto adatta a condurre lo spirito umano a quello stato di attenzione interna alle ispirazioni divine. Veramente si sente con facilità Dio nella cella dell’eremita, se soltanto si vuole sentirLo e accettare la Sua direzione. Nella vita umana ordinaria, in mezzo alle occupazioni mondane, i cristiani spesso neppure hanno un’idea delle ispirazioni dello Spirito Santo. Lui è presente e agisce anche nella loro vita, ma il chiasso mondano, la fretta oggi quasi continua, la molteplicità delle cose da pensare e da fare, l’infinità di impressioni diverse che produce ogni giorno la vita moderna, rendono veramente difficile questa attenzione spirituale a Dio, presente e parlante. Invece – l’esperienza ci mostra – come è facile, vivendo nella cella eremitica, renderci conto della volontà di Dio, delle preferenze del Signore che ci spingono con delicatezza a tale preghiera, a tale rinunzia, a tale umiliazione. Vere possiamo dire col Profeta Baruch: “Noi beati, o Israele, perché ci è noto quello che piace a Dio” (Bar 4, 4).
5. Ispirazioni di Dio (II) [4]
Abbiamo detto l’ultima volta che la nostra vita di solitudine e di raccoglimento crea delle condizioni ottime per conoscere la volontà di Dio e sentire le sue ispirazioni. Quanto più siamo raccolti, tanto più Dio ci spinge internamente a una conversione vera, profonda, coraggiosa, ci spinge a intraprendere con una decisione virile questo “viaggio” santo verso Gerusalemme, del quale ci parla il Salmo 83 nella nostra Santa Liturgia. Ciascuno di noi sente in se stesso questa voce dello Spirito che parla senza parole.
L’ispirazione non cambia ogni giorno, non ci propone ogni giorno un’altra cosa. Dio nell’anima agisce piuttosto così: le suggerisce di fare questo, o lasciare questo, rinunciare a questo… e poi il giorno seguente o forse dopo settimane o mesi ritorna allo stesso e dice: “Perché non l’hai fatto? Io aspetto ancora… se lo farai, potrà essere una cosa d’importanza decisiva per il tuo progresso, per la tua vita intera… Non mi rifiutare…” Così, in questo dialogo quotidiano con il Signore, se l’anima si sforza di essere fedele, maturano delle decisioni interne che rendono l’anima capace di fare cambiamenti profondi e decisivi nella vita, ai quali senza questo assiduo dialogo non avrebbe né luce né coraggio di pervenire.
Ma si deve anche prendere in considerazione un’altra verità, cioè che le ispirazioni divine non bene accettate possono creare una situazione spirituale pericolosa, se l’uomo sa bene cosa dovrebbe fare per piacere al Signore e nondimeno non lo fa. Di questo pericolo ci parla la Santa Scrittura. È veramente raccapricciante ciò che dice il Salmo 80: Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire: Israele, se tu mi ascolterai, non ci sarà in te dio straniero, né ti prostrerai a un Dio forestiero. Sono io, Jahvé, il tuo Dio, che ti feci uscire dalla terra d’Egitto. Apri la bocca e la riempirò. Ma non diede ascolto il mio popolo alla mia voce e Israele non volle saperne di me (80, 9-12). Dio chiede questo ascolto per il bene dell’uomo stesso, e dice quali sono i vantaggi di un tale atteggiamento di attiva sottomissione dello spirito umano al Signore. Il principale vantaggio è la conoscenza del vero Dio, che fa svanire tutti i falsi dèi, tutti valori illusori: “non ci sarà in te dio straniero, né ti prostrerai a un dio forestiero…”. Allora conoscerai che “io sono Jahvé, il tuo Dio, che vi fece uscire dalla terra d’Egitto”. Secondo il salmista il frutto di questo fedele ascolto del Signore, di questa prontezza a compiere la sua volontà, sarebbe una conoscenza personale di Dio come Dio nostro, come il Dio Salvatore che ci ha salvato dalla servitù egiziaca. La munificenza di Dio in favore di quelli che Lo vogliono ascoltare viene brevemente espressa in questa piccola frase del Salmo: “Apri la bocca e la riempirò”.
Difatti, il popolo di Israele non si è mostrato fedele ad ascoltare il suo Dio, né desideroso di compiere sempre la sua santa volontà. Le conseguenze sono state terribili. Ecco cosa ne dice il Signore stesso: “Ma non diede ascolto il mio popolo alla mia voce, e Israele non volle saperne di me”. Quali sono state le conseguenze di un tale atteggiamento, vediamo: E li abbandonai alla ostinazione del loro cuore; camminino pure nei loro voleri! (80, 13). Non ci può essere una punizione più terribile in questo mondo. È veramente una cosa spaventosa esser così abbandonati da Dio ai nostri propri voleri, ai pensieri del nostro proprio cuore, senza la luce divina che ci conduca in questo tenebroso mondo. Questa punizione è per quelli che non vogliono ascoltare il Signore quando parla al loro cuore sulla strada della loro vita. Difatti, che cosa può essere più spaventoso per un uomo dell’essere lasciato così alle tenebre del suo povero intelletto accecato?
Ma Dio è sempre pronto ad aiutarci. Dopo questa minaccia il Signore continua nel Salmo: Se il mio popolo mi ascolterà, Israele se camminerà nelle mie vie, in breve piegherò i loro nemici… e lo nutrirò di fior di frumento e lo sazierò con miele della rupe” (80, 14-15a.17). Il peccato dell’indocilità è molto pericoloso, ma con Dio è sempre possibile ripararlo presto e totalmente per una rinnovata volontà di ascolto.
Per renderci sensibili alle divine ispirazioni dobbiamo prima essere molto attenti alle espressioni ordinarie della volontà di Dio, e prima di tutto coltivare nella nostra anima un desiderio sincero e ardente di compiere in tutto la volontà del Signore, di sottometterci a Lui in tutti i nostri desideri e tutte le nostre azioni. Penso a questo atteggiamento dell’anima che si trova perfettamente espresso nel Salmo 118: “Con tutto il mio cuore Ti cerco, non farmi deviare dai Tuoi precetti. Nel mio cuore celo i Tuoi detti, per non peccare contro di Te, Benedetto sei Tu, Signore, insegnami i Tuoi decreti. Con le mie labbra ripasso tutti i giudizi della Tua bocca. Sulla via delle Tue testimonianze gioisco più che per ogni ricchezza. Sui tuoi ordini io medito e considero i Tuoi sentieri. Nei Tuoi decreti mi allieto, non dimentico la Tua parola” (118, 10-16). Questo è un atteggiamento spirituale perfettamente benedettino. Questo ardente desiderio di sottomettersi perfettamente a Dio, di fare solamente la Sua volontà costituisce il fondamento di una spiritualità sana e sicura. A una tale volontà Dio non resiste, e lo Spirito Santo non nega le sue ispirazioni.
In questo clima spirituale si sviluppano quelle realtà che nella teologia spirituale si chiamano doni dello Spirito Santo. Questi doni sono diversi e la tradizione ne enumera sette. Ma tutti hanno questo di comune, che sono delle disposizioni che rendono l’uomo capace di sentire le ispirazioni dello Spirito Santo. Una immagine può facilitare la comprensione di questa dottrina. In questo ambiente ove ci troviamo ci sono innumerevoli onde elettromagnetiche portatrici di voce umana provenienti da molte stazioni radiotrasmittenti. Ci sono discorsi, ci sono concerti di musica, ecc… Sono qui, in questo spazio dove siamo noi, ma non possiamo udire tutte queste voci non avendo un apparecchio adatto per captare queste onde. E così tutta questa realtà benché presente ci sfugge. Così le anime che non hanno in sé questi doni dello Spirito abbastanza sviluppati mancano dell’organo necessario per incontrare e sentire queste sottili voci dello Spirito che parla. La Santissima Vergine Maria, Sposa dello Spirito Santo, aveva questi doni in una tale pienezza che tutte le ispirazioni e le mozioni dello Spirito furono nella Sua anima pienamente efficaci. Il primo dono, fondamento di tutti gli altri, è il dono del timore di Dio. È appunto questo dono che fa prendere all’anima l‘atteggiamento del quale abbiamo parlato sopra, cioè l’umile e ardente desiderio di una sottomissione totale al Signore.
6. I comandamenti di Cristo (I) [5]
Insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato (Mt 28, 20). Abbiamo visto sabato scorso che il Signore Gesù, incontrandosi dopo la sua Risurrezione con i suoi discepoli in Galilea, li ha mandati nel mondo per istruire tutte le genti e battezzarle nel nome… Come attrezzatura per questo difficilissimo incarico ha dato loro la Sua potente Parola e l’inesauribile tesoro dei Sacramenti: “istruite tutte le genti battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28, 19). Alla proclamazione della salvezza e al dono dei sacramenti aggiunse ancora un terzo dono: l’istruzione morale: “insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato”.
È certamente essenziale per un cristiano sapere che è stato riscattato dalla potenza tenebrosa del peccato e della morte per la Misericordia infinita del Padre e la Croce salvifica del Figlio, credere nella risurrezione e la vita eterna. È anche essenziale partecipare a questa realtà mediante i sacramenti; ma il cristiano come discepolo di Cristo deve ancora sapere come vivere secondo questa grazia, deve conoscere la via nuova discesa dal cielo sulla terra per poter camminare secondo essa. Il Signore non ci lascia senza istruirci anche in questo campo importantissimo della vita umana: “insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato”. La Parola di Dio non solamente ci rivela ciò che Dio ha fatto amorosamente per noi, ma ci fa vedere anche quello che noi dobbiamo fare in amorosa risposta alla sua grazia immensa.
Così è vero ciò che dice il Salmo 118: “Lampada al mio piede è la Tua parola, e luce al mio cammino” (118, 105). Ma quando un cristiano pensa ai comandamenti del Signore, pensa ordinariamente al Decalogo. È giusto questo perché il Decalogo conserva sempre il suo valore e la sua attualità. Però, se si limitano le esigenze di Dio a quelle espresse nel Decalogo anche estendendole al loro prolungamento spirituale, si perde molto della luce nuova apportata dal Vangelo. Quindi, se il Signore Gesù ha mandato i suoi Apostoli per insegnarci ad osservare tutto ciò che Lui “ha comandato”, deve essere molto attento il cristiano, quando legge il Vangelo, di non trascurare queste numerose espressioni della volontà del Signore, ma di sforzarsi di essere obbediente ad esse. Certamente questi precetti del Vangelo sono molto numerosi e non è possibile per noi qui meditarli tutti, ma per svegliare la nostra attenzione, affilare la coscienza e aguzzare il desiderio, sarà buono meditarne almeno alcuni.
Quando parliamo dei Comandamenti di Dio, c’è una cosa che dobbiamo sempre prendere in considerazione. Penso a questa verità fondamentale, che il dono di Dio sempre precede le sue esigenze. Quindi, le esigenze di Dio sono rivelazioni del suo dono, sono conseguenze e come l’altra faccia della sua grazia. Dio esige ciò che ha dato e niente di più. San Agostino l’ha capito bene e quando dice: “Domine da quod iubes, et iube quod vis” (Signore dacci ciò che comandi e comanda ciò che vuoi). Quindi, rivelandoci ciò che dobbiamo, Dio ci rivela ciò che possiamo, ci rivela le forze e le possibilità della nuova natura che ci ha dato in Cristo Gesù.
Tra le parole di Gesù troviamo una che ricorre molto spesso sulle labbra del Signore. Gesù ama dire agli uomini “Non temete”. Questa parola ha un doppio significato. (1) Essa costituisce l’espressione della nuova relazione dell’Umanità con Dio nel Nuovo Testamento. È una relazione di vicinanza, di amore, di comunione. In questo senso l’Angelo disse a Maria e, in sua persona, a tutta l’umanità: Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio (Lc 1, 30). Queste parole, indirizzate principalmente a Maria, riguardano noi tutti. A ciascuno di noi si potrebbe dire: “Ne timeas, invenisti gratiam” (Non temere perché hai trovato grazia). L’Annuncio dunque dell’Angelo a Maria è l’annuncio del Nuovo Testamento, l’inizio del Nuovo Testamento. Questo stesso senso ha la parola di Gesù alle donne ritornanti dal sepolcro : “Non temete, andate a dire ai miei fratelli…” (Mt 28, 10). Si deve dunque avere un rispetto infinito per Dio, non dimenticando però l’amore che cambia tutto e fa dire al Figlio di Dio: “miei fratelli”. Il primo senso di questo comandamento: “non temete”, comporta dunque una relazione con Dio del tutto nuova, una relazione di comunione figliale. Dio vuole che l’uomo conformi il suo atteggiamento riguardo a Dio alla grazia della filiazione ricevuta.
(2) Il secondo significato di questo comandamento: “non temete”, è differente. Nella descrizione evangelica della tempesta sul mare San Marco scrive: “Sopravvenne un violento turbine di vento che spingeva le onde nella barca, in modo che essa ne era già piena. Ed Egli, a poppa dormiva sopra un cuscino. Lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non t’importa che periamo? Ed Egli, svegliandosi minacciò il vento e disse al mare: Taci! Calmati! E il vento cadde e si fece grande bonaccia. Poi disse loro: Perché avete paura così? Come! Non avete fede?” (Mc 4, 37-40). In un altro luogo dice: “Sono io, non temete” (Gv 6, 20). Il coraggio è dunque un obbligo per un discepolo di Cristo. Se il Creatore del cielo e della terra è con noi, che cosa possiamo temere? Dio vuole che facciamo nostre le forti parole del Salmo 45: “Dio è per noi rifugio e presidio; aiuto grande si mostrò nelle strette. Perciò non temeremo se si stravolge la terra, se crollano i monti nel cuore dei mari. Mugghino e spumeggino pure le loro acque; tremino i monti quando si gonfiano. ( ) Jahvé degli Eserciti è con noi; è Rocca per noi il Dio di Giacobbe” (45, 2-4.8). E San Paolo nel suo inno all’amore di Dio nella Lettera ai Romani scrive: “Chi potrà strapparci dall’amore di Cristo? Quale tribolazione, angustia, persecuzione, fame, nudità, pericolo, spada? Se pur sta scritto: ogni giorno per Te siamo messi a morte. Siamo trattati come pecore da macello. Di tutte queste prove trionfiamo appieno, grazie a Colui che ci ha amato. Certamente né la morte, né la vita, né gli angeli, né i principati, né il presente, né il futuro, né le potenze, né cose alte o profonde, né alcun’altra creatura ci potranno separare dall’amore di Dio che ci giunge nel Cristo Gesù, nostro Signore” (Rm 8, 35-39 ). Il comandamento evangelico del coraggio cristiano è fondato sull’Amore di Dio, sulla sua irrevocabile fedeltà e presenza nella vita del discepolo. Il coraggio è inseparabile da una vera fiducia in Dio. Mandando i suoi discepoli al combattimento che li condurrà fino al martirio, il Signore Gesù dice: “Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l’anima; (…) Due passeri non si vendono forse per un asse? E non uno di essi cade a terra senza la permissione del Padre vostro. Quanto a voi, anche i capelli del vostro capo sono numerati. Dunque, non temete” (Mt 10, 28.29-31).
Meditiamo ancora un altro comandamento del Signore. Egli dice nel Vangelo di San Matteo: Venite a Me, voi tutti che siete stanchi e aggravati, ed io vi darò riposo (Mt 11, 28). Si considera queste parole piuttosto come un appello, una amoroso invito. Ma per un vero discepolo di Gesù, che vuole obbedire ad ogni volontà del suo Maestro e Signore, questo invito è anche l’espressione della volontà di Colui che ha ricevuto dal Padre ogni potere nel cielo e sulla terra. Siamo già con Lui e Lui è con noi, e nondimeno dobbiamo ancora venire a Lui.
C’è una solitudine buona, quella degli eremiti che cercano la solitudine per non essere soli, che cercano la solitudine per essere con Lui, cioè per compiere questo suo comandamento: “Venite a me”. Perché esistono tutti questi bellissimi eremi, veri paradisi sulla terra, se non per venire a Lui ed essere con Lui, per compiere questa sua misteriosa volontà di essere con noi? È veramente meravigliosa questa confidenza di Dio che si trova nel Libro dei Proverbi 8, 31: “Mi ricreavo sulla faccia della terra e la mia delizia era tra i figli dell’uomo”. Una confidenza veramente stupenda! Noi difficilmente sopportiamo la compagnia degli uomini e Dio trova la sua delizia tra loro. Ma se ci ha rivelato questo, noi vogliamo procurarGli questa delizia e perciò cerchiamo la solitudine per essere con Lui. Questa è la vera, la buona solitudine, quella che compie il suo comandamento: “Venite a me”.
Ma c’è un’altra solitudine, cattiva, contraria a quella sua volontà. Guardiamo un po’ la nostra vita e consideriamo se non siamo un po’ troppo soli nella nostra vita, nelle nostre decisioni, nei nostri problemi, nelle nostre sofferenze, nelle nostre prove e incertezze, nei nostri sforzi quotidiani del nostro cammino verso la perfezione e la salvezza eterna. Questa solitudine, questa solitaria baruffa dello spirito umano con se stesso senza riposarsi in Lui, non è secondo la volontà di Dio. Dio non si è fatto uomo perché l’uomo fosse solo, abbandonato a se stesso nella sua vita. Tutta la vita dobbiamo imparare a vivere insieme con Dio, a essere con Lui, pensare e agire con Lui, soffrire con Lui. Tutta la vita dunque dobbiamo imparare a compiere questo suo comandamento : “Venite a me, ed io vi darò riposo”.
7. I comandamenti di Cristo (II) [6]
Insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato (Mt 28, 20). Dopo aver esortato i suoi uditori, e noi tutti con loro, di venire a Lui, il Signore disse: Prendete il mio giogo su di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete riposo per le anime vostre (Mt 11, 29). Come, Signore? Tu dici: “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e aggravati, ed io vi darò riposo” (Mt 11, 28), e subito aggiungi: “prendete il mio giogo su di voi”. Tu prometti agli stanchi e agli aggravati un riposo e proponi invece un giogo! È questo il Tuo riposo?… Non sei Tu il gran Aspettato di cui parla il Profeta Isaia dicendo: “Il giogo pesante del popolo e la sbarra intorno alle sue spalle, il bastone del suo aguzzino Tu hai spezzato come nel giorno di Madian?” (Is 9, 3). Tu sei il Liberatore che toglie ogni giogo, e Tu ci parli ancora di giogo, Tu ci esorti a prendere il giogo?
Si, è un giogo di Cristo che dobbiamo portare. In un altro luogo del Vangelo Gesù lo nomina apertamente dicendo: Chi vuole seguirmi rinneghi se stesso e prenda la sua croce ogni giorno e mi segua (Lc 9, 23). L’Uomo è stato liberato dal durissimo giogo del diavolo non per essere senza giogo, ma per assumere il giogo di Cristo che è pieno di dolcezza. Il Signore disse altrove : “Nessuno può servire a due padroni” (Mt 6, 24). E tu forse pensi: “non posso servire a due, e dunque non servirò a nessuno”. Questo non è possibile. L’Uomo è troppo debole per questo. Se non serve Dio, cadrà certamente nelle mani del diavolo. L’unica via per scappare alla servitù del diavolo è di farsi servo di Dio, di appartenere a Lui. Un piccolo stato tra due superpotenze non potrà conservare una perfetta indipendenza, ma cercherà l’appoggio dell’una o dell’altra, rinunziando così a una piena autonomia. La potenza del diavolo è grandissima, uno solo di questi spiriti cattivi è più forte di tutto il genere umano e l’odio che sentono verso gli uomini è tremendo. Se per un solo momento Dio cessasse di custodire l’umanità, queste migliaia di nemici accanitissimi la distruggerebbero subito. Come l’uomo può pensare di poter conservare la sua indipendenza e la sua libertà appoggiandosi su se stesso?
Liberati quindi dal durissimo giogo del diavolo, prendiamo il giogo di Cristo. E bene dice il comandamento del Signore: “prendete”. L’atteggiamento spirituale significato per questa parola “prendete” è molto importante. Significa un’accettazione attiva di un peso come dono del Signore. Così dobbiamo ricevere tutto dal Signore, anche le cose pesanti, come dono del Suo amore. Nella vita spirituale del cristiano, del monaco, la maniera con la quale lui prende il giogo dei suoi doveri, della sua esistenza reale e concreta, il giogo delle sue prove e delle sue sofferenze, ha una grande importanza.
Se un operaio deve portare un sacco di 100 chili di grano, non è certo indifferente come lo prenderà sulle sue spalle; se lo prende male, non potrà camminare con questo peso e lo lascerà presto, ma se sottomette bene le sue spalle al peso, non gli sembrerà esser troppo pesante. Si deve quindi formare in noi questa disposizione d’anima salda e forte, disposizione volonterosa di ricevere, di prendere su di sé con gioia il giogo del Signore. È molto importante questo. Purtroppo ci sono molti anche tra i monaci che sono sempre scontenti di ciò che hanno e non sanno portare il peso della loro vita con gioia. Così, la loro vita si guasta. Questa maniera di ricevere il giogo della nostra vita come dono di Dio, come dono del Suo amore, all’incontro del quale usciamo di noi stessi, farà che “troveremo riposo per le anime nostre”. Il riposo vero non è nella liberazione da ogni giogo, ma nell’accettazione amorosa del giogo del Signore. A questo riposo aneliamo, non a un riposo immaginario, che consisterebbe in una liberazione da tutti i doveri e tutte le sofferenze. Tra tutte queste situazioni possiamo trovare il riposo nel Cuore di Gesù, se vogliamo prendere il suo giogo e fare la sua volontà.
Per incoraggiarci il Signore aggiunge: il mio giogo, difatti, è agevole e il mio carico è leggero (Mt 11, 30). Pensiamo un po’ a queste parole che ci portano luce. Perché, se il peso che portiamo su di noi ci sembra duro e insopportabile, non è forse un segno che non portiamo il carico del Signore, ma un altro carico che non è suo? Spesso accade che l’uomo si piega sotto un peso che non può sopportare. Se volesse analizzare attentamente, potrebbe scoprire che ciò che porta con tale fatica e tale sforzo non è il carico del Signore, ma il giogo della sua propria volontà. Ci immaginiamo di dover assolutamente arrivare a qualche scopo, e non ci poniamo la questione purificatrice, se Dio lo vuole da noi, e allora comincia per noi una triste via di sforzi sterili, pieni di angosce e incertezze, una via senza pace né riposo. Il male non consiste nella grandezza del carico del Signore, ma consiste in questo, che il grande peso che portiamo non è il peso impostoci dal Signore, ma è il terribile peso della nostra volontà propria. Dobbiamo dunque spesso esaminarci per sapere se veramente portiamo il giogo del Signore e non un altro giogo.
Andando dalla Polonia con la macchina verso l’Italia per partecipare al Capitolo Generale dell’anno 1977, un’altra macchina mi ha sorpassato sulle montagne tra Vienna e Graz. Era un Apostolo della strada. Dietro alla sua macchina aveva una grande inscrizione: “Pensa se il tuo viaggio è conforme alla volontà di Dio”. San Giovanni scrive nella sua prima epistola: “Questo è l’amore di Dio: osservare i suoi comandamenti. Comandamenti che non sono gravosi, perché chiunque è generato da Dio sa vincere il mondo” (1 Gv 5, 3-4). San Agostino commentando questo passo scrive: “Tu forse dirai: come non sono gravosi i comandamenti di Dio? È forse facile amare i nemici? È forse facile sopportare persecuzioni?… Fratello mio, non dire che sono gravosi i comandamenti di Dio, quando la Parola di Dio ci insegna che non sono gravosi. Pensa piuttosto che tu non hai ancora ricevuto il dono a te destinato, il dono che rende facile il compimento dei comandamenti di Dio. Prega dunque col gemito della tua volontà per ricevere il dono della facilità. Questo è l’amore di Dio – dice S. Agostino – a cui il carico di Cristo è leggero, o piuttosto egli stesso è il carico di Cristo che è leggero”.
Ma il Signore, quando disse queste parole: “prendete il mio giogo su di voi”, aggiunse ancora una piccola frase: imparate da me che sono mite e umile di cuore (Mt 11, 29). La traduzione italiana di Salvatore Garofolo scioglie in un senso solo l’alternativa che rimane nel testo originale greco, dicendo: “imparate da me ché sono mite e umile di cuore”. Secondo questa traduzione ciò che abbiamo da imparare da Gesù Cristo è appunto la sua mitezza e l’umiltà di cuore. Ma si potrebbe e forse dovrebbe tradurre: “imparate da me perché sono mite e umile di cuore. La mitezza e l’umiltà di Gesù non costituiscono l’oggetto preciso del suo insegnamento, ma sono le qualità di chi vuol insegnare a meritare la fiducia dei suoi discepoli. Gesù è un buon Maestro perché possiede queste qualità di mitezza e di umiltà. Possedendole si capisce che le trasmette anche ai suoi discepoli. Non c’è dunque una grande differenza tra queste due interpretazioni.
8. Imitazione di Dio[7]
Una verità centrale della nostra religione cristiana è certamente quella che in Cristo Gesù siamo divenuti figli di Dio. Dio ci ha salvati e ci ha presi nella Sua Famiglia, creando per la sua ineffabile grazia una relazione di indicibile intimità tra Lui stesso e noi. Questa meravigliosa filiazione apre all’uomo creato “a immagine e secondo la somiglianza di Dio” (Gn 1, 26-27), e poi caduto nel peccato, la nuova possibilità di rinnovarsi a somiglianza di Dio che è ormai il Suo Padre. Di questo profondo rinnovamento spirituale parla San Paolo nell’Epistola ai Colossesi dicendo: “Vi siete spogliati del vecchio uomo con la sua condotta e avete rivestito il nuovo, quello che si rinnova per giungere alla piena conoscenza, secondo l’immagine di colui che lo ha creato” (Col 3, 10). Una caratteristica quindi dell’uomo rinnovato è la sua somiglianza a Dio. Il figlio rassomiglia a suo Padre. Questa somiglianza non è solamente un attributo dell’uomo rinnovato, ma costituisce un programma e un dovere da riempire, non è un carattere statico, ma una sorgente viva di un dinamismo di unione e di assomiglianza. Dal momento che l’uomo è divenuto figlio di Dio, non più la natura umana, ma la Natura Divina, Dio stesso è la norma della nostra perfezione. L’Apostolo può ormai dire: “Siate dunque imitatori di Dio quali figli diletti” (Ef 5, 1).
Il Signore nel Vangelo di San Matteo ci insegna: Avete udito che fu detto: Amerai il prossimo tuo e odierai il tuo nemico. Io, però, vi dico: Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, il quale fa levare il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti, amate quelli che vi amano, quale ricompensa avrete? Forse non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno forse lo stesso anche i pagani? – e infine aggiunge: – Voi, dunque, siate perfetti come il vostro Padre celeste è perfetto” (Mt 5, 43-48). Nell’Antico Testamento Dio aveva detto a Mosè: “Parla a tutta la comunità dei figli di Israele e dì loro: Siate Santi, perché io, Jahvé vostro Dio, sono Santo!” (Lv 19, 2). Notate che Dio non disse a Mosè: “Siate Santi come io, Jahvé vostro Dio, sono santo, ma perché io sono santo”. Segue una enumerazione di prescrizioni legali da osservare. Quindi, non si tratta qui di imitare la Santità di Dio, ma di osservare la Legge di Dio Santo e così di affermare la Sua santità. L’imitazione diretta di Dio appartiene al figlio, e perciò nel Nuovo Testamento, basato sulla filiazione, si dice: “siate perfetti come il vostro Padre celeste è perfetto”. Nel Vangelo di San Luca dirà: “siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6, 36).
Si vede, dunque, che per noi cristiani non esiste più una norma umana di perfezione, ma Dio stesso, il nostro Padre, rivelato dal Figlio, è la noma di perfezione per noi. Un moralista si sente imbarazzato leggendo la parabola del diciottesimo Capitolo di San Matteo. Il Signore vi parla di un re che voleva fare i conti con i suoi servi. Gli fu presentato uno che gli era debitore di diecimila talenti. All’umile preghiera di questo servo il re gli condonò tutto il debito. Ma poi questo servo uscendo fuori si imbatté in uno dei suoi compagni di servizio, che gli doveva cento denari. Secondo le leggi della morale naturale il servo creditore aveva diritto di esigere dal suo debitore il rimborso del suo prestito. La misericordia del re verso di lui non gli faceva perdere il suo diritto alla restituzione di cento denari. Certo, lui li esigeva con troppa severità, ma esigeva il suo. Non era dunque un conato di rapina, ma una esigenza troppo severa di restituzione di cosa dovuta… Perché dunque mandarlo in prigione e “consegnarlo agli aguzzini” (Mt 18, 34) se lui era nel suo proprio diritto?
Qui vediamo chiaramente la distanza tra la norma naturale e la norma evangelica. La norma naturale dice: non trasgredire i tuoi diritti, e la legge evangelica dice: fa come Dio, tuo Padre, ha fatto a te. L’unica norma è quindi Dio stesso e il suo modo di agire. Il Signore lo dice chiaramente: “Allora il re lo fece chiamare e gli disse: Servo malvagio, ti ho condonato tutto quel debito perché mi ti sei raccomandato; non dovevi a tua volta avere pietà del tuo compagno come io avevo avuto pietà di te?” (Mt 18, 32-33). Il servo sarà dunque punito non per aver commesso una ingiustizia, ma per non aver voluto agire come il suo re e Signore. Ecco la norma cristiana – agire come Dio, imitare il Padre per essere vero figlio ed esserlo sempre di più.
Quando si medita sugli attributi di Dio e si pensa quale dovrebbe essere la risposta dell’uomo-figlio a ciascuno di questi attributi, si vede subito un duplice modo di rispondere a questi attributi. Il primo modo è l’imitazione, e il secondo modo consiste nel tirare le conseguenze pratiche del fatto che Dio è così. Per esempio, Dio è Misericordia, il primo modo consisterà nell’imitare la Misericordia divina in tutte le nostre relazioni col prossimo, e il secondo sarà di appoggiarsi in tutto su questa Divina Misericordia. Ci sono degli attributi metafisici di Dio che il pensiero filosofico può dedurre dalla verità che Dio è la Causa Prima di tutto il creato, dunque è la Causa senza Cause, dunque “Ens a se”, necessario, infinito, onnipotente, sommo Bene, ecc… La meditazione di questi attributi metafisici di Dio è di gran prezzo per la vita spirituale.
Ma la Sacra Scrittura ci rivela ciò che si potrebbe chiamare il “carattere di Dio”. Ci mostra il Dio dell’Amore nelle sue relazioni agli uomini, nei suoi contatti con gli uomini, nel suo dialogo con l’uomo che riempie tutta la storia umana e ne costituisce il vero e unico senso. La rivelazione ci mostra il pensiero di Dio, il suo eterno disegno di salvezza in rapporto all’uomo. La Sacra Scrittura ci fa conoscere l’azione di Dio e le sue reazioni ai diversi atteggiamenti degli uomini. Finalmente, ci rivela anche il più profondo mistero della vita interna del Dio, uno nell’unità di Tre Persone. I cattolici moderni, per la figura di umiltà e di modestia dinanzi ai non credenti, dicono spesso: “noi non conosciamo molto, siamo ignoranti nelle cose essenziali della vita più o meno come voi”. Un atteggiamento certamente molto gentile e molto cortese, però non conforme alla verità, un atteggiamento cristiano che fa ingiuria a Dio e alla sua rivelazione. Si dovrebbe piuttosto dire con il Siracide: “Ti fu, infatti, mostrato più di quanto tu non possa comprendere” (3, 22). Possiamo, dunque, ora cominciare a meditare insieme su Dio e i suoi attributi.
9. Immutabilità (I)[8]
Si avrebbe oggi l’impressione che l’antico filosofo Eraclito sia diventato il favorito del nostro secolo. Lui infatti ha fissato il suo sguardo sul cambiamento continuo, sul flusso di tutte le cose esistenti. Nelle celebri parole panta rei, cioè tutto scorre, tutto passa, lui ha espresso la sua intuizione della realtà. La nostra generazione ha perso il senso dell’assoluto e dell’eterno per fissare lo sguardo sul relativo e sul variabile. La legge naturale, considerata da secoli come legge divina e eterna, inscritta per sempre nella natura umana, appare ai moderni come mutabile, come funzione di situazioni storiche, psicologiche, economiche, ecc… L’evoluzionismo e il suo grande eroe, Teilhard de Chardin, che rappresenta tutto il mondo in continua evoluzione, piace ai nostri contemporanei. Temono invece tutto ciò che si presenta come stabile, come assoluto. L’uomo moderno deve essere in un continuo progresso, deve essere creativo e perciò deve fuggire le obbligazioni di una morale che scaturisce da sorgenti eterne. Tutto questo lui vorrebbe rigettare come un “establishment”, come un assideramento che toglie la Libertà e rende il progresso impossibile.
Ma un vero contemplativo è sempre un uomo dell’eterno e dell’immutabile. È bellissima e profondissima l’espressione di S. Agostino, che in una brevissima formula unisce il mutabile all’eterno: “Per incommutabile nunc tuum omnia saecula transierunt”. Il contemplativo sempre gode non di quello che cambia, ma di quello che è immutabile, come dicono i certosini: “Stat Crux dum volvitur orbis”. La contemplazione dell’Eterno rimane sempre la sorgente della vera creatività e di un instancabile dinamismo di progresso autentico. Il miraggio del cambiamento continuo ha tutte le marche di un influsso satanico nel mondo odierno.
Ma ritorniamo all’attributo divino dell’immutabilità e poniamo la questione se è possibile all’uomo figlio di Dio imitare in qualche modo questo attributo del suo Padre celeste. Ci sembra che si dovrebbe dare una risposta negativa alla nostra questione. La mutabilità appartiene all’essenza stessa della creatura, come dunque si potrebbe imitare l’Immutabile? “Ogni carne è come erba e tutta la sua gloria è come fiore del campo. Secca l’erba, appassisce il fiore... Ma la parola del nostro Dio sussiste in eterno” (Is 40, 6.8). Quindi, una opposizione irriducibile? Noi siamo difatti in un continuo cambiamento: cambiano le nostre disposizioni, le nostre occupazioni, le nostre esperienze, le nostre decisioni e risoluzioni, siamo soggetti a un processo continuo di invecchiamento. Come possiamo noi imitare l’Immutabile e l’Eterno?
Ma se è vero che Dio è il nostro Padre, deve esistere una possibilità per noi di imitarlo anche in questo. Infatti la Santa Scrittura ci mostra l’esistenza di una tale possibilità. Apriamo il Salterio. In prima pagina troveremo la duplice immagine del giusto e dei malvagi. Il giusto viene caratterizzato appunto in opposizione alla mutabilità che lo circonda. Lui è stabile: “nella legge di Jahvé è il suo diletto e nella sua legge si addestra di giorno e di notte. E sarà come albero piantato su rivi d’acque, che il suo frutto dà a suo tempo e la sua fronda non cade; e questo lo porta a successo” (Sal 1, 2-3). L’albero ha una radice che lo tiene saldo contro tutti i venti, una radice che attinge le acque nascoste. Così il giusto vive in contatto con Dio, radicato in Dio, mentre i malvagi non trovano nessuna stabilità: “non così gli empi, no! Perché anzi saranno come pula che il vento sospinge” (Sal 1, 4). La pula è leggera, secca, infruttuosa, sempre in superficie, sempre in movimento senza scopo, inutile. Vediamo dunque che è possibile l’imitazione anche di questo attributo divino – dell’immutabilità.
10. Immutabilità (II) [9]
Progrediamo oggi, carissimi Confratelli, nella nostra meditazione su Dio e i suoi attributi. Per i figli di Dio è una cosa utilissima e anche gradevole pensare al loro Padre celeste e trovare la loro gioia nell’ammirazione delle sue infinite perfezioni. Abbiamo parlato l’altra volta dell’immutabilità di Dio e abbiamo posto il problema della possibilità per una creatura essenzialmente mutabile di imitare questo attributo di Dio. A prima vista questo pare essere totalmente impossibile, ma sull’esempio del giusto presentatoci dal Salmo 1 abbiamo visto che questa impossibilità non è totale, che l’uomo può con la grazia del Signore imitare in una certa maniera anche l’immutabilità di Dio, suo Padre.
Nei nostri tempi un artificio diabolico certamente assai pernicioso consiste nel presentare all’uomo come un segno di vitalità superiore l’assenza di ogni regolamento di vita. L’uomo deve essere spontaneo, deve rispondere liberamente e con spontaneità alle situazioni, agli impulsi che cambiano ogni giorno, anzi ogni momento. Una pneumatologia moderna vede in questa spontaneità sempre nuova, libera da ogni regola e da ogni prescrizione, un segno caratteristico dell’azione dello Spirito Santo. Nella luce di questa dottrina l’obbedienza a una regola di vita appare pressappoco come un peccato contro lo Spirito Santo. Invece, la teologa dei santi vedeva nell’obbedienza di un religioso un segno della presenza e dell’azione dello Spirito Santo. Questa apoteosi moderna dello spontaneo conduce direttamente a un indebolimento della volontà, rendendola incapace di vincere se stessa in nulla, né di sottomettersi a lunga scadenza a nessun obbligo. Perciò ho detto che un artificio diabolico si trova all’origine della diffusione di una tale dottrina.
Se si toglie dalla vita umana ogni elemento di stabilità come il dovere, il precetto, una regola di vita, i voti, i propositi, un determinato scopo da raggiungere, la virtù, ecc…, l’uomo è totalmente lasciato alle sue fantasie e ai suoi impulsi. Un tale individuo umano diventa un balocco del diavolo. La pseudo-libertà di un tale uomo è in realtà una schiavitù delle sue tendenze più basse. La Santa Scrittura ci mostra sempre l’instabilità in relazione con la malvagità. Il Salmo 1 paragona i malvagi alla “pula che il vento sospinge”. Il Profeta Isaia ha una bella e molto impressionante immagine nel capitolo 57, 20-21, che mostra l’instabilità e la continua inquietezza dei malvagi: “Gli empi sono come un mare agitato che non può trovar pace, e le cui acque travolgono melma e fango. Non ci sarà pace per gli empi, dice il mio Dio”. Il Signore Gesù nel Vangelo ci mostra il diavolo come essenzialmente instabile e inquieto: “Lo spirito immondo vaga per luoghi aridi in cerca di riposo, e non lo trova” (Mt 12, 43). L’Angelo ribelle ha voluto fare la propria volontà, non ha voluto sottomettersi, non ha voluto accettare la volontà di Dio. È dunque caduto fuori dall’unico luogo di pace degli spiriti creati – il seno di Dio. Adesso e per tutta l’eternità sarà vagante per luoghi aridi in cerca di riposo e non lo troverà mai.
Vediamo – carissimi Fratelli – come è pericoloso per uno spirito angelico o umano non cercare la stabilità che si trova nella sottomissione alla volontà di Dio, ma preferire di seguire la spontaneità dei propri desideri in continua mutazione. L’uomo deve dunque cercare non l’instabilità ma la stabilizzazione in Dio. In questo senso possiamo anche capire le celebri parole di Sant’Agostino : “inquietum est cor nostrum donac requiescat in Te”. Soltanto nel seno di Dio gli spiriti trovano la loro pace e la loro fermezza eterna. Una delle intenzioni principali di San Benedetto, quando scriveva la Sua Regola, era di stabilizzare i monaci. Egli conosceva il suo tempo e osservava il monachesimo contemporaneo. Ha notato il gran pericolo spirituale dei piccoli gruppi di monaci dove ciascuno seguiva il suo piacere, ha notato i monaci girovaghi che si trovavano in uno stato di continuo cambiamento e viaggio. Vedeva tutto questo e ha capito che il monachesimo di quel tempo aveva un grandissimo bisogno di stabilità. Nella sua Regola, dunque, la stabilità è stata garantita per l’introduzione di un voto speciale, proprio al nostro Ordine. San Benedetto ama molto la stabilità, la costanza, la perseveranza, la fermezza del carattere, e desidera che i suoi monaci siano uomini stabili, sui quali Dio, la Chiesa e il monastero possano contare. Lui stesso era un uomo tale che poteva essere d’appoggio per gli altri.
Spesso i giovani che cominciano la loro vita monastica o eremitica incontrano come una delle prime grandi tentazioni, la tentazione di cambiare. Certo, vogliono servire Dio, non hanno l’intenzione di ritrarre la loro donazione a Dio, né il loro proposito di consacrare tutta la loro vita al suo servizio. Ma un pensiero ostinato viene come un ritornello: “Non è qui il tuo posto tu hai sbagliato strada, certamente ti sentiresti meglio e saresti più santo dai Carmelitani Scalzi, o dai Cappuccini, o dai Certosini, ecc…”. È una tentazione assai frequente e pericolosa perché può far di un buon giovane religioso un uomo traviato. Talvolta accade che un cambiamento di Ordine religioso sia inspirato da Dio, ma nella grandissima maggioranza dei casi è una tentazione che ordinariamente rivela un’immaturità della fede che non arriva ancora a radicarsi in Dio. Nella pratica della soluzione di simili casi è certo che “praesumptio stat pro stabilitate”. Il diavolo teme la costanza e spesso preferisce suggerire un ideale anche più alto per indurre a cambiare. Lui è sempre il maestro dell’instabilità. Perciò è giusto, è sapiente il consiglio del vecchio abate Nesteros, nella 14 conferenza di Cassiano, che dice: “se fai qualche cosa di buono non lasciarlo per un’altra cosa migliore, perché non c’è niente di migliore alla perseveranza nel bene”.
Non la spontaneità ma la costanza, la fermezza, la perseveranza, la fedeltà, il senso del dovere…, sono segni di una vera maturità spirituale. A questo atteggiamento morale non si arriva subito. E certamente non si arriva con una predilezione per l’elemento cambiante e variabile della vita. Di questa maturità San Paolo ci parla nell’Epistola agli Efesini dicendo: “Finché perveniamo tutti all’unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, a formare l’uomo maturo, al livello della statura che attua la pienezza del Cristo. Così non saremo più bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, alla mercé dell’inganno degli uomini” (Ef 4, 13-14).
Uno dei più grandi successi del diavolo nei nostri tempi è certamente il crollo della virtù di fedeltà tra i cristiani. Questo proviene in linea retta dall’incostanza e dall’instabilità insegnate dal diavolo alla nostra generazione. Molto nella Chiesa si basa sulla fedeltà a un impegno preso davanti a Dio e alla stessa Chiesa. E che cosa vediamo oggi? Dov’è la fedeltà matrimoniale? Quanti sacerdoti, religiosi e religiose non hanno saputo perseverare nelle obbligazioni prese? Questo è divenuto un fenomeno massiccio. Cristo ha detto nel Vangelo di San Luca: “Chiunque guarda indietro mentre mette mano all’aratro è inadatto per il Regno di Dio” (Lc 9, 62). Cristo insegna dunque che l’uomo è e deve essere capace di obbligarsi per tutta la vita, deve poter mettere mano all’aratro e senza guardare indietro andare fino alla fine della zolla. Molti cristiani di oggi invece, anche sacerdoti e religiosi, pensano che questo sia impossibile, che si deve sempre lasciare all’uomo una possibilità di cambiare. Povero nostro mondo!
Certo, l’uomo non sarà mai immutabile e immobile come Dio. Neppure il Signore Gesù come uomo era immutabile come Dio. Ma c’è un’immutabilità nell’Uomo Cristo che il cristiano può e deve imitare. Come il Verbo eterno sta (pros), cioè verso il Padre, così il Cristo Uomo è tutto verso il Padre. Questo atteggiamento di base non cambia mai, non indebolisce mai, non perde mai la sua intensità e niente può disturbarlo. Così dovrebbero essere nei figli adottivi di Dio la risposta all’immutabilità del suo amore e l’imitazione di essa. Dio è assolutamente immutabile, ogni uomo invece, e anche tutta la Chiesa di Dio, è come una nave sui flutti. Può essere anche fortemente agitata dalle ondate e dall’uragano, ma se un’àncora la tiene non sarà rapita dai flutti e sfracellata sulle rocce. Così il cristiano deve essere ancorato nell’abisso di Dio per la fede e la fiducia. Nonostante dunque la nostra grandissima debolezza, siccome siamo polvere, crediamo che Dio voglia darci la fermezza del pensiero e la potenza dell’amore, affinché possiamo essere fedeli a Lui in mezzo a questo mondo pieno di forze ostili. La teologia tradizionale, e specialmente San Tommaso, insegna il gran valore dei voti religiosi perché confermano la volontà nel bene. Lo stesso scopo hanno anche le regole e le costituzioni. Non sono fatte per complicare la nostra vita, né per far di noi degli automi, ma per dar un appoggio alla nostra volontà, per consolidarla nel bene, come dice San Benedetto: “si quid paululum restrictus, dictante aequitatis ratione ad emendationem vitiorum vel coservationem caritatis processerit. Amen.”
11. La pazienza di Dio [10]
Abbiamo parlato l’ultima volta dell’immutabilità di Dio considerando la possibilità per noi uomini di imitare questo attributo del nostro Padre. Abbiamo visto che, nonostante la variabilità essenziale alla creatura, una certa imitazione dell’immutabilità di Dio è possibile, però soltanto per viam unionis cum Deo. Soltanto in Dio, come ancorato in Dio, lo spirito umano trova questa forza stabile e pacifica che lo alza sopra le ondate della vita e del mondo. L’immutabilità appartiene agli attributi di Dio, ai quali la riflessione filosofica può giungere. L’intelligenza umana è capace di conoscere non solamente l’esistenza di un Dio Creatore, ma anche fino a un certo grado la Sua Essenza. La riflessione intellettuale, libera dalle tenebre del sensualismo moderno, è capace di conoscere l’onnipotenza, la sapienza, l’eternità, l’infinità, ecc., di Dio. Questa capacità radicale dell’intelletto umano di conoscere Dio costituisce un dogma della Chiesa cattolica, definito dal Concilio Ecumenico Vaticano I.
San Paolo nella Lettera ai Romani scrive: “Perché ciò che di Dio si può conoscere è palese in essi, avendoglielo Iddio stesso manifestato. Sì, gli attributi invisibili di Lui, l’eterna sua potenza e la sua divinità, fin dalla creazione del mondo si possono intuire, con l’applicazione della mente, attraverso le sue opere. Costoro sono dunque senza scusa” (Rm 1, 19-20). Ma ci sono altri attributi di Dio a cui la filosofia umana è incapace di giungere. Quelli sono come dei lineamenti del volto di Dio della Rivelazione, come tratti del suo carattere. La pazienza appartiene a questi attributi. La conosciamo dalla Santa Scrittura. Tutta la storia santa, la storia dei rapporti di Dio con l’uomo, costituisce una affascinante rivelazione di questo tratto caratteristico del nostro Padre Celeste. La pazienza di Dio si è impressa in una maniera indelebile nell’esperienza e nella memoria del Popolo di Dio e nell’esperienza personale di ogni vero cristiano.
Nel Nuovo Testamento ci sono due parole che esprimono l’idea di pazienza: (1) makrothumía – pazienza, longanimità: questo concetto di makrothymía può essere applicato a Dio stesso nei suoi rapporti con le creature; (2) hypomoné – pazienza, perseveranza, virtù di quello che soffre: e quindi non si può applicare questo concetto a Dio, ma soltanto all’uomo e al Cristo. Il grande Salmo storico 77 presenta tutta la storia di Israele sotto l’aspetto della straordinaria pazienza con la quale Iddio fedele e misericordioso sopportava le infedeltà e la durezza di cuore del suo popolo: “generazione ostinata e ribelle, generazione di cuore incostante, e di spirito non fedele a Dio” (Sal 77, 8); “Non custodirono l’Alleanza di Dio e rifiutarono di camminare nella sua legge. E dimenticarono le Sue imprese/ e le Sue meraviglie che mostrò loro/ Al cospetto dei loro padri fece prodigi,/ in terra d’Egitto compagnia di Ioan./ Divise il mare e li fece passare,/ e rizzò le acque come una diga./ E li condusse colla nube di giorno/ e ogni notte colla luce di foco./ Le rupi spaccò nel deserto,/ e li abbeverò come il grande abisso./ E fece uscire rivi della roccia,/ corsero a torrenti le acque./ E tornarono ancora a peccare contro di lui/ ribellandosi all’Altissimo nel deserto./ E tentarono Dio nei loro cuori” (Sal 77, 10-18).
Il Salmista ci mostra la provvidenza del Signore, sempre piena di tenerezza e di misericordia per il suo popolo, e dall’altra parte vediamo la durezza di cuore, l’infedeltà e una singola prontezza a dimenticare gli innumerevoli benefici ricevuti. Purtroppo questa è una vera immagine dell’uomo, di noi tutti nel nostro atteggiamento dinanzi a Dio. Considerando la straordinaria, l’ineffabile delicatezza dell’amore di Dio, si vede che l’uomo è uno zotico, un cafone grossolano e rozzo nei suoi rapporti col Signore. La grazia di Dio che deve trasformare questo zotico in un figlio di Dio, pieno di una squisita delicatezza nel suo amore filiale, ha un lavoro grandissimo da eseguire, un vero miracolo che non sarebbe possibile senza l’ammirevole pazienza dell’Amore divino.
Questa pazienza di Dio si manifesta in questo, che Dio preferisce vedere la sua infinita Maestà offesa, che respingere l’uomo. Qui è il Mistero della pazienza divina inaccessibile alla filosofia naturale. Questo profondissimo mistero della Maestà di Dio, oltraggiata e sopportante l’oltraggio per non distruggere l’uomo, si è rivelata in Cristo. Lo vediamo nella stupenda visione di Isaia: “Il Signore Jahvé mi ha aperto l’orecchio/ e io non mi sono opposto,/ non mi sono ritirato./ Ho consegnato il dorso ai flagellatori,/ la guancia ai depilatori,/ non ho nascosto la faccia/ agli oltraggi e allo sputo” (Is 50, 5-6). Dio, Creatore dell’uomo, lo conosce fino al fondo, conosce la sua estrema debolezza, la sua forte inclinazione al peccato. Il suo atteggiamento verso la creatura umana è quindi un atteggiamento di misericordia e pazienza. Come vediamo nella storia dei Niniviti, anche le altre nazioni erano oggetto di questa misericordiosa pazienza di Dio.
Tutta la Storia umana è la storia della pazienza misericordiosa di Dio, sempre di nuovo provocata dall’uomo e sempre di nuovo vittoriosa dell’uomo. E chi tra di noi non può ritrovare nella storia d’Israele la storia della sua propria anima? Chi non può applicare a se stesso i seguenti versi dal citato Salmo 77: “E il loro cuore non era costante con lui/ e non erano fedeli alla sua alleanza./ Ma Egli, pietoso, cancellava la colpa/ e non distruggeva./ E continuava a richiamare la sua ira/ e non suscitava tutto il suo furore./ E ripensava che essi erano carne,/ spirito che va e non torna” (Sal 77, 37-39). San Paolo nel terzo capitolo della sua Lettera ai Romani considera tutto il tempo che ha preceduto la venuta di Cristo come il tempo della pazienza di Dio (cf. 3, 25-26). Non c’era ancora il Sangue divino per lavare le colpe degli uomini. Dio le sopportava quasi con una paziente tolleranza (anoché).
La pazienza e la longanimità sono le virtù del pedagogo. Lui sa che nel processo educativo non si può contare su risultati immediati. Anche un buon allievo ha bisogno di tempo e di pazienza per arrivare a un risultato di valore. Un buon pedagogo lo circonda di bontà e di pazienza, incoraggiandolo a progredire con perseveranza. Così agisce Dio secondo la Sapienza del Siracide: “Il numero dei giorni dell’uomo/ al massimo può arrivare a cent’anni,/ goccia d’acqua del mare e granello di sabbia,/ così pochi quegli anni nel giorno dell’eternità!/ Per questo il Signore è longanime con loro/ e versa su di essi la sua misericordia./ Egli vede e conosce bene che la loro sorte è deprecabile/ e per questo abbonda nel perdono./ La compassione dell’uomo va al suo vicino;/ la compassione del Signore va a ogni creatura;/ riprende, istruisce, ammaestra,/ riconduce come pastore il gregge./ Ha Misericordia di chi riceve l’educazione/ e di chi si preoccupa dei suoi giudizi” (Sir 18, 8-14).
Gesù Cristo stesso parla di questa pazienza pedagogica di Dio nel Vangelo. Una parabola evangelica è consacrata specialmente a questo tema. Parlando della necessità per gli uomini di convertirsi, Gesù mostra Dio come aspettante pazientemente questa conversione. Dio sa aspettare, e la ragione di questa aspettativa divina è sempre la Misericordia. “Diceva questa sua parabola: Un tale aveva un fico piantato nella sua vigna e venne a cercarvi frutto, ma non ne trovò. Disse allora al vignaiolo: Ecco da tre anni vengo a cercar frutto su questo fico e non ve ne trovo; taglialo, a che scopo rendere infruttuoso il terreno? Ma quegli gli rispose: Padrone, lascialo ancora quest’anno, fin tanto che io zappi attorno ad esso e metta letame; se in avvenire farà frutto, bene; se no lo taglierai” (Lc 13, 6-9).
Il Creatore fa alle sue creature il dono del tempo. Tutto ciò che vive ha bisogno del tempo per svilupparsi e arrivare alla maturità. Anche un albero buono, piantato su corsi d’acqua, “dà il suo frutto a suo tempo.” (Sal 1, 3). Il tempo ha dunque per lo sviluppo dell’uomo un’importanza primordiale. Il Signore ci fa il dono del tempo, ci aiuta con le grazie necessarie e aspetta il frutto non subito, ma “in tempore suo”. È per noi una cosa di grandissima importanza ben capire l’importanza del tempo e di pensare a colui, grande Paziente, che ci guarda e ci aspetta con amore. Dio non si affretta, non ha permesso ai mietitori di strappare la zizzania prima della mietitura, ma ha lasciato crescere tutto fino alla messe.
Il debitore insolvibile della parabola di Matteo 18 “si gettò ai piedi del re e gli si prostrava dicendo: Signore sii paziente con me e ti restituirò tutto” (18, 26). Che cosa chiede se non il tempo per poter restituire la somma dovuta? Lui non pensa che il suo debito verso il Re è tale che nessun tempo basterebbe per poterlo restituire. Tutta la nostra vita è un grido verso Dio: “Abbi pazienza Signore”, ma nessun tempo può bastare per la restituzione del mio debito, se Tu non mi aiuti. Il compagno di servizio di questo servo cattivo chiedeva anche il tempo per poter rimborsare i cento denari che doveva. Per lui il dono del tempo sarebbe stato decisivo…
Quando abbiamo la tentazione di giudicare severamente i nostri fratelli perché non sono tali come secondo il nostro parere dovrebbero essere, pensiamo che questo fratello si getta ai nostri piedi e grida: “Sii paziente con me e restituirò!” Perché non vogliamo dare al nostro fratello il tempo del quale tutti abbiamo bisogno per cambiare, per convertirci, per correggerci? Dio dà il tempo a tutti, anche noi lo riceviamo e approfittiamo di questo dono veramente necessario per noi. Ma ai nostri fratelli spesso non vogliamo concederlo. Essi devono correggersi subito, perché questo esigiamo noi. L’ortolano ha la pazienza: lui contempla il lento e misterioso sviluppo delle piante e sa di non poterlo accelerare. L’agricoltore sa che non avrà il grano nell’aprile, anche se ci fosse una urgente necessità. Lui sa bene che in questa stagione non serve a niente uscire nel campo col falcetto. Ma per le leggi dalle quali dipende l’evoluzione dello Spirito e della persona umana spesso manca la comprensione. Ma questa pazienza e questa longanimità ti è necessaria anche per sopportare te stesso, il tuo proprio misterioso sviluppo che tu non capisci, la realtà nella quale tu non sei come vorresti essere. La saggezza dell’uomo è nel sentire il gran mistero della vita, della vita propria e della vita altrui, della vita di tutti i viventi, ma specialmente del Mistero delle operazioni della vita divina nelle anime. La consapevolezza di essere sempre in contatto con questo abissale mistero fa l’uomo umile, delicato e paziente.
12. La pazienza (hypomoné)[11]
L’ultima volta abbiamo considerato la pazienza di Dio, la Sua makrothymià, nel suo rapporto alle creature, e specialmente la sua lentezza a punire i peccanti. Dio dà ai peccatori il preziosissimo dono del tempo affinché abbiano la possibilità di correggersi. San Paolo nella Lettera ai Romani ammonisce gli Ebrei a non abusare di questa pazienza di Dio: “Pensi tu (…) di poter sfuggire al giudizio di Dio? Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza, della sua longanimità, non comprendendo che questa bontà di Dio ti spinge solo al pentimento” (Rm 2, 3-4). Ciascuno di noi deve pensare con grande serietà a questo, che Dio aspetta la nostra conversione, aspetta con una bontà paziente e longanime. S. Paolo insiste dicendo che questa paziente bontà di Dio ci spinge al pentimento. Essa ci spinge anche a usare di una simile longanime e misericordiosa pazienza verso gli altri.
L’Uomo approva Dio quando usa una tale pazienza verso lui stesso, anzi pensa facilmente che questo sia a lui dovuto, ma talvolta sopporta difficilmente la pazienza di Dio verso gli altri, specialmente se sono grandi peccatori. Nei tempi di grandi calamità si vedevano anche credenti sollevarsi contro Dio dicendo: “Come è possibile questo? Dio non vede? Dio non sa? O forse Dio non esiste?” Questo si sentiva per esempio durante l’ultima guerra mondiale: “Come Dio può permettere a un criminale come Hitler con una banda di mascalzoni di opprimere così tanti buoni e innocenti?!” Un mio cugino, che fu ufficiale nell’esercito durante la guerra, mi ha raccontato che ha preso parte alla grande offensiva dell’armata rossa contro la Germania. Tra le operazioni il suo distaccamento è stato accerchiato insieme con un reparto sovietico dalle truppe tedesche. In quel momento i soldati russi hanno preso delle medaglie di Santi e hanno cominciato a pregare. Uno tra di loro si è inginocchiato e alzando le mani al cielo gridava ad alta voce: “Dio dove sei! Tu non vedi che cosa si fa in Russia. Fino a quando vuoi tacere!” Qui è il mistero della pazienza di Dio, mistero che l’uomo non può capire, che deve sopportare con fiducia e speranza. E qui arriviamo all’altro aspetto della pazienza, cioè alla hypomoné.
Abbiamo detto che dei due termini biblici esprimenti l’idea di pazienza soltanto il termine makrothymía può essere applicato a Dio, perché esprime l’idea di longanimità senza racchiudere l’idea della sofferenza nel sopportare. Invece la hypomoné racchiude questa idea: questa era la virtù dei “poveri di Jahvé” nel Vecchio Testamento, quei poveri di Jahvé che appartenevano alle classi umili della società, uomini senza influsso, senza importanza, uomini calpestati dalle bufere della storia, poveri e sofferenti, ma uomini attaccati con tutto il loro cuore a Jahvé, credenti instancabilmente alla sua fedeltà e all’incrollabilità delle sue promesse. L’hypomoné è una pazienza sostenuta da una speranza umile, viva e inflessibile (Sustine Dominum!).
Sentiamo la voce di questa pazienza (hypomoné) nei Salmi, la sentiamo specialmente nelle Lamentazioni di Geremia. Noi non ci rendiamo facilmente conto della grandezza della prova alla quale fu sottomesso il Popolo di Israele: il Tempio di Dio distrutto, la Città Santa Gerusalemme preda delle fiamme, il Popolo cacciato dalla Terra Santa, data dal Signore per sempre, e disperso in mezzo a nazioni pagane. Come capire questo? Come non rompersi in disperazione? Su che cosa ancora appoggiarsi? La Terra Santa era un dono di Dio che aveva promesse di durare sempre. Il Tempio dove Dio abitava, dove gli Israeliti incontravano il Signore e contemplavano nella fede e nel culto il Suo volto, la Città Santa… Tutto questo costituiva per il Popolo di Israele il segno indispensabile della permanenza dell’Alleanza stessa. Come spiritualmente sopportare il crollo di tutto questo senza concludere che l’Alleanza stessa è crollata e perdere ogni fede in Jahvé (cf. Sal 76)? Si deve confessare che la prova fu veramente terribile e sovrumana. Ma appunto qui entra questa umile pazienza, questa hypomoné piena di una speranza, che non capisce niente, ma nondimeno rimane inflessibile in mezzo alla sofferenza e all’umiliazione.
“Tutto ciò ci venne addosso, né ti avevamo dimenticato,/ né avevamo mentito alla tua alleanza./ Non si era voltato indietro il nostro cuore,/ né si erano sviati i nostri passi dal Tuo sentiero./ Eppure ci hai fiaccato in un luogo di sciacalli,/ hai calato su di noi l’ombra della morte./ Se avessimo scordato il nome del nostro Dio,/ se avessimo steso le palme a un Dio straniero (...)/ Ebbene, per Te, siamo trafitti senza posa;/ siamo stimati come gregge da macello./ Svegliati, perché dormi, o Signore?/ Risvegliati e non respingerci per sempre./ Perché nascondi il Tuo volto,/ dimentichi le nostre miserie e le nostre oppressioni?/ Perché è china fino alla polvere la nostra anima,/ striscia per terra il nostro ventre./ Sorgi e soccorrici/ e salvaci per la Tua bontà” (Sal 43, 18-21.23-27).
Tutto può crollare, ma la fedeltà del Signore non può crollare. Tutto può perire, le esigenze della vita possono strapparci tutto, ma l’Alleanza mai! Questo è il fondamento saldo che ci rimarrà sempre indipendentemente da tutte le sofferenze, le umiliazioni e le rinunzie che dovremo subire in questo mondo. Questa pazienza cristiana, pazienza dei Santi, costituisce uno dei temi principali del Libro di Apocalisse di Giovanni: “Hic patientia sanctorum est, qui custodiunt mandata Dei et fideum Jesu” (Qui è la perseveranza dei Santi, i quali osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù) (Ap 14, 12). Secondo la Sacra Scrittura la fedeltà all’Alleanza con Dio è una cosa difficile in questo mondo. Un vero fedele è un vincitore, perché non si può essere veramente fedeli senza vincere. Ma è Dio che dà la vittoria a una fiducia che non si lascia abbattere.
Questa dottrina sull’hypomoné ha il suo posto d’onore nella Regola di San Benedetto. L’atteggiamento che lui descrive nel quarto grado di umiltà è propriamente quello della biblica hypomoné: “Il quarto grado di umiltà consiste in questo, che nella stessa obbedienza in cose difficili e ripugnanti, e perfino in qualsiasi ingiuria ricevuta, abbracci la pazienza con coscienza tranquilla e nel sopportare non si stanchi né venga meno, dicendo la Scrittura: Chi avrà perseverato fino alla fine, questi sarà salvo. Ed anche: Stia forte il tuo cuore e attendi il Signore. E per mostrare che il servo fedele deve per il Signore tollerare ogni cosa, dice nella persona di quelli che soffrono: Per amor tuo siamo tutto il giorno tormentati a morte, siamo ritenuti come pecore da macello” (cap. VII). E ecco anche la fiducia inseparabile della hypomoné: “E fiduciosi nella speranza della retribuzione divina, con gioia proseguono a dire: Ma in tutta questa cosa noi siamo vincitori per Colui che ci ha amati” (ivi). S. Benedetto prosegue insegnando che tutto questo si può sopportare se lo spirito prende, conformemente alla dottrina del Vangelo, un atteggiamento massimalistico: “Ma adempiono pure il precetto del Signore, con la pazienza nelle avversità e nelle ingiurie, coloro che, percossi in una guancia, porgono anche l’altra; a chi toglie loro la veste, lasciano anche il mantello; forzati di andare per un miglio vanno per due; con San Paolo Apostolo sopportano i falsi fratelli e benedicono quelli che li maledicono” (ivi). Il principio è chiaro: il fedele deve, per il Signore, poter sopportare tutto. Questa esigenza così radiale, così estrema, non fu escogitata dal Santo Padre nostro Benedetto, ma viene direttamente dalla Sacra Scrittura. C’è qualche cosa di profondamente cristiano e di cristiforme nel sopportare.
La pazienza di Dio si è rivelata nella pazienza del Figlio Suo, il quale prendendo la nostra natura umana acquistò la capacità di soffrire fino alla morte stessa che non Gli fu risparmiata. Così Egli rivelò in se stesso non solamente la makrothymía del Padre, ma fu anche l’esempio perfetto della hypomoné tra le sue sofferenze. Egli ha riscattato il mondo sopportando tutta la malvagità e la brutalità del mondo. Da questo momento sopportare è divenuto il programma dell’uomo su questa terra. È certo che ciascuno di noi ha molto da sopportare e che la pazienza è una virtù molto pratica in questo mondo. Non è una virtù dei giovani, perché generalmente i giovani non sanno aspettare e vogliono avere subito ciò che desiderano avere. Perciò non diciamo che la pazienza è una virtù caratteristica dei vecchi. Anzi ci sono non pochi vecchi impazienti, che non sono capaci di sopportare con umiltà e mansuetudine anche delle piccole contrarietà che disturbano le loro abitudini. Ma è certo che la pazienza, con la perseveranza la quale ne costituisce una forma, è una virtù cristiana fondamentale. S. Giacomo ne fa un brillante elogio nella sua lettera: “Perfetta gioia riputate, fratelli miei, l’imbattervi in prove d’ogni genere, ben sapendo che ciò che mette alla prova la vostra fede produce pazienza, e la pazienza perseverante conduce l’opera alla perfezione, affinché siate perfetti e completi, di nulla mancanti” (Gc 2, 2-4).
San Tommaso insegna che la pazienza costituisce l’atto principale della virtù di forza, siccome abbiamo bisogno di più forza per sopportare il male che ci aggredisce, specialmente se la situazione è durevole, che non di essere noi stessi la parte attaccante (principalior actus fortitudinis est sustinere quam aggredi). Per la pratica della virtù di pazienza amavo attirare l’attenzione dei giovani monaci sull’insegnamento molto pratico di San Benedetto nella Sua Regola. Penso al sesto grado dell’umiltà, che ci propone l’esercizio di un atteggiamento ascetico molto pratico. S. Benedetto dice: “Il sesto gradino dell’umiltà è che il monaco sia contento di ogni cosa vile e spregevole, e per tutte le cose che gli sono comandate si giudichi un inetto e indegno operaio, ripetendo a se stesso col Profeta: Mi sono ridotto al niente e non ho capito nulla; sono diventato come un bruto dinanzi a Te, ma sono rimasto sempre con Te” (cap. VII). Questa gioiosa contentezza di tutto ciò che ci accade di penoso è una via alla santa hypomoné di Cristo.
13. La prova [12]
Nell’ultima nostra conferenza che ebbe luogo a San Lorenzo, ispirandoci a questo santo martire e al martirio abbiamo meditato sul mistero della prova alla quale deve sottomettersi ogni uomo in questo mondo. Meditando su questo importantissimo problema della vita cristiana abbiamo interrogato la Sapienza del Siracide che ne parla nel capitolo secondo. Però con la nostra meditazione non abbiamo esaurito la grande ricchezza di questo capitolo 2. Oggi, dunque, continueremo la nostra meditazione su questo ammirevole capitolo 2. Ecco ciò che dice: Figlio, se ti accosti al servizio del Signore,/ disponi la tua anima alla prova./ Abbi un cuore retto, sii costante/ e non turbarti sotto la prova./ Tieniti unito a Lui intimamente e non separartene,/ perché tu ne resti avvantaggiato in seguito (Sir 2, 1-3).
Questi versetti li abbiamo già meditati. Poi segue: Ricevi quanto ti invierà/ e sii longanime nelle vicissitudini/ delle tue afflizioni (Sir 2, 4). È certamente cosa importantissima ricevere tutto ciò che Dio ci invia, secondo le meravigliose parole di Giobbe: “Se abbiamo ricevuto dal Signore il bene perché non riceveremo da Lui anche il male?” (Gb 2, 10). Ma per essere capace di far questo l’uomo deve avere la fede che tutto ciò che a lui accade viene realmente da Dio come un dono del suo infinito Amore. Senza una tale semplicità della fede non è possibile sopportare le grandi prove. La certezza soprannaturale che tutto ci viene dal Padre che ci ama, ci dà la pace, e allora diviene possibile ciò che dice il Siracide : “Sii longanime nelle vicissitudini delle tue afflizioni.”
Sì, adesso si può essere longanimi, si può tranquillamente aspettare, perché si sa che tutto ha un senso, che tutto è pieno di amore e di bontà divina: “Ricevi quanto ci invierà/ sii longanime”. Come è bello questo atteggiamento che sa sempre trovare Dio nelle circostanze sempre variabili della vita umana! Gli asceti insistono che non dobbiamo fermarci alle considerazioni delle cause seconde, ma dobbiamo sempre salire alla Causa prima, siccome è sempre direttamente presente poiché l’oro viene provato con il fuoco/ e gli uomini graditi nella fornace dell’umiliazione (Sir 2, 5). L’oro significa un tesoro, un grande valore. Ma l’oro deve essere purificato nel fuoco. Il fuoco è una potenza che distrugge molte sostanze, ma altre invece purifica. Le grandi sofferenze sempre fanno morire, ma da te, dalla tua cooperazione con la grazia dipende se morirai tu stesso o morirà il tuo vecchio uomo per far vivere il nuovo. Durante la guerra si vedeva questo doppio effetto di una grande sofferenza: tra quelli che sono stati imprigionati nei campi di concentramento molti sono usciti migliori, più forti, più umani, più uniti al Cristo. Altri invece sono stati spiritualmente rovinati e spezzati.
Le grandi prove – dice la Sapienza – sono preparate per gli amici di Dio, per uomini che Gli sono graditi. Per loro è preparata “la fornace dell’umiliazione”. Perché la divina Sapienza parla qui di “fornace dell’umiliazione”? Noi forse preferiremmo parlare di una fornace della sofferenza. È un’idea più generale, siccome non ogni sofferenza è umiliazione... Sì, ci può sembrare così, ma il pensiero espresso qui dal Siracide è più profondo e più preciso. Non è la sofferenza come tale che purifica e trasforma l’anima dell’uomo, ma l’umiliazione. L’intenzione di Dio quando ci manda la sofferenza non è di farci soffrire, ma ben di farci raggiungere una profonda umiltà del cuore che è la vera sapienza, è la vera purezza dell’anima. Quindi, in ogni sofferenza c’è l’umiliazione che costituisce l’elemento prezioso, la direzione della grazia che l’uomo deve saper trovare per collaborare a suo modo con la misteriosa pedagogia di Dio. Se non trova la dolcezza dell’umiltà, la sofferenza lo spezzerà.
Affidati a Lui e ti prenderà in tutela,/ segui la retta via e spera in Lui (Sir 2, 6). L’umiliazione dell’uomo è certamente l’intenzione del Padre Celeste quando ci manda il dono della sofferenza, ma non soltanto l’umiliazione. Dio vuole attrarre il cuore dell’uomo a sé. Non vuole Dio lasciare che l’uomo sia solo nella sua sofferenza, ma vuole che lui cerchi il Signore, che si avvicini a Lui, che scopra finalmente il mistero di una fiducia totale. Perché la sofferenza dell’uomo lì rivela la propria debolezza fin al punto di non poter più. Allora l’uomo capisce di essere stato creato per la fiducia, per affidarsi totalmente a Dio. Allora la sua estrema debolezza, la quale per sé dovrebbe portare alla disperazione, non fa più paura, ma piuttosto è sorgente di gioia, secondo le parole di San Paolo: “Libenter gloriabor in infirmitatibus meis, ut inhabitet in me virtus Christi: cum enim infirmor, tunc potens sum” (2 Cor 12, 10).
Affidati a Lui e ti prenderà in tutela,/ segui la retta via e spera in Lui. L’uomo deve semplicemente essere fedele adempiendo i suoi doveri ogni giorno e sperando in Dio. È vero però che la speranza in Dio è una virtù difficile. L’Uomo ama sentire un suolo fermo sotto i suoi piedi. Noi cristiani, che abbiamo la speranza in Dio, praticamente ci appoggiamo su tante cose create che concorrono al nostro benessere spirituale. Abbiamo una salute abbastanza buona, una certa sicurezza economica, molti amici che ci vogliono bene, condizioni di vita sufficienti, nessuno ci perseguita, nessuno ci vuole apertamente male, anche il diavolo ci lascia senza grandi tentazioni. Non è facile per noi immaginarci, vivendo tra tanti appoggi psicologici, che cosa sia appoggiarsi su Dio solo. Forse Dio ci darà una volta l’occasione di praticare questa speranza pura secondo le parole del misterioso “servitore di Jahvé” della Profezia di Isaia: “Chi tra di voi teme Jahvé/ ascolti la voce del suo servitore!/ Chi cammina nelle tenebre,/ senza alcuna luce in sé,/ speri nel nome di Jahvé,/ si appoggi sul suo Dio” (Is 50, 10). “Appoggiarsi sul suo Dio” è dunque un atteggiamento che si verifica in una infinità di gradi. Pochi lo realizzano perfettamente. Dobbiamo spesso esaminare la verità della nostra speranza in Dio.
Nei versetti seguenti il Siracide si rivolge tre volte a quelli che temono Dio: Voi che temete il Signore, aspettate la sua misericordia,/ non venite meno, se non volete cadere./ Voi che temete il Signore, abbiate fiducia in Lui,/ e la vostra ricompensa non verrà meno./ Voi che temete il Signore, sperate cose migliori:/ l’interminabile gioia e la misericordia (Sir 2, 7-9). L’insegnamento sulla prova e sulla maniera di comportarsi nella prova si cambia in un cantico alla fiducia in Dio e alla sua infinita misericordia.
Osservate le generazioni passate e fate attenzione:/ chi si è affidato al Signore e ne è rimasto deluso?/ Chi ha perseverato nel timore di Lui ed è stato abbandonato?/ Chi lo ha invocato ed è stato da Lui ignorato? / Perché il Signore è pietoso e misericordioso; / rimette i peccati e salva in tempo di sventura! (Sir 2, 10). Il timore di Dio che è un amore umile trova la sua piena espressione in una fiducia piena e senza limiti a Dio: Voi che temete il Signore, aspettate la sua misericordia/ Voi che temete il Signore, abbiate fiducia in Lui/ Voi che temete il Signore, sperate cose migliori:/ l’interminabile gioia e la misericordia (Sir 2, 7-9). Il Siracide ci insegna che questa fiducia in Dio deve essere coraggiosa: Guai ai cuori codardi e alla mani inerti! Guai al cuore abbattuto perché non crede: perciò sarà privo di protezione! Guai a voi che avete perduto la pazienza; che farete quando il Signore vi visiterà? Chi teme il Signore non diffida delle sue parole; chi lo ama, ne segue il cammino. Chi teme il Signore, si sforza di piacergli e chi lo ama si sazia della legge. Chi teme il Signore, dispone il cuore e umilia la sua anima innanzi a Lui. Gettiamoci nelle braccia del Signore e non nelle braccia degli uomini, poiché come è la sua grandezza così anche è la sua misericordia (Sir 2, 12-18). Ecco l’ultima raccomandazione indirizzata al servo di Dio duramente provato: “Gettiamoci nelle braccia del Signore, poiché come è la sua grandezza così anche è la sua misericordia”.
Il popolo di Dio nel Vecchio Testamento fu veramente duramente provato nella sua fede e la sua speranza in Jahvé. Dopo le grandi prove nel deserto dove tutto dipendeva dalla fede, sono venute le prove ancora molto più difficili in Palestina. Possiamo difficilmente immedesimarci nella situazione dei credenti Israeliti quando la Città Santa Gerusalemme fu distrutta, il tempio bruciato, il popolo stesso cacciato via dalla Terra Santa e disperso tra i pagani. Tutti i segni esterni dell’Alleanza tra Dio e il popolo sono spariti. Non c’era più nessuna liturgia, nessun contatto sentito con Jahvé. Molti potevano interpretare ciò che era accaduto come una rottura dell’Alleanza, come un abbandono da Dio. Una prova certamente terribile! Quelli che non sono stati spezzati hanno avuto una fede fortissima. Tutti i disastri della storia sono passati sopra di loro, ma loro sono rimasti incrollabili: “Omnia excelsa Tua et fluctus Tui super me transierunt” (Sal 41, 8b). Questi hanno sempre sperato nel Dio fedele. Non hanno mai ammesso che Lui potesse essere infedele alla Sua parola, e così hanno superato la terribile prova della loro vita.
II. Liturgica
1. Nativitas B.V.M. [13]
La nascita di un uomo è una festa per i suoi cognati. Anche obiettivamente è un evento grande, perché l’inizio di ogni uomo suppone un intervento diretto del Creatore, è quindi un avvenimento d’una profonda significazione religiosa. Ma la nascita umana non è santa siccome è macchiata dal peccato. Quello che nasce, che comincia a vivere in questo mondo, è un peccatore allontanato da Dio a causa del peccato originale. È vero, questa vita deve appartenere al Cristo, deve essere rapita da Lui e trasformata in Lui, deve diventare una corsa verso il Padre, sì, ma “hic et nunc” è rivolta dal Signore. Quindi, per un cristiano non la concezione né la nascita, ma il battesimo costituisce la vera festa dell’inizio.
Per San Giovanni Battista la Chiesa celebra la sua nascita credendo alla sua miracolosa purificazione e santificazione nel seno materno, ma non celebra la sua concezione, la quale non differiva da quella degli altri esseri umani. Invece per Maria la Chiesa celebra non soltanto la sua Natività, ma anche la sua Concezione Immacolata, e perfino questa solennità è più importante della festa odierna, giacché significa la totale esenzione di Maria dalla legge comune a tutti i rappresentanti dell’umanità caduta. La Concezione Immacolata è la festa della vittoria totale di Maria sul peccato dell’uomo e su quello che in virtù del peccato esercita un potere tirannico sull’uomo caduto. La festa della Natività appartiene allo stesso mistero dell’inizio della Santissima Madre di Dio e il suo oggetto è l’apparizione in questo mondo dell’Immacolata vincitrice del peccato. La venuta di Maria in questo povero mondo significa l’aurora del gran Mistero di Salvezza. Questa è la ragione della grande gioia di questa festività. Perciò la Chiesa canta oggi alla Madonna: “Nativitas tua, Dei Genitrix Virgo, gaudium annuntiavit universo mundo: ex Te enim ortus est Sol iustitiae, Christus Deus noster: qui solvens maledictionem, dedit benedictionem; et confundens mortem, donavit nolis vitam sempiternam.” (La Tua nascita Vergine Madre di Dio,/ ha annunziato la gioia / al mondo intero: / da Te è nato il Sole di giustizia, / Egli ha tolto la condanna / e ha portato la grazia, / ha vinto la morte /e ci ha dato la vita eterna).
La Santissima Vergine Maria è quella beatissima creatura umana che non ha mai resistito alla grazia di Dio. Non c’è stata nessuna, anche la più tenue e delicata, mozione dello Spirito Santo alla quale Lei non avesse obbedito subito e pienamente. E così lo Spirito Santo, non trovando in Lei nessuna resistenza alla sua azione, ma sempre una perfetta apertura e una docilità senza fallimento, ha potuto trasfomarLa in se stesso. Nel mondo immerso nelle tenebre del peccato Maria fu l’unica altissima cima irradiata dal Sole che cominciava già a sorgere sull’umanità. Lei fu il punto di contatto tra l’immensità di Dio e la piccolezza dell’uomo. Come la colomba di Noè, non potendo trovare su tutta la terra un luogo secco per riposarsi, venne all’Arca di Noè, così lo Spirito di Dio, trovando tutto il mondo immerso nel peccato, venne a Maria: “Spiritus Sanctus superveniet in Te”. Maria fu quindi il punto di incontro dell’uomo con Dio. Noi abbiamo potuto andare incontro a Dio veniente soltanto in Lei. Ma è una causa di fierezza per tutto il genere umano aver potuto andare incontro a Dio in un modo così magnifico.
Se Dio ha voluto incontrarsi con l’umanità in Maria, si può dire che Lei è diventata in un certo senso la forma di questo incontro. Non si deve capire questo nel senso che ogni cristiano non può incontrare Dio nella preghiera direttamente senza prima rivolgersi esplicitamente a Maria, ma che per incontrare Dio si deve in una certa maniera diventare Maria. Più l’anima cristiana rassomiglia a Maria, diventa Maria, tanto più incontra Dio e diviene un vivente incontro con Dio, cioè un tempio vivente del Signore. Se Maria è l’incontro di tutta l’umanità con Dio, ne segue che tutto ciò che riguarda l’unione degli uomini con Dio appartiene in una certa maniera a Lei. L’unione con Dio è la cosa sua. Dove si tratta dell’unione dell’uomo con Dio, Maria è sempre presente. Donde questa meravigliosa appellazione di “Madre della divina grazia”. Come quella che non ha opposto nessuna resistenza all’ispirazione e all’azione dello Spirito Santo, Lei è divenuta quasi la concretizzazione di questa azione, la forma concreta della grazia, modello per tutti e per la Chiesa stessa. In Maria vediamo quali dobbiamo essere e come dobbiamo vivere per ricevere Dio e vivere in unione con Lui.
Ci sono molti Santi nella Chiesa, in essi vediamo l’enorme ricchezza spirituale della Chiesa. Ma tra i Santi possiamo fare una scelta. Non tutti sono a un grado uguale adatti alla nostra spiritualità personale. Alcuno vuole imitare San Francesco da Assisi, per un altro Santa Teresa del Bambino Gesù sarà più adatta all’imitazione. Maria invece è per tutti, Maria è universale, una luce spirituale per tutti, una medicina per tutti, una gioia spirituale per tutti. Nessuno può sottrarsi al suo fascino spirituale, al suo profondo e delicato incanto, al suo odore ineffabile.
La vera storia dell’uomo non consiste nella successione degli eventi che formano la trama esteriore della sua vita. La vera storia dell’uomo è la sua storia spirituale, la storia della sua vita con Dio o lontano da Dio, la storia delle sue fedeltà e delle sue infedeltà, dei suoi congedi dal Signore e dei suoi ritorni a Lui con umiltà e lacrime di contrizione. Questa è la vera storia di ogni cristiano, in sostanza è la Storia dell’Alleanza. Come vediamo nella Sacra Scrittura, la vera storia del Popolo di Dio Israele non tratta degli affari politici, non si ferma alla successione degli eventi esterni, ma si concentra sull’Alleanza e sul problema della fedeltà a questa Alleanza. Ci mostra Dio sempre fedele e ci mostra Israele che talvolta rompe il suo contatto col Signore, abbandona Dio per cercarlo di nuovo e ritrovare la sua infinita e instancabile misericordia. Questa storia di Israele si riproduce in ciascuno di noi. Per ciascuno di noi la cosa essenziale è l’Alleanza; dico la cosa essenziale, perché l’Alleanza con Dio costituisce il senso stesso della nostra vita.
Ma si può dire senza inesattezza che esiste anche una storia Mariana della nostra vita, cioè la storia di questo misterioso incontro personale del cristiano con la Madre di Cristo e Madre sua. Di questa grazia importante e piena di soavità è bene essere consapevoli. Alla devozione verso Maria che tutti abbiamo si deve lasciare una grande libertà nei limiti della fede cattolica. Questa relazione filiale del cristiano con la sua Madre Celeste può avere diverse espressioni e diverse forme. Tutte sono buone e salutari se concordano con la fede e la dottrina della Chiesa. Si propongono diverse forme, ma si deve conservare una grande delicatezza per non voler inquadrare in un sistema ciò che è semplicemente vita di amore e di fiducia filiale.
2. La venuta del Signore [14]
L’Avvento sta finendo e ci avviciniamo alla grande solennità della Nascita del Signore, del Figlio Unigenito di Dio che si è degnato di nascere come Figlio dell’uomo dalla purissima Vergine Maria. Mai potremo capire la profondità di questo mistero del divino Amore. Per poco che vogliamo approfondirlo il nostro spirito si sente oppresso da una luce troppo grande per lui.
Il Prologo del Vangelo di San Giovanni ci rivela l’eterna nascita del Verbo prima di parlarci della sua Incarnazione. All’inizio della Bibbia, il primo versetto del libro Genesi segna l’inizio del tempo, quando tutte le cose cominciarono ad esistere. L’Evangelista San Giovanni va oltre l’affermazione di Genesi. Quando le cose cominciarono ad esistere, il Verbo di cui lui ci parla già era in possesso di un’esistenza senza principio e senza limiti. È il Verbo di Dio, perché Dio in Lui si esprime, in Lui esprime tutto se stesso, tutto ciò che Lui è, tutta la sua infinita Essenza.
Dio è semplice, Lui non si esprime parzialmente, ma si dice tutto in una Parola che procede da Lui eternamente e costituisce la Persona del Figlio. Noi, quando parliamo, esprimiamo qualche cosa del nostro pensiero. Ma anche usando molte parole non possiamo esprimere tutto ciò che pensiamo e tanto meno siamo capaci di esprimere tutto il nostro essere nelle nostre parole. Il Verbo di Dio è dunque il Figlio Unigenito di Dio uguale al Padre.
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio (Gv 1, 1-2). Nel testo greco abbiamo (pròs tòn theòn) che possiamo tradurre come nel testo generalmente annesso e come abbiamo citato: “e il Verbo era presso Dio”; ma possiamo anche capirlo altrimenti. Pròs tòn theòn può essere tradotto anche: “Verso Dio”; “il Verbo era verso Dio”. Il Figlio sta davanti al Padre, rivolto a Lui. Questo suo eterno atteggiamento si esprime anche nella sua Umanità assunta. Tutta la sua vita umana è verso il Padre: il suo cuore, i suoi pensieri, la sua volontà, la sua attività, tutto era sempre verso il Padre. Questa idea si trova nella Lettera agli Ebrei, dove la vita del Cristo è rappresentata come una entrata del sommo sacerdote nel santuario celeste con l’offerta del proprio sangue verso il Padre. L’orientamento essenziale della vita cristiana è anche pròs tòn theòn. Resi figli di Dio per adozione, andiamo o corriamo insieme con Cristo verso il Padre. Questa idea del Figlio di Dio Sommo Sacerdote pròs tòn theòn, verso Dio Padre, era espressa meglio nell’antica forma degli altari liturgici che non erano verso il popolo.
Tutte le cose per mezzo di Lui furono fatte, e senza di Lui nulla fu fatto di ciò che fu fatto (Gv 1, 3). Fonte prima e universale dell’essere il Padre, dandosi totalmente al Figlio, gli comunica anche la sua potenza creatrice creando tutto per mezzo di Lui. Così San Giovanni sottolinea che quello che si è fatto piccolo e debolissimo pargoletto è l’Onnipotente Creatore dell’Universo visibile e invisibile. L’Universo è suo e porta la traccia di Lui.
In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini (Gv 1, 4). Qui parla di quella vita che da principio era in Lui, quella vita che si identifica con Lui: “sicut enim Pater habet vitam in semetipso, ita dedit et Filio habere vitam in semetipso” (Come, infatti, il Padre ha in se stesso la vita, così ha dato al Figlio d’aver la vita in se stesso) (Gv 5, 26). Dice dunque San Giovanni che quella vita che in Lui era, era la luce degli uomini, ciò significa che da principio l’uomo era creato in vista di partecipare a quella vita divina. Meravigliosa rivelazione sull’uomo, sul senso profondo dell’umanità nel pensiero del Creatore. L’uomo fu destinato a partecipare alla vita stessa di Dio, la quale doveva farsi la sua luce, cioè la norma della sua vita e la sua condotta.
Questo stupefacente pensiero si trova confermato nel versetto nono dello stesso Prologo che dice: La Luce vera che illumina ogni uomo stava per venire nel mondo (Gv 1, 9). L’uomo è un essere così divino nel pensiero del suo Creatore, che la sua vita deve ricevere la sua norma dalla vita interna di Dio stesso. Vita Dei erat lux hominum (Gv 1, 4).
e la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno sopraffatta (Gv 1, 5) In questo versetto scendiamo dal cielo sulla terra. La luce di Dio entra in contatto con le tenebre. Questa brevissima frase: “e la luce splende nelle tenebre”, costituisce una potente sintesi di tutta la storia umana. La lotta tra la Luce e le tenebre riempie la storia e la rende così intricata e difficile da capire. Ci sono tante cose terribilmente tenebrose in questo mondo, ma insieme ci sono tanti ambienti lucidi, tante sorgenti di luce vera, di luce eterna. In noi stessi si svolge questa guerra tra la luce e le tenebre. Il Vangelo di San Giovanni ha per tema principale questo drammatico scontro: la Luce di Dio riscontra la resistenza delle Potenze tenebrose, resistenza che si fa di più in più incoercibile. Ma finalmente quando le tenebre sembravano già trionfare è venuta la piena vittoria della Luce – la Risurrezione del Cristo. “e la Luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’ hanno sopraffatta”. Il testo greco accetta una doppia interpretazione: le tenebre non hanno vinto o le tenebre non l’ hanno capito. Ambedue questi sensi si possono giustificare per il testo del Vangelo.
Vi fu un uomo mandato da Dio, e il suo nome era Giovanni. Questi venne come testimone per dar testimonianza alla Luce, affinché tutti credessero per mezzo di Lui (Gv 1, 6-7). Viene la Luce divina in questo mondo e comincia la testimonianza umana. Come è possibile che un uomo dia testimonianza alla Luce divina? Pare veramente impossibile che un uomo abbia un tale incarico. Infatti non c’è nessuna proporzione tra un uomo e la Luce divina. Naturalmente è impossibile per l’uomo diventare un testimone di Dio. Ma l’Evangelista dice: “fu un uomo mandato da Dio... Questi venne come testimone per dar testimonianza alla Luce”. Se non fosse “mandato da Dio” sarebbe totalmente incapace di eseguire un tale incarico. Giovanni Battista fu il primo testimone del Dio Incarnato dinanzi al mondo. Fu il primo, ma non l’ultimo. Da lui comincia la testimonianza che non dovrà più tacere fino alla fine del mondo.
La testimonianza (martyría), idea importantissima nel cristianesimo che nella Chiesa dei primi secoli era molto viva. Poi, nei secoli posteriori non se ne parlava molto. Oggi assistiamo a una vera rinascita di questa idea. Il mondo, ricaduto nel paganesimo e minacciato di sprofondarsi nell’ateismo, ha un urgente bisogno di testimoni. Si ricorda che il Signore prima di lasciare i suoi discepoli disse loro: “eritis mihi testes” (Sarete miei testimoni) (At 1, 8). Non ha detto: “sarete per me teologi, o predicatori…”, ma sarete miei testimoni. I giovani oggi vogliono questo, essi cercano i testimoni di Cristo. Chi può essere testimone di Cristo? Una condizione essenziale per essere testimone di alcuno è di conoscerlo personalmente. Soltanto chi conosce personalmente può essere testimone. Chi conosce Cristo soltanto per mezzo dei libri o per mezzo delle testimonianze altrui non può essere testimone di Cristo. San Paolo doveva incontrare personalmente il Signore per poter essere il suo Testimone e il suo Apostolo. La rinascita odierna di questa importante esigenza cristiana costituisce certamente uno dei segni di un vero rinascimento nel seno della Chiesa. Anche oggi lo sviluppo della Chiesa esige molti testimoni, cioè molti cristiani che conoscono il Signore personalmente. Questo non è una cosa straordinaria, perché ogni cristiano vivente veramente e profondamente la sua fede conosce il Cristo personalmente e può essere suo testimone.
Non era egli la luce ma doveva dare testimonianza alla luce (Gv 1, 8). Giovanni Battista è un modello di testimone. Lui era pieno di Cristo e vuoto di se stesso. Lui guardava soltanto il Cristo, gridava il Cristo, e quando i Giudei vennero e gli domandavano: “Chi se tu”, lui fu meravigliato di questa domanda. Si meravigliava come avessero potuto interessarsi a lui, e nel primo momento non poteva trovare una risposta. E poi ha risposto citando il Profeta Isaia: “io sono la voce di uno che grida nel deserto” (Gv 1, 22-23). Dunque sono niente, perché la voce da sé è niente, la voce è tutta per il Verbo che annunzia gridando. La cosa più pericolosa per un testimone di Cristo è pensare di essere qualche cosa. Il primo testimone è puro di questa passione. Ma non tutti i suoi discepoli furono come lui. Quando vedevano che molti seguivano Gesù e non venivano più al loro maestro, si sono lagnati con Giovanni provocandolo a rendere quella bellissima testimonianza a se stesso, testimonianza di una perfetta trasparenza spirituale: “Giovanni rispose: Nessuno può prendere nulla se non gli è stato dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: non sono io il Messia, ma sono stato mandato innanzi a Lui. Chi ha la sposa è sposo, ma l’amico dello sposo, che l’assiste e l’ascolta, è felice alla voce dello sposo. Questa dunque è la mia gioia, ed è giunta al colmo. Lui deve crescere, io diminuire” (Gv 3, 27-29). Gli Apostoli di Cristo non avevano ancora questa trasparenza, né questa gioia della trasparenza quando domandavano al Signore: “Chi sarà più grande nel Regno dei Cieli?” Essi certamente pensavano ancora di essere qualche cosa. Guardando la Luce, contemplando la Luce e perdendo se stessi si diviene testimoni di Cristo secondo il modello di San Giovanni Battista.
La Luce divina che illumina ogni uomo stava per venire al mondo. Egli era nel mondo, e il mondo per mezzo di Lui fu fatto, e il mondo non lo riconobbe. È venuto nella sua casa e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno ricevuto, ha dato il potere di diventare figli di Dio; a quelli che credono nel Suo Nome, i quali non da sangue, né dal volere della carne, né da volere d’uomo, ma da Dio sono nati. E il Verbo s’è fatto carne ed ha dimorato tra noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria che come Unigenito ha dal Padre, piena di grazia e di verità (Gv 1, 9-14).
3. Natale [15]
All’inizio della Bibbia il primo versetto del libro Genesi segna l’inizio del tempo, quando tutte le cose cominciarono ad esistere; l’Evangelista San Giovanni va oltre l’affermazione di Genesi. Quando le cose cominciarono ad esistere il Verbo di cui lui ci parla già era in possesso di un’esistenza senza principio e senza limiti. In principio era il Verbo,/ e il Verbo era presso Dio,/ e il Verbo era Dio./ Egli era in principio presso Dio.
Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla Luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la Luce ma doveva rendere testimonianza alla Luce (Gv 1, 1.6-8.19.28). Tre domande al Battista: “Chi sei tu?”; “Che cosa dici di te stesso!”; “Perché battezzi?”. Tre domande che hanno risonanza anche in noi. Risposta del Battista alla seconda domanda: “Io sono la voce, parola che invita alla conversione”. “In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete”. Alla terza domanda il Battista risponde che battezza nelle acque del fiume Giordano per invitare le anime convertite a conoscere “uno che viene”, cioè il Messia, di cui si proclama servo indegnissimo (cf. Gv 1, 19-23). E tu, sei testimone di Gesù Luce del mondo?
In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città (Lc 2, 1-3). Un fatto politico dà il via al più grande avvenimento della storia: la nascita del Figlio di Dio a Betlemme. Il popolo Ebreo aveva pregato per secoli: “Oh, se tu squarciassi i cieli e scendessi!” (Is 63, 19). Vieni Signore a liberarci! Nella pienezza dei tempi Dio risponde in modo inaudito a questa lunga attesa: “Sì, Dio ha tanto amato il mondo da donargli il suo Figlio Unigenito” (Gv 3, 16).
Anche Giuseppe che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta (Lc 2, 4-5). Betlemme da “Beth-Lehem” significa “Casa del Pane”. L’Incarnazione è legata all’Eucarestia. Gesù dirà: “Io sono il Pane vivo disceso dal cielo” (Gv 6, 51). Il segno dell’Incarnazione è la povertà totale, lo spazio vuoto per Dio. Il segno dell’Eucarestia è la piccola Ostia, l’umiltà totale.
Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compivano per Lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo Figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro all’albergo (Lc 2, 6-7). Nella nascita di Gesù la Madonna compare in primo piano come Vergine Madre e tuttavia è avvolta di silenzio. Tutte le cose grandi si compiono nel silenzio e nel nascondimento. La Vergine dell’Incarnazione è adoratrice perfetta del Verbo divino, tutta raccolta in Dio nell’interno del suo cuore Immacolato, così bella nella grazia di quella Maternità divina, così soffusa di luce, perché tutta inondata dall’Amore delle Tre Persone divine. La Vergine dà alla luce Gesù, “primogenito” di molti fratelli e sorelle che siamo noi.
C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un Angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento (Lc 2, 8-9). I pastori (in ebraico “am ha ares” = “popolo della terra”) sono gli umili, i disprezzati. E proprio a loro viene dato il primo annuncio di gioia. Echeggia già il piccolo inno di giubilo di Gesù: “Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti (= gli autosufficienti, i superbi) e le hai rivelate ai piccoli!” (Lc 11, 2-5), agli umili. Chi è umile attira in sé Dio e comincia già a vivere il Cielo.
ma l’Angelo disse loro: “Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore” (Lc 2, 10-11). Anche gli Angeli della Risurrezione diranno: “Non temete”. Il termine, il vertice della vita di Gesù è la Risurrezione. Sarà così anche per noi. Ma già adesso inizia la cosiddetta “Risurrezione anticipata”, che coinvolge anche il nostro corpo, ogni volta che noi risorgiamo dal peccato alla Grazia. Il perdono di Dio nella confessione ci rende allora capaci di accogliere il dono divino della gioia. Se Gesù è presente nelle profondità del nostro cuore, sgorga in noi quel grido di gioia che ci permette di attraversare i deserti e i tempi di siccità di questa breve esistenza.
4. La passione del Signore [16]
Sta scritto nel Vangelo di San Luca: Avvenne poi che, compiendosi per Lui il tempo di essere tolto dal mondo, egli fece il viso duro e si diresse verso Gerusalemme (9, 51). Quando si legge il Vangelo, fa certamente impressione una cosa: questo orientamento di tutta la vita di Cristo verso la sua Passione. Come uomo doveva temerla. Per la natura umana la previsione certa delle sofferenze che lo aspettavano era difficile da sopportare. E perciò il testo del Vangelo dice: “Egli fece il viso duro e si diresse verso Gerusalemme”. Là si preparava già l’altare per l’Agnello. “Il mio cibo è di far la volontà di Colui che mi ha inviato, di compiere l’opera di Lui”(Gv 4, 34). Tutta la volontà di Gesù era tesa verso questo momento che Lui chiamava la Sua Ora. La terribile sofferenza, il dolore, la crudelissima morte, l’umiliazione…, tutto questo era quasi niente dinanzi alla volontà del Padre e il compimento del Suo ordine.
Con grande sollecitudine Gesù preparava i suoi discepoli alla comprensione e all’accettazione di questa volontà del Padre, tanto contraria a tutte le loro speranze e aspettative. La sua vita e il suo ministero sulla terra dovevano finire con la più umiliante sconfitta, con un vero disastro. Tutto questo ministero del loro amatissimo Maestro, ministero così glorioso, pieno di miracoli e di manifestazioni dell’Onnipotenza di Dio, doveva finire in una umiliazione la più profonda. L’Uomo di tutte le loro speranze, l’Uomo di Dio, il Salvatore di Israele, quell’Essere straordinario nel quale presentivano la natura divina, doveva essere umiliato e calpestato, doveva essere ridotto a nulla e tutta la sua opera doveva essere ridotta a niente quasi in un istante. L’orgoglio e la brutalità di questo mondo doveva essere per un momento vincitrice su Dio stesso che ha potuto calpestare e schiacciare.
Il Cristo con la sua volontà umana accetta questo e va coraggiosamente dinanzi. Ammiriamo la calma fermezza della sua volontà che non esita né torna indietro, ma abbraccia amorosamente la volontà del Padre. In tutta la vita di Gesù Cristo vediamo questa meravigliosa semplicità che consisteva in questo, che c’era un solo semplicissimo motivo che reggeva tutte le sue azioni, e questo motivo era la volontà del Padre. Se alcuno lo interrogava: “Perché fai questo o quello?” il Signore Gesù poteva sempre dare questa semplice risposta : “Perché così vuole il Padre, perché per questo sono stato mandato…” Questa semplice intenzione di totale obbedienza rende conto di tutte le azioni, tutte le opere di Cristo. Questa semplicità di intenzione, mantenuta con una intransigenza e una fedeltà invincibile, Lo farà finalmente vincitore su questo mondo aggrovigliato nella menzogna.
Una delle numerose lezioni che la Passione di Cristo apporta all’uomo è certamente quella della semplicità: la volontà del Padre e nient’altro. Questo attaccamento alla sola volontà di Dio rende l’uomo limpido e forte, capace di vincere il mondo e il diavolo. Ma è vero che la volontà del Padre rimane sempre un mistero terribilmente sconcertante per l’uomo. È naturale per l’uomo considerare la sua vita come uno sviluppo, di desiderare il successo, di temere l’insuccesso e la sconfitta. Ma questa è appunto la saggezza del mondo che Dio ha voluto distruggere per la predicazione della Croce. San Paolo dice: “Dacché infatti, il mondo non seppe con la sua saggezza conoscere Iddio nelle manifestazioni della sapienza divina, Iddio si compiacque di salvare i credenti mediante la stoltezza della predicazione. E, dato che i Giudei reclamano miracoli e i Greci vanno in cerca di sapienza, noi, all’opposto, predichiamo un Cristo crocefisso, oggetto di scandalo per i Giudei e follia per i pagani, ma per quelli che sono chiamati, siano essi Giudei o Greci, un Cristo che è potenza di Dio e sapienza di Dio. Poiché la follia di Dio è più sapiente degli uomini, e la debolezza di Dio è più forte degli uomini” (1 Cor 1, 21-25).
Per noi tutti la salvezza è nella Croce di Cristo. Ma la Croce di Cristo reclama da noi una partecipazione personale. Come dice un poeta polacco: “La Croce piantata sul Golgota non salverà colui che non vorrà piantare la croce nel suo cuore”. Ogni cristiano è segnato dal Mistero della Croce, la grazia che riceviamo mediante il battesimo è una grazia di morte: “in morte illius baptizati sumus” (Rm 6, 3), noi siamo battezzati nella morte di Cristo, siamo immersi nella morte di Cristo. Altrimenti non si diviene cristiani. Apparteniamo dunque a questo mistero. E questa è appunto la ragione per la quale la Croce ha un tal fascino per l’anima cristiana. Sentiamo che la nostra relazione personale alla Croce di Cristo è la vera misura del nostro valore personale come cristiani, la vera misura del nostro cristianesimo. Sento che sarò veramente un cristiano quando sarò capace di guardare il Crocefisso in faccia e potrò dire in ogni verità che amo il Crocefisso e che amo la Croce del mio Signore e la ricerco nella mia vita. Quando potrò dire questo in ogni verità? Quando avrò la grazia di non avere più questa scappatoia, questa codardia davanti alla Croce, ma un atteggiamento francamente cristiano e coraggioso. Se vediamo un fratello cristiano che si sacrifica totalmente, che realizza nella sua vita la Parola del Signore di odiare la propria anima in questo mondo, sentiamo un movimento di gelosia perché sentiamo che questo fratello ha trovato la pienezza e l’autenticità del cristianesimo, sentiamo che lui è veramente libero.
L’Uomo di oggi parla sempre di un cristianesimo “positivo”, mette l’accento sulla risurrezione e non ama pensare alla Passione e alla morte. È vero che il fine è sempre la vita. “Christus resurgens ex mortiis iam non moritur, mors illi ultra non dominabitur (Cristo una volta risuscitato dai morti, più non morrà, non avendo la morte più alcun dominio su di lui). Chi è morto, è morto al peccato una volta per sempre: e chi vive, vive ormai per Iddio. Così voi pure consideratevi morti sì al peccato, ma vivi per Dio in Cristo Gesù” (Rm 6, 9-11). Sì, la vita eterna è già una realtà in noi, perciò dice l’Apostolo: “Se siete risorti con Cristo cercate le cose dell’alto, dove Cristo è assiso alla destra di Dio” (Col 3, 1), ma in questo mondo rimane totalmente il programma del Signore che dice nel Vangelo di S. Giovanni, nel capitolo dodicesimo: “Se il chicco di frumento non cade in terra e vi muore, resta solo; se invece muore, porta molto frutto. Chi ama la sua vita, la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo, la conserva per la vita eterna” (Gv 12, 24-25). Se il chicco di frumento fosse intelligente, temerebbe di cadere nel solco umido e tenebroso. Così anche il cristiano sente un timore davanti al mistero della morte che lo attira e lo affascina in virtù della sua grazia battesimale. Noi dobbiamo pensare che la nostra vocazione monastica è un appello speciale alla Croce di Cristo. La rinuncia che fa penetrare nel mistero della morte costituisce l’elemento caratteristico di questa vocazione. La vita monastica è la prolungazione e lo sviluppo il più naturale della grazia ricevuta nel battesimo. Pensiamo a questo, Fratelli, e preghiamo il Signore che per mezzo della celebrazione liturgica della sua Morte generatrice di vita ci rinnovi in questo spirito.
5. Pasqua (sabato in albis) [17] Carissimi Fratelli,
Siccome il Tempo Pasquale dura fino alla Pentecoste, dobbiamo sforzarci di approfondire un po’ spiritualmente questo grandissimo Mistero meditando il suo senso e la sua importanza per noi. Domanderemo a San Paolo di aiutarci nella nostra meditazione; è stato lui invero che sotto l’ispirazione dello Spirito Santo ha potuto per primo insegnarci la significazione teologica e spirituale di questo fatto meraviglioso di tutta la Storia della Salvezza, e il punto centrale di essa.
Prima di tutto l’Apostolo presenta la Risurrezione di Gesù Cristo come un fatto storico bene stabilito da molti testimoni. Ai Corinzi che avevano molti dubbi relativamente alla Risurrezione scrive: Vi trasmisi invero quanto anch’io ho ricevuto, che, cioè, Cristo morì per i nostri peccati, conformemente alle Scritture; e che fu sepolto e risorse il terzo giorno, conformemente alle Scritture; e che apparve a Cefa e poi ai Dodici. In seguito apparve a oltre cinquecento fratelli in una sola volta e, di questi, la maggior parte resta tuttora in vita, mentre alcuni sono morti. Apparve quindi a Giacomo, poi a tutti gli Apostoli. In ultimo, dopo tutti, apparve anche a me, come all’aborto. Si, io sono il minimo degli Apostoli, neppure degno di essere chiamato Apostolo, perché perseguitai la Chiesa di Dio… Tanto io, dunque, quanto essi così predichiamo e voi a questa fede avete aderito (1 Cor 15, 3-9.11).
Il pensiero dell’Apostolo è chiaro: la fede della Chiesa nella Risurrezione di Cristo riposa su fatti storici bene attestati da molti testimoni oculari. L’Apostolo parla chiaramente con grande insistenza come se avesse previsto i nostri tempi. Oggidì assistiamo a uno sforzo ostinato di molti esegeti critici della Bibbia che mirano a sradicare la fede cristiana dal suo suolo storico. Il mondo della fede sarebbe secondo loro un mondo spirituale fuori dalla storia e senza realtà storica. L’Apostolo Paolo invece insiste sulle prove storiche della Risurrezione del Signore. Ma S. Paolo non si ferma qui, ma subito ci fa entrare nelle viscere del Mistero. Ora – dice – se si predica che Cristo è risorto dai morti come mai ci sono tra voi alcuni che dicono che non c’è risurrezione dei morti? Se non c’è risurrezione dei morti neppure Cristo è risorto! (1 Cor 15, 12-13).
Abbiamo già qui un’interpretazione teologica del fatto della Risurrezione che non si capisce da sé. Un ragionamento puramente umano avrebbe detto: “Se io ammetto il fatto della Risurrezione di Cristo perché è attestato da molti che Lo hanno visto vivo dopo la sua morte sulla croce, da questo non risulta che gli altri morti potrebbero anche risorgere. Ragionamento umano giusto”. Ma qui entra già la dottrina soprannaturale dell’Apostolo ricevuta dallo Spirito Santo. Nessun altro potrebbe sapere questo. L’Apostolo ci insegna l’esistenza d’un misterioso legame tra noi e Gesù morto e risorto. Se Lui è risorto, dobbiamo risorgere anche noi. Questa è una necessità a ragione di questo legame, una necessità tale che, negando la risurrezione dei morti, si deve negare anche quella di Gesù, perché la sua non avrebbe senso senza la nostra. Quindi, negando la risurrezione dei morti si deve arrivare alla negazione di tutta la religione cristiana: Se non c’è risurrezione dei morti, neppure Cristo è risorto! Ma se Cristo non è risorto allora la nostra predicazione è vana, vana anche la nostra fede… Voi siete ancora nei vostri peccati. Non solo: anche quelli che si sono addormentati in Cristo si sono perduti, e noi che in questa vita abbiamo posto speranza in Cristo soltanto, siamo tra tutti gli uomini i più degni di commiserazione (1 Cor 15, 13-14.17-19).
Pertanto da questo misterioso legame che ci unisce al Cristo morto e risorto, San Paolo continua sviluppando la sua profonda dottrina sulla Risurrezione: Ora invece Cristo è davvero risorto dai morti, primizia di quelli che si sono addormentati nel sonno di morte. Poiché la morte venne per opera di un uomo, anche la risurrezione dei morti viene per opera di un uomo (1 Cor 15, 20-21). In questa grandiosa visione teologica l’umanità è presentata come in uno stato di mietitura. In questa ingente mietitura l’Uomo Cristo è la primizia, seguono migliaia e migliaia di uomini dei quali la morte è qui presentata come un sonno: “Christus primitiae dormientium”.
Come infatti tutti muoiono in Adamo, così pure tutti in Cristo saranno richiamati in vita. Ciascuno però nel suo ordine: primizia è Cristo; quindi quelli che alla sua venuta saranno di Cristo; poi la fine! (1 Cor 15, 22-24). In questa immagine della prima Lettera ai Corinzi vediamo tutta l’umanità in via verso la fine che sarà la risurrezione dai morti. L’Umanità della quale il Cristo si è fatto capo e primizia; l’Umanità rapita da Dio in Cristo si trova in via verso la gloria del Risorto. La prospettiva della 1 Cor riguarda il problema della risurrezione finale.
Ma la teologia pasquale di San Paolo non si ferma qui. Nell’Epistola ai Colossesi lui scrive: Se siete risorti con Cristo, cercate le cose dell’alto, dove Cristo è assiso alla destra di Dio, pensate alle cose dell’alto, non a quelle della terra. Voi siete morti, infatti, e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati nella gloria (Col 3, 1-4 ). Qui vediamo qualche cosa di nuovo. Non si parla soltanto di una risurrezione futura già assicurata per la Risurrezione di Cristo, ma non ancora effettuata. Qui si parla dello stato attuale del cristiano che è uno stato di risurrezione, e, siccome “agere seguitur esse”: l’agire segue l’essere, corrisponde all’essere, così a questo stato di risurrezione deve corrispondere un agire. Nella Lettera ai Corinzi San Paolo disse che risorgeremo dopo la morte per opera di Cristo che è risorto come nostra primizia; qui invece insegna che già siamo risorti, la risurrezione è una realtà già attuale in noi, una forma di vita che ci è stata data da Dio tramite i sacramenti della Chiesa e alla quale dobbiamo sottomettere tutto il nostro agire. Dobbiamo dunque cercare le cose dell’alto non soltanto perché sono migliori, ma perché questo cercare delle cose dell’alto è una esigenza di questa nuova vita proveniente dal Signore Risorto, con il quale siamo uniti misteriosamente ma realmente. Dobbiamo quindi “cercare le cose dell’alto dove Cristo è assiso alla destra di Dio”. Dove Cristo è, là devono dirigersi i nostri desideri.
Ma nella Lettera agli Efesini San Paolo dice ancora qualche cosa di più. Ecco le sue parole: Dio ricco in misericordia, per la grande carità con cui Egli ci ha amati, morti come eravamo per le nostre colpe, ci ridonò la vita con Cristo… e con Lui ci risuscitò e ci fece sedere nelle regioni celesti, in Cristo Gesù (Ef 2, 4-6). I nostri desideri devono dirigersi “dove Cristo è assiso alla destra del Padre”. Poiché in Lui siamo già in queste “regioni celesti” anticipatamente. Ma in questo mondo il pensiero della risurrezione non è mai totalmente separato da quello della morte. Nella sua Lettera ai Colossesi l’Apostolo trova una bellissima forma sintetica per esprimere il mistero della vita del cristiano: “Voi siete morti, e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio” (3, 3).
6. L’incontro in Galilea (Mt 28, 16-20) [18]
Quando Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salomone sono venute al sepolcro per imbalsamare il corpo di Gesù, il sole era già levato. Il vero Sole dell’umanità, la luce del mondo brillava già sopra il firmamento con tutto il suo splendore. Esse dicevano tra loro: “Chi ci rotolerà la pietra dalla porta del sepolcro?” (Mc 16, 3). Ma alzati gli occhi, videro che la pietra era stata già rotolata; eppure era molto grande. Questo era un senso simbolico. Anche noi in questo Tempo Pasquale siamo invitati ad alzare gli occhi e vedere con una grandissima gioia che l’ingente pietra della nostra tomba è stata già rotolata e possiamo uscire dalla morte verso la vita piena ed eterna nella luce del vero Sole. Questo Mistero contempliamo con una fede illuminata, con una gioia sempre rinnovata.
Nel Vangelo di San Matteo, e anche in quello di San Marco, le donne sono mandate dall’angelo annunziatore della Risurrezione del Signore agli Apostoli con l’ordine per loro di recarsi in Galilea per incontrare Gesù. Questo misterioso appuntamento era già stato dato da Gesù ai discepoli prima della sua Passione. Difatti, dopo l’ultima cena, strada facendo verso il monte degli Ulivi, disse loro: “Tutti voi patirete scandalo a causa mia questa notte; sta scritto infatti: Percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse; ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea” (Mt 26, 31-33). Sappiamo dal Vangelo che il Signore si è incontrato coi suoi discepoli più volte dopo la Sua Risurrezione. La maggioranza degli incontri riferiti dagli Evangelisti aveva luogo a Gerusalemme e nei dintorni. Soltanto due incontri troviamo nei Vangeli che hanno avuto luogo in Galilea: uno raccontato da San Matteo e l’altro da San Giovanni. Ma quello del quale parla Giovanni aveva un carattere piuttosto privato. Gesù si è mostrato ai discepoli al lago di Genezareth. Quello invece del quale parla Matteo ha una importanza speciale. È un appuntamento ufficiale, fissato dal Signore stesso ancora prima della Sua Passione, al gruppo ristretto degli Apostoli.
San Matteo dice che l’incontro ha avuto luogo su un monte designato da Gesù e accenna alla presenza degli Undici. Gli interpreti suggeriscono il monte Tabor o il monte delle Beatitudini, ma l’Evangelista non lo dice. La sua relazione è laconica: Vedendolo, gli si prosternarono; mentre alcuni avevano dubitato. Gesù avvicinatosi, parlò loro dicendo: A me fu dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque, istruite tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco io sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo (Mt 28, 18-20).
Questo discorso di Gesù ha un carattere molto solenne. Tutto qui ha una grande importanza. Prima abbiamo qui una solenne affermazione e una proclamazione che il Cristo risorto ha ricevuto dal Padre un assoluto ed illuminato potere sopra tutte le creature. Questo potere si estende a tutto l’universo visibile e invisibile. L’Uomo Figlio di Dio ha pieno potere anche sugli Angeli del Cielo e sulle potenze infernali, come scrive San Paolo ai Filippesi: “perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi in cielo, sulla terra, nell’inferno e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è Signore” (Fil 2, 10-11). Da questo potere del Risorto non esiste nessuna esenzione. Questo assoluto e universale potere di Gesù Cristo e questa necessità di sottomettersi totalmente a Lui esistono dal momento della Sua Resurrezione. Nel momento quando dice queste parole agli Apostoli Lui è già il Sovrano universale; ma la sottomissione effettiva del mondo sotto il suo scettro costituisce un lungo processo che comincia solamente nel momento quando Cristo parla agli Undici.
La Lettera agli Ebrei dice citando il Salmo 8: “Che cosa è l’uomo che Tu te ne ricordi o il figlio dell’uomo che Tu lo riguardi? L’hai fatto per poco più piccolo degli angeli, di gloria e d’onore l’hai coronato, tutto hai assoggettato ai suoi piedi. Dicendo che tutto è assoggettato a Lui, nulla ha lasciato a Lui non soggetto! Ora però non vediamo ancora assoggettate a Lui tutte le cose” (Eb 2, 6-8). Nel capitolo decimo della stessa Lettera agli Ebrei Cristo ci è presentato come aspettante la piena realizzazione della sua dominazione universale: “Offerto un unico sacrificio per i peccati, in perpetuo si assise alla destra di Dio, attendendo ormai fino a che i suoi nemici siano posti a sgabello dei suoi piedi” (Eb 10, 12-13). Così anche in ciascuno di noi il suo potere è già pieno e assoluto, ma la realizzazione del suo pieno dominio in noi si effettua gradatamente per l’azione dello Spirito Santo e la nostra sempre più perfetta sottomissione a questa azione. Il Regno di Dio è dunque già realizzato nella Risurrezione di Cristo. Lui è veramente il Re, e il suo potere è assoluto e universale. Ma d’altra parte il Regno di Dio si trova “in statu fieri”, si svolge nel tempo in mezzo a molteplici ostacoli e difficoltà. E perciò dobbiamo sempre pregare: “Venga il Tuo Regno!” (Mt 6, 10). Questa evoluzione dinamica, questo misterioso sviluppo del Regno di Dio nel mondo costituisce uno spettacolo affascinante per la fede che si sente fortemente e profondamente impegnata.
S. Paolo nella prima Epistola ai Corinzi ha un bellissimo passo che ci mostra la fine di questa evoluzione del Regno che non si fa senza una lotta terribile contro le potenze diaboliche: “Poi la fine, quando Egli rimetterà il regno di Dio, il Padre, dopo aver distrutto ogni principato e ogni dominazione e potenza. Bisogna infatti che Egli regni finché non abbia posto tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L’Ultimo nemico a essere eliminato sarà la morte. Dio infatti tutto ha posto sotto i suoi piedi. Ma quando dice che tutto gli è stato sottomesso, fa evidentemente eccezione colui che tutto gli ha sottomesso. Solo quando tutto gli sarà sottomesso, allora anche lo stesso Figlio si sottometterà a colui che gli ha sottomesso tutte le cose, affinché Dio sia tutto in tutti” (1 Cor 15, 24-28). Vediamo quindi che il potere assoluto e universale dato al Cristo Risorto deve realizzarsi poco a poco in lotta contro le potenze contrarie. La nostra preghiera: “Venga il Tuo regno” è piena di senso anche dopo la Risurrezione di Gesù Cristo e dopo la solenne proclamazione del suo potere universale dinanzi agli Apostoli in Galilea.
Continuando il suo solenne discorso agli Apostoli, Gesù dice: Andate dunque, istruite tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo (Mt 28, 19). Gesù manda gli Apostoli nel mondo in virtù di questo stesso potere universale. Ma come può il Signore mandare i suoi discepoli in un mondo non ancora sottomesso al suo soavissimo giogo? Come può mandare i suoi discepoli ideali in un mondo dove le potenze diaboliche non sono ancora rotte e occupano le posizioni chiave? È certo che queste potenze terranno duro e non cederanno senza una terribile resistenza. Nondimeno Gesù li manda “come pecore dai lupi” (Mt 10, 16). Il mondo non vuole sottomettersi al Cristo. Ecco la radice del martirio! Cosa normale nella storia dell’apostolo cristiano. Come nell’Antico Testamento Dio diede la Palestina agli Ebrei, ma essi stessi con l’aiuto divino dovevano conquistarla, così anche nel Nuovo Testamento il mondo deve essere sottomesso al Cristo, conquistato per Lui con un impegno personale dei discepoli di Cristo durante tutta la storia fino alla fine del mondo.
In questa prospettiva possiamo capire meglio il senso profondo della nostra professione monastica e della Regola di San Benedetto. San Paolo ha scritto ai Romani: “Per la disobbedienza di un solo uomo gli altri furono costituiti peccatori, per l’obbedienza di uno solo gli altri saranno costituiti giusti” (Rm 5, 19). L’Apostolo insegna il valore soteriologico dell’obbedienza di Cristo che costituisce una forza di sottomissione che piega l’uomo ribelle verso l’obbedienza a Dio. L’obbedienza monastica non ha un senso solamente ascetico, ma ha anche un senso soteriologico. Essa costituisce un aumento nella Chiesa di quella forza di sottomissione che vince la forza di ribellione, minuisce gli influssi diabolici nel mondo e avvicina il momento della sottomissione universale. Gli Apostoli sono mandati a tutti popoli della terra senza nessuna eccezione. Tutto il mondo deve riconoscere in Cristo il suo Re e Signore. Per questo incarico enorme e sopraumano gli Apostoli non sono lasciati con le sole forze umane.
Il Vangelo parla di una doppia armatura: (1) Istruite tutte le Genti – la Parola di Dio; (2) battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo – battesimo e tutta la ricchezza sacramentale della Chiesa.
(1) La Parola di Dio è una potenza sopranaturale, una potenza divina, data alla Chiesa per il suo grande combattimento spirituale per la salvezza del mondo. S. Paolo parlando del Vangelo dice: “Certo io non mi vergogno del Vangelo: Esso è potenza divina per la salvezza di quanti sono credenti” (Rm 1, 16). La Parola di Dio è una potenza non di distruzione, ma una potenza di luce e di amore, che salva l’uomo adducendolo alla conversione. Più la Parola di Dio sarà pura nella predicazione dei sacerdoti, non mescolata con una sapienza mondana, tanto più fortemente agirà per mezzo di essa la potenza salvatrice di Dio. Noi possiamo indebolire l’azione salvatrice della Parola di Dio, se non ci sottomettiamo noi stessi a questa Parola e non la trasmettiamo nella sua purezza.
(2) battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Queste parole hanno una grandissima importanza dottrinale. Non c’è un altro testo nel Novo Testamento ove sia così chiaramente espressa l’uguaglianza tra le Tre Persone divine. Il battesimo ricevuto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo significa che l’immersione visibile nell’acqua battesimale invisibilmente immerge l’uomo nella vita ineffabile della Santissima Trinità. Senza il battesimo l’uomo può soltanto adorare Dio come unico Dio suo Creatore. Invece, immerso nella vita interiore di Dio per il battesimo, entra in speciali relazioni in rapporto al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo e può rivolgersi a ciascuna di queste Santissime Persone. Pensiamo a questo ineffabile mistero dell’immersione nella Trinità.
7. Ascensione [19]
La solennità che comincia questa sera appartiene alle grandi solennità liturgiche della Chiesa. Il Signore Gesù Cristo dopo la più dolorosa morte, dopo la più profonda umiliazione della Sua Passione, è stato onorato da Dio. Il Padre L’ha glorificato nella vita eterna alla sua destra per tutti i secoli dei secoli. La Chiesa si rallegra nella gioiosa certezza che Gesù Cristo non soffre più, che le mani dei nemici non possono ormai raggiungerLo.
Durante l’Ultima Cena, parlando con gli Apostoli il Signore disse loro: Finora non avete chiesto nulla nel mio nome! Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia perfetta (Gv 16, 24). Queste parole del Signore possono essere capite come un delicato rimprovero ai discepoli perché non domandano in suo nome quando pregano. Alcuni difatti le capiscono così. Mi sembra invece più probabile che non vi sia nessun rimprovero, ma un senso teologico più profondo. I discepoli non chiedevano nel nome di Gesù e non potevano chiedere ancora così, giacché la preghiera nel suo nome non esisteva ancora, non era ancora nata. Il Sacerdote eterno doveva prima penetrare i cieli e riposarsi alla destra di Dio. Fino a questo momento il gran Mistero della Salvezza, il Mistero di Cristo, non era ancora compiuto. Non si poteva quindi pregare come oggi preghiamo noi: “Per il Nostro Signore Gesù Cristo Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell’Unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli”. Adesso lo diciamo con gaudio della nostra fede, sapendo che l’accesso nostro a Dio è una realtà.
Che cosa sarebbe la nostra vita, se questo accesso fosse ancora chiuso? Così non si può pensare, Fratelli. Il senso principale dei nostri eremi consiste appunto in questo accesso a Dio, in questa possibilità per l’uomo di accedere a Dio. Per questo abbiamo abbandonato tutto, per questo ci siamo chiusi in questi bellissimi eremi, per avvicinarci a Dio, per conversare con Dio, per essere con Dio. Questo costituisce anche la nostra testimonianza davanti al mondo, il nostro grido agli uomini, il messaggio degli eremiti. Essi dicono agli uomini: “Coraggio, non perdete la speranza, l’accesso è aperto, l’unione dell’uomo con Dio è ormai possibile. E forse questa forte proclamazione è il più importante impegno degli eremiti nel mondo. Se la vita nostra è un segno visibile ed eloquente di questa importantissima realtà dell’apertura dell’accesso a Dio per gli uomini, è normale che noi viviamo di questa realtà in una maniera specialmente intensa. Questo lo sappiamo tutti, ma ciascuno di noi nell’esperienza della propria vita sa che per l’uomo mortale il problema del contatto con Dio non è facile, anche se è essenziale. Non soltanto la nostra esperienza personale, ma anche l’esperienza degli altri, l’esperienza della Chiesa, l’esperienza delle diverse famiglie religiose durante la storia ci dice molto su questo punto. Quanti conventi, quanti monasteri che erano quasi radicati in Dio per la loro fede e il loro forte spirito di preghiera, poi si sono vuotati di questo spirito. L’architettura rimasta ne parla ancora, ma lo spirito non c’è più.
Tutto questo mostra nel mondo una lotta terribile. L’oggetto di questa lotta implacabile è appunto il contatto dell’uomo con Dio. Cristo ha aperto l’accesso nel glorioso giorno della Sua Ascensione, ma il diavolo fa tutto per chiudere questo accesso e tagliare il contatto dell’uomo con Dio. Il diavolo teme l’uomo che è in contatto con Dio. È l’unica cosa che lui teme. Tutte le altre grandezze dell’uomo non sono niente per lui. Nel Medio Evo i Cistercensi davano ai loro monasteri nomi molto significativi. Questi nomi, come Mellifont, Clairefontaine ecc…, significavano la presenza di Dio come sorgente di beni spirituali, abbondanti per quelli che pieni di fede e di santi desideri Lo cercavano nella preghiera e nella contemplazione.
Se la fedeltà alla preghiera è la causa universale di tutti i beni, così l’abbandono della preghiera, la perdita del contatto vivificante con Dio è la causa di tutti i mali. Come il contatto elettrico è in se stesso semplice, ma produce molti effetti diversi di luce, di calore, di movimento, di forza, così il contatto con Dio si manifesta diversamente nei suoi effetti, rimanendo semplice in se stesso. Qui, nella ripresa di questo contatto, non altrove, è la guarigione totale dell’uomo, sia considerato individualmente, sia come società. Il Profeta Isaia nel capitolo 64 ci presenta un’immagine raccapricciante della situazione morale del popolo. Dice: “Siamo divenuti tutti come una cosa impura, tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come vento – e la ragione –: Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si svegliava per stringersi a te” (Is 64, 5-6).
Carissimi, in questa gloriosa solennità dell’Ascensione del Signore vediamo da una parte la porta del cielo aperta per l’uomo, la santità di Dio meravigliosamente resa accessibile al povero vermetto della terra, e dall’altra parte sentiamo le questioni dei giovani olandesi rivolte al Papa che rivelano non solamente un abbandono della fede, ma anche della stessa umana natura. La coscienza di questi giovani non segnala più alle loro anime le esigenze elementari della legge naturale umana. Davanti a una tale miseria come non pensare alla situazione morale menzionata dal Profeta Isaia: “Perché, Signore, ci fai deviare dalle tue vie e hai indurito il nostro cuore, così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servitori, per amore delle tribù tua eredità. Perché gli empi hanno calpestato il tuo santuario, i nostri avversari hanno profanato il tuo luogo santo? Siamo divenuti come coloro su cui tu non hai mai comandato, sui quali il tuo nome non è stato mai invocato. Siamo divenuti tutti come una cosa impura, tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come vento. Nessuno invocava il tuo nome nessuno si svegliava per stringersi a te. Oh, squarciassi tu i cieli e discendessi!” (Is 63, 17-19)
Il monaco deve ricominciare sempre di nuovo il suo sforzo di preghiera, il rinnovamento continuo del suo vivificante contatto con Dio. L’importante è non scoraggiarsi. La dottrina della Scrittura e dei Santi ci avverte che le difficoltà su questa strada possono essere grandi. Per avere un contatto veramente profondo con Dio l’uomo deve essere purificato spiritualmente per l’esperienza nella fede della verità piena secondo la triplice relazione che esiste tra lui e Dio: Figlio – Padre; creatura – Creatore; peccatore – Santo. L’Esigenza della piena verità lo farà sperimentare non soltanto la vicinanza di Dio e il suo amore, ma anche l’infinita distanza tra il Creatore e la creatura e l’opposizione tra il Santo e il peccatore. Per tutto questo dovrà coraggiosamente passare. Uno dei testi scritturistici che esprimono in una maniera specialmente bella e profonda la dolorosa purificazione della preghiera è certamente il capitolo 3 delle Lamentazioni: “Egli mi guidò, mi fece camminare nelle tenebre, non nella luce. (...) Mi circondò tutt’intorno perché non uscissi, appesantì le mie catene. Anche se grido e chiamo il soccorso, egli soffoca la mia preghiera. Sbarrò la mia via con blocchi di pietra, sconvolse i miei sentieri. (...) Mi saziò con erbe amare, mi dissetò con assenzio. (...) Buono è Jahvé con chi spera in Lui, con l’anima che lo cerca. Buona cosa è aspettare con silenzio la salvezza di Jahvé. Buona cosa è per l’uomo portare il giogo fin dalla giovinezza. Sieda costui solitario e faccia silenzio quando egli gli impone il giogo. Metta nella polvere la bocca, poiché forse c’è ancora speranza” (3, 2.7-9.15.25-29).
8. Ascensione e Pentecoste [20]
Incominciamo oggi la celebrazione della Solennità dell’Ascensione del Signore e tra una settimana avremo la grandissima gioia di commemorare la venuta dello Spirito Santo nel nostro povero mondo. Siccome sabato prossimo non avremo il Capitolo a ragione della Messa Vespertina occorrente, è giusto unire nella nostra odierna meditazione le due grandi solennità. Invero non si deve fare una costruzione artificiale per considerare ambedue queste Solennità “per modum unius”, perché già da sé esse costituiscono una unità impressionante.
Nel giorno della sua gloriosa Ascensione il Signore Gesù Cristo, come Uomo, dopo aver subito la tremenda sofferenza e umiliazione della sua Passione e morte, salì “usque ad summum coeli”, penetrò nell’intimo segreto della sfera della vita divina: Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; adesso lascio il mondo e torno al Padre (Gv 16, 28). Ma sappiamo che Lui non ha fatto questo per se stesso, ma l’ha fatto per noi. La festa dell’Ascensione non è quindi una commemorazione soltanto della sua salita nel cielo e della sua glorificazione. Oggi si realizza anche per noi questo meraviglioso passaggio, questo ingresso nella sfera di vita e di realtà celeste. Questo si compie misteriosamente in noi grazie alla partecipazione che abbiamo nel Cristo, partecipazione che fa che i misteri del Cristo siano nostri misteri.
Queste parole che Gesù ha pronunciato parlando di se stesso devono realizzarsi anche in noi: “sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; adesso lascio il mondo e torno al Padre”. Tutti noi siamo usciti dal Padre per la creazione e per la divina filiazione, e per noi tutti è questo destino: “adesso lascio il mondo e torno al Padre”. Per noi, monaci ed eremiti che vogliamo seguire il Signore, che abbiamo udito la Sua chiamata e cerchiamo le formule semplici e forti di vita, non c’è un programma più semplice e più affascinante di questo: “adesso lascio il mondo e torno al Padre”. Il Figlio di Dio non è venuto in questo mondo soltanto per conoscerlo con la sua santissima presenza, non è venuto in questo mondo soltanto per essere più insieme con noi e darci la sua presenza; ma è venuto per prenderci con sé, per attirarci nella sua marcia forzosa verso il Padre. Carissimi Confratelli, appunto la vita eremitica costituisce forse sulla terra il segno più eloquente di questa realtà dell’Ascensione del Signore Gesù. Dobbiamo meditare questo.
La Lettera agli Ebrei chiama Cristo pròdromos, quello che corre primo, quello che apre la corsa e gli altri lo seguono. Tutti corrono, tutti si affrettano per seguire questo primo, questo (pròdromos – in greco). E dove corre Lui? Dove Lo seguiamo? “Usque ad interiora velaminis”, dice la Scrittura: “oltre il velo”. Che cos’è questo velo? Nell’Antico Testamento un velo separava il primo tabernacolo, chiamato “Santo”, dal secondo, chiamato “Santo dei Santi”. Nel primo tabernacolo entravano i sacerdoti per compiervi gli uffici del culto; ma nel secondo, il solo sommo sacerdote, una volta all’anno, non senza sangue. Questo velo era un simbolo eloquente che significava che l’uomo peccatore non aveva accesso all’intimità di Dio. La vita interna di Dio rimaneva inaccessibile all’uomo. Solo il sommo sacerdote poteva entravi, ma soltanto una volta l’anno e non senza sangue. Questa prescrizione della Legge di Israele era una profezia. Il sommo sacerdote entrante nel “Santo dei santi” con sangue prefigurava Gesù che doveva col suo proprio sangue entrare una volta per sempre nel cielo, aprendolo per l’umanità intera. E per ciò dice la Lettera agli Ebrei: “abbiamo un forte incoraggiamento, noi che troviamo scampo nell’attaccarci all’offerta speranza; la quale teniamo come àncora dell’anima, sicura e salda e che penetra oltre il velo, dove precursore per noi entrò Gesù, divenuto Sommo Sacerdote in eterno” (6, 19-20).
Siamo dunque già ancorati dietro il velo, nella misteriosa vita divina! Si parla qui di speranza, ma il sacro testo ci dà una speciale teologia della speranza. La speranza cristiana non è soltanto una virtù che aspetta da Dio la vita eterna e l’aiuto della sua grazia in questa vita appoggiandosi sulla divina infinita bontà e misericordia, la sua fedeltà e la sua potenza. La speranza è certamente tutto questo, ma è ancora di più, è un legame misterioso con Cristo glorioso nel cielo alla destra del Padre. Per la Sua Ascensione siamo stati ancorati “oltre il velo”. È bene, dunque – Carissimi Fratelli – di pensare spesso al cielo. Se gli Ebrei deportati in Babilonia dicevano: “Se mai ti dimenticassi, Gerusalemme, mi fallisca la destra; mi aderisca la lingua al palato, se non ti ricordo, se non esalto Gerusalemme in capo alla mia canzone gioiosa” (Sal 136, 5-6), tanto più noi dobbiamo spesso e intensamente pensare alla nostra Patria Celeste, alla nostra Vera Gerusalemme.
Che cosa può essere più consolante e più elevante per un autentico eremita del pensiero alla vita eterna? “Nella casa del Padre mio – dice il Signore Gesù – vi sono molte dimore… vado a preparare un posto per voi. E quando sarò partito e avrò preparato un posto per voi, ritornerò e vi prenderò con me, affinché dove sono io siate anche voi” (Gv 14, 2-3). È bello e molto conforme al nostro ideale di contemplativi di fermarci con interna compiacenza a queste immagini piene di luce e di splendore spirituale che abbiamo negli ultimi capitoli dell’Apocalisse, immagini dell’eterna bellezza che non avrà tramonto: “E vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Infatti il primo cielo e la prima terra passarono, e il mare non è più. E vidi la città santa, Gerusalemme nuova, che scende dal cielo, da presso Dio, preparata come sposa che è stata ornata per il marito. E udii una voce grande proveniente dal trono che diceva: Ecco la dimora di Dio con gli uomini…, e Dio stesso sarà con essi e tergerà ogni lacrima dei loro occhi, e la morte non sarà più, né lutto, né grido né dolore saranno più; ché le cose di prima passarono. E disse colui che sedeva sul trono: Ecco, faccio nuove tutte le cose. (…) e mi trasportò in spirito sopra un monte grande e alto, e mi mostrò la città santa Gerusalemme che scende dal cielo da presso Dio, avendo in sé la gloria di Dio. (...) e la città era di oro puro simile a vetro puro. (...) E la città non ha bisogno del sole né della luna che la rischiarino; poiché la gloria di Dio la illuminò e la sua lucerna è l’Agnello. (...) E nessuna maledizione vi sarà più (…) e vedranno la sua faccia, e il suo nome sarà sulle loro fronti (…) e regneranno per i secoli dei secoli.” (Ap 21, 1-3.4-6.10.18.23, e 22, 3.4.5).
Ma che cosa significa per l’uomo la partecipazione all’Ascensione di Cristo se non una assunzione nella vita divina? E questa assunzione nella vita divina si fa per il dono dello Spirito Santo. Se nella Solennità dell’Ascensione consideriamo l’elevazione dell’uomo in Cristo fino al cielo, la festa della Pentecoste ci rivela il cielo discendente sulla terra. Siccome lo Spirito Santo è Dio, ricevere lo Spirito Santo, partecipare nello Spirito Santo significa entrare nel cielo, penetrare nell’intimo santuario della vita divina. Quindi, quando Cristo è salito nel cielo, l’uomo doveva cominciare ad essere celeste, ad essere con Cristo nel cielo. Questo si è realizzato nella giornata della Pentecoste, quando il Cielo nella Persona dello Spirito Santo è disceso sui discepoli di Cristo assumendoli nella vita divina. Questo stretto legame tra la glorificazione di Cristo e la venuta dello Spirito Santo è sottolineato già da Gesù stesso: “Nell’ultimo giorno… della festa (delle Capanne), Gesù in piedi disse ad alta voce: Se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me. Come ha detto la Scrittura, fiumi di acqua viva scorreranno dal suo seno. Questo disse dello Spirito che dovevano ricevere i credenti in Lui; lo Spirito infatti non era stato ancora dato, perché Gesù non ancora era stato glorificato” (Gv 7, 37-39). La venuta dello Spirito Santo è la nascita della Chiesa come Corpo Mistico del Cristo glorificato. Le opere di Dio hanno una somiglianza tra di loro. Nella creazione dell’uomo Dio prese un elemento terreno e insoffiò la vita. Nella creazione della Chiesa Lui prese anche un elemento terreno – gli Apostoli, e poi insoffiò il suo Spirito e la Chiesa ha cominciato ad esistere come un corpo vivente.
Se abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, dobbiamo credere di averlo ricevuto e dunque dobbiamo vivere nello Spirito Santo. Una cosa molto importante per ciascuno di noi è sapere che lo Spirito Santo è colui che dirige la nostra vita. Si deve distinguere una doppia direzione dello Spirito Santo nella Chiesa: una esterna e l’altra interna. La direzione esterna dello Spirito si fa mediante la Rivelazione e la Chiesa. Nella Scrittura, nella Tradizione, nell’insegnamento del Magistero della Chiesa lo Spirito insegna e dirige gli uomini. Questa è la direzione esterna. Ma c’è anche una direzione interna. Lo Spirito insegna e dirige l’uomo attraverso interne inspirazioni. Tutto ciò che viene dallo Spirito di Dio è buono, sia che venga per la via esterna, sia che venga per la via interna. Tra la direzione esterna e quella interna non possono esistere dei contrasti giacché Dio non può essere contrario a se stesso. Ma ciò che viene per la via esterna della Chiesa è più sicuro, invece nelle nostre ispirazioni interne possiamo più facilmente sbagliarci attribuendole allo Spirito di Dio. La Chiesa però ha la missione e l’autorità dallo Spirito Santo di giudicare anche l’autenticità divina delle inspirazioni interiori delle anime, specialmente quando quelle ispirazioni riguardano un’opera esteriore nella Chiesa (fondazioni, ecc.).
9. San Benedetto [21]
Abbiamo celebrato questa settimana la festa del Padre nostro San Benedetto. Lui non fu il nostro fondatore, ma ben nostro Legislatore. Il nostro Santo Padre e Fondatore, San Romualdo, fu formato alla sua scuola e ha voluto che i suoi figli lo fossero ugualmente. La Regola di San Benedetto è il codice veramente ispirato che ci trasmette l’antico spirito monastico e l’antica disciplina monastica, maturata nei primi secoli del cristianesimo, da uomini santi e pieni della sapienza divina. La festa del nostro Santo Padre e Legislatore ci invita a fermarci un po’ per contemplare la bellezza divina della sua vocazione e della sua opera. La figura di San Benedetto ha qualche cosa di monumentale nella semplicità e nella serietà della sua totale appartenenza a Dio. Nella pienezza della sua paternità rassomiglia al Patriarca Abramo, e come questo Patriarca cammina con Dio con una straordinaria semplicità, realizzando quasi naturalmente la grande opera di Dio a lui affidata. È certamente utile e salutare per noi rinnovare questo nel nostro cuore per la meditazione nello spirito della Santa Regola che dobbiamo considerare come un dono preziosissimo del Signore: “Lucerna pedibus meis” (Sal 119, 105).
Il fondamento di tutta la spiritualità della Regola consiste nel contatto personale con Dio. Il libro della Genesi racconta nel capitolo 16 come Agar fuggente dalla severità di Sarai è consolatala Dio, dopo la sua visione alla sorgente d’acqua nel deserto, e chiamò quel pozzo Lakhai-Roi, cioè “al vivente che mi vede” (cf. Gn 16, 13-14). Il Santo Padre Benedetto vuole il suo discepolo a questo pozzo, davanti “al vivente che mi vede”. Da questo punto parte tutta la spiritualità benedettina. Già nel Prologo alla Regola troviamo questo confronto dell’uomo con Dio. Lo ritroviamo poi nel capitolo settimo sull’umiltà, della quale costituisce la sorgente e la base. L’umiltà benedettina non è frutto di esercizi di autodisprezzo, né di umiliazioni artificiali, ma essa scaturisce da questo confronto con Dio, da questo contatto vivo e spirituale col Signore alla sorgente Lakhai-Roi, dove San Benedetto vuole condurre e mantenere il suo discepolo.
Quando la vita si stabilisce sotto lo sguardo di Dio, nella viva presenza di Dio, davanti al suo volto splendente e maestoso, nasce nell’anima un profondo senso della grandezza di Dio, della sua infinità maestà. E allora si sveglia un ardente desiderio di adorazione, di sottomissione e di umiliazione. Appunto in un tale profondo e vivo desiderio consiste ciò che possiamo considerare come la vera personalità del monaco: un atteggiamento adorante, umiliato e sottomesso, cioè obbediente. Abbiamo qui le caratteristiche principali di una vera personalità monastica: spirito di religione, umiltà e obbedienza. Siccome il contatto con Dio costituisce l’unica sorgente di queste virtù fondamentali, ne risulta una personalità ben unita, armoniosa e coerente.
La visione dell’obbedienza di San Benedetto è più teologica e soteriologia che semplicemente ascetica, benché questo punto di vista non manchi. Le parole della Regola: ut ad eum per obedientiae laborem redeas, a quo per inobedientiae desidiam recesseras (Prologo) non spettano soltanto al candidato concreto che si presenta per essere ricevuto, ma a tutti, e possiamo dire all’umanità intera. L’uomo concreto che domanda di farsi monaco deve rendersi conto dello stato teologico dell’umanità alla quale appartiene. L’umanità si trova in uno stato di disobbedienza e di ribellione contro Dio. Questo stato, che può essere sanato solamente per mezzo di una amorosa e totale sottomissione al Signore e alla sua volontà, in parte ci perviene dell’obbedienza del Cristo. Ecco in un semplicissimo schema tutto il problema della santificazione: adorare, umiliarsi, sottomettersi perfettamente. A questo scopo deve servire la “Schola Dominici servitii” (Prologo).
Il candidato dunque, entrando nel monastero, assume in sé tutta la storia del genere umano caduto e redento per viverla in sé concretamente. San Paolo scrive ai Romani: “Per la disobbedienza di un solo uomo gli altri sono costituiti peccatori, per obbedienza di uno solo gli altri sono costituiti giusti” (Rm 5, 19). L’obbedienza del Cristo ha raddrizzato la linea di tutta l’umanità, resa storta per l’influsso dello spirito diabolico. Il monaco vuole partecipare in una maniera speciale e privilegiata a questo raddrizzamento dell’uomo per l’obbedienza del Cristo. Questa è la sua vocazione speciale nella Chiesa. In questa prospettiva profondamente teologica e semplice dell’obbedienza si capisce che San Benedetto tratta il candidato alla vita monastica non come uno che vuole sviluppare e perfezionare le sue qualità, ma come un peccatore che vuole convertirsi per ritornare a Dio mediante una perfetta sottomissione. La Regola di San Benedetto è più una Regola di ritorno a Dio che una regola di perfezionamento, anche se quest’ultima idea è presente al Santo Autore più forse sotto la forma di un’ascensione per diversi gradi verso l’abitazione di Dio.
Si parla spesso della “pax benedettina”, sottolineando una caratteristica impressione di pace che la vita benedettina fa su quelli che la incontrano. Questo si può capire bene se si pensa che ciò che possiamo chiamare “il movimento della Regola” è nient’altro che il ritorno a un ordine divino delle cose, un ordine obiettivo nel quale ciascun essere ha il suo posto, i suoi limiti, la sua autenticità. La pace non è altro che la “tranquillitas ordinis”. Non è dunque da meravigliarsi che appunto da questa Regola, che fa rientrare tutto nell’ordine eterno di Dio, emana un’atmosfera particolare di pace.
Ci sono delle concezioni della Regola di San Benedetto che, sottolineando i diversi atteggiamenti spirituali del monaco benedettino, dimenticano la forte ascesi personale insegnata da San Benedetto nella Sua Regola. Il capitolo 4: “Quae sunt instrumenta bonorum operum”, ci mostra il monastero come luogo di un lavoro ascetico personale, serio e fervoroso. Questo aspetto essenziale sarebbe da sottolineare nei nostri tempi.
È vero che San Benedetto si mostra molto misurato quando si tratta delle mortificazioni corporali. Dopo l’austerità dei Padri del Deserto, il suo codice può sembrare di introdurre un certo lassismo. Esaminando più a fondo il sistema ascetico della Regola vediamo che le sue esigenze spirituali sono fortissime. Nell’umiltà, nell’obbedienza, nella povertà San Benedetto mostra delle esigenze intransigenti. Il suo programma spirituale non ammette nessun minimalismo, nessuna mediocrità, il monaco deve umiliarsi fino al fondo dove la grazia di Dio lo troverà per esaltarlo.
Il monastero benedettino ha una struttura ecclesiale, una struttura teologica più di molte altre comunità religiose nella Chiesa. Ho assistito una volta a Varsavia a una conferenza sulla comunità religiosa secondo la dottrina del Vaticano II. Il conferenziere era un Redentorista. Parlava con entusiasmo sulla dottrina del Concilio Vaticano II. Secondo lui il Concilio ha scoperto una teologia della vita comune che prima non era conosciuta. È certamente vero che le Congregazioni Apostoliche come i Redentoristi, nelle loro piccole comunità totalmente organizzate in funzione del lavoro apostolico, non vivevano una teologia della vita comune e potevano praticamente ignorarla. Ma la comunità benedettina è teologica in tutta la sua concezione. Nella sua struttura essa è una concretizzazione della Chiesa. Il fondamento e il centro è l’Abate che rappresenta e prolunga la viva presenza del Cristo, su cui tutto si appoggia e da cui tutto riceve la vita e la coesione. L’Eucarestia e la preghiera liturgica con la Parola di Dio formano la spina dorsale della vita spirituale della Comunità. Tutta la giornata trova qui il principio della sua organizzazione e della sua santificazione in Cristo. I princìpi dell’unità, dell’autorità, del servizio, della partecipazione, della carità fraterna, del mutuo aiuto, tutti questi elementi della vita ecclesiale e della teologia della Comunità sono già presenti nella Comunità benedettina fin dal principio. Tutti questi principi si verificano anche negli eremi camaldolesi che sono vere comunità di eremiti, sono anche comunità di preghiera, nonostante la specifica ricerca da eremiti di una preghiera solitaria.
10. San Lorenzo [22]
Festeggiamo oggi uno dei più celebri martiri della Chiesa. La Chiesa ama i suoi martiri, li onora, si gloria di questi soldati che hanno combattuto fino alla fine senza cedere al male e l’hanno vinto nella morte. Dalle solennità dei martiri si possono trarre molti insegnamenti per la vita cristiana, ma oggi vorrei fermarmi su un pensiero che mi sembra importante, cioè che la vita cristiana è una prova. Questa verità è messa in rilievo speciale nei combattimenti dei martiri, ma non si può dubitare che ogni cristiano debba essere provato in questa vita per raggiungere la corona. A questo pensiero dobbiamo ritornare spesso per non addormentarci nel nostro sforzo ascetico quotidiano, per stimolare sempre di nuovo le nostre energie spirituali.
Dio ci prova. È un pensiero fecondo, Dio ci prova, Dio ci tratta sul serio. L’uno o l’altro avvenimento nella ma vita, un affanno, una umiliazione, una debolezza… che mi sembravano essere mali e costituire pure ostacoli sul mio cammino, hanno un altro senso, un altro volto quando penso: Dio sta provandomi. Allora tutto ha un senso, tutto diviene vivo. A noi tutti dice la Sapienza del Siracide: Figlio, se ti accosti al servizio del Signore, disponi la tua anima alla prova (Sir 2, 1). Quindi, secondo le parole della Sapienza c’è un relazione necessaria tra il servizio del Signore e la prova: “Figlio, se ti accosti al servizio del Signore, disponi la tua anima alla prova”. Se dunque hai preso un fermo proposito di servire Dio, non pensare di poter scappare dalla prova. Perché questa necessità della prova?
1. Perché servire Dio è sottomettersi alla Sua volontà e la Sua volontà è una volontà di perfezionamento e di santità per noi: “Haec est voluntas Dei: sanctificatio vestra” (1 Ts 4, 3). La santificazione richiede una trasformazione profonda dell’uomo, una purificazione totale della sua mente e del suo cuore, e questo non può realizzarsi senza dolorosi distacchi e molte sofferenze.
2. E poi il diavolo non è mai in vacanza. Egli, come nostro avversario accanitissimo e implacabile, è deciso a non lasciarci passare. Come i popoli nemici d’Israele non volevano lasciarlo passare per impadronirsi della Terra Promessa. Essi hanno detto duramente: “Non passerai!”, e sono venuti armati al suo incontro. Tutti questi popoli che volevano impedire al Popolo di Dio di passare il loro territorio per andare verso la Terra Promessa, simboleggiavano le potenze infernali. A ciascuno di noi l’Angelo infernale grida: “Non passerai!” È dunque chiaro che, se nondimeno vogliamo proseguire la nostra marcia, incontreremo la sua ferma resistenza.
3. Anche il Signore stesso vuole provare il nostro amore. Ci sono dunque delle prove che non risultano direttamente dalle difficoltà inerenti allo sforzo di perfezionamento, né provengono dall’ostilità del demonio, ma vengono direttamente dal Dio dell’amore che vuole provare l’amore del suo servo e figlio. La prova è dunque una realtà che sempre è presente nella nostra vita. È importante per noi riconoscerla e trovare un atteggiamento giusto verso di essa per approfittarne spiritualmente. Il Siracide ci dà un insegnamento profondo e pratico in materia. Ecco come ne parla nel suo capitolo 2: Figlio, se ti accosti al servizio del Signore, disponi la tua anima alla prova, abbi un cuore retto, sii costante e non turbarti sotto la prova. Tieniti unito a Lui intimamente e non separartene, perché tu ne resti avvantaggiato in seguito. Ricevi quanto ti invierà e sii longanime nelle vicissitudini delle tue afflizioni: poiché l’oro viene provato con il fuoco, e gli uomini graditi nella fornace dell’umiliazione. Affidati a Lui e ti prenderà in tutela, segui la retta via e spera in Lui (2, 1-6).
Dobbiamo analizzare un po’ questo bellissimo insegnamento della Sapienza di Dio, educatrice degli uomini! È una pedagogia santa, piena di serenità e di pace. Il primo che ci consiglia è un sereno realismo. Non considerare la prova che ci viene come qualche cosa di straordinario e di terribile. Il soldato volontario che si offre per andare alla guerra, capisce bene la sua propria decisione. Lui sa che alla guerra si combatte e si spara. Quindi non è sorpreso di trovare al fronte la sparatoria e un costante pericolo. Così quello che vuole servire Cristo non si nutre di pie illusioni, ma sa bene quale opera vuol fare. E dunque il primo consiglio ci spinge a una piena e realistica consapevolezza dell’opera che facciamo. Questo realismo non permette all’anima di turbarsi né di meravigliarsi di ciò che accade, perché si rende perfettamente conto che con la sua ferma decisione di servire Dio si è esposta alla prova. Con un tale atteggiamento dispone l’anima sua alla prova.
Poi dice: “Abbi un cuore retto, sii costante e non turbarti sotto la prova”. Ci sono qui tre raccomandazioni: (1) la rettitudine del cuore, (2) la costanza, (3) e la pace interna. L’Uomo deve assicurarsi della rettitudine del suo cuore, deve controllare questa rettitudine e raddrizzare ciò che non sarebbe dritto. Vediamo qui che le grandi prove costituiscono impulsi per controllare la propria coscienza e raddrizzarla. Senza una buona e retta coscienza l’uomo non può sopportare la prova senza esserne profondamente turbato. La coscienza retta e il cuore retto ci danno questa pace fondamentale, necessaria per poter attraversare le prove e uscirne vincitori. “Abbi dunque un cuore retto”, e poi “sii costante”. Le sofferenze inerenti ad una prova agiscono sullo spirito umano spingendolo a fuggire, quindi a cambiare sperando di trovare un alleviamento nel cambiare. È una illusione pericolosa. Nei continui cambiamenti l’anima non troverà l’alleviamento desiderato, ma un maggiore turbamento. Costanza nell’amore, costanza nella fiducia, costanza nell’impegno assunto, costanza nell’adempimento del dovere quotidiano, costanza in una pace serena sotto le ali di Dio, qualsiasi cosa avvenga. La pace non è soltanto un dono di Dio, ma anche un obbligo dell’uomo. Esiste una vera ascesi della pace. Molti sembrano non saperlo. Questa ascesi della pace conviene in una maniera tutta speciale ai monaci.
Ma tutti questi atteggiamenti spirituali non sarebbero niente e non avrebbero consistenza senza quello del quale parla nel versetto terzo: “Tieniti unito a Lui intimamente e non separatamente, perché tu ne resti avvantaggiato in seguito”. Ecco un’altra condizione indispensabile per poter uscire vincitore dalla prova della nostra vita: Essere unito a Dio. Senza l’unione con Dio è impossibile per l’uomo vincere nel combattimento della vita. Questo ammonimento appartiene già alla vita mistica come quello del Signore Gesù: “manete in me” (Gv 15, 4). Che cosa sia questo: “manete in me” e come praticamente obbedire a questo sublime precetto, ognuno deve a poco a poco arrivare, in collaborazione con la grazia divina, a capire che cosa questo significa per lui e come egli debba personalmente realizzarlo.
La vita cristiana non è mai puramente ascetica, ma è sempre radicalmente mistica, siccome l’unione con Dio ne è la sorgente e non soltanto il fine e il premio. È bellissimo ciò che ne dice qui la Sapienza: “Tieniti unito a Lui intimamente e non separartene”. È certo che, se l’uomo è unito a Dio, non può peccare, perché dove c’è Dio il peccato non è possibile. Prima di poter peccare l’uomo deve separarsi da Dio. L’Atto di separarsi da Dio è l’atto importantissimo che precede ogni caduta morale dell’uomo. Questo doppio stadio nella tentazione, la quale è la prova “par excellence”, troviamo nell’insegnamento di San Giacomo, che nel primo capitolo della sua lettera scrive: “Ciascuno è tentato dalla propria concupiscenza” (Gc 1, 14) e qui vengono due parole molto significative. Il testo della Vulgata ha: “abstractus et illectus”, è una traduzione buona del greco: ekselkómenos kaì deleazómenos. “Abstractus et illectus” sono quasi due momenti di una tentazione vincente. Primo momento: “abstractus”: la tentazione astrae la mente dalla presenza di Di,o dal contatto con Lui. Poi viene il secondo momento: “illectus”: la mente separata da Dio si lascia trascinare dalla concupiscenza verso un oggetto illecito.
Se nel caso d’una tentazione l’unione con Dio costituisce invero l’unica difesa decisiva (almeno se si tratta di forti tentazioni), la sua importanza è grandissima anche nelle altre prove della vita di chi vuole seriamente servire il Signore. La Sapienza parla di una intima unione con Dio: “Tieniti unito a Lui intimamente e non separartene”. Qui è la segreta e vera sorgente di ogni bene e di ogni perseveranza nell’autentico bene. A questo preziosissimo ammonimento il Siracide aggiunge una promessa riguardante il futuro: “perché tu ne resti avvantaggiato in seguito”.
Alcuni, infiammati dall’amore di Dio, hanno pensato che l’amore per essere perfetto non deve più pensare al premio, non deve più desiderare il cielo, né la vita eterna. Tra gli altri ha insegnato una simile dottrina Fenelon. La Chiesa non ha approvato questa dottrina e Fenelon si ritrasse. Non si deve mai pensare che la perfezione della carità esiga il sacrificio della speranza. Cristo non ha mai insegnato una carità senza speranza. Lui disse che dobbiamo avere il nostro tesoro nel cielo, non ci esorta di non avere nessun tesoro. Non pensiamo che ci possa essere un cristianesimo più perfetto di quello che ci è stato predicato e donato nel Vangelo. La vita cristiana perfetta consiste nella pienezza delle tre virtù teologali: la fede, la speranza e la carità. La speranza è una forte virtù, essa costituisce il dinamismo della nostra corsa verso la Casa del Padre e la vita eterna. Viviamo intensamente la speranza. Una continua promessa del bene a chi compie la volontà di Dio costituisce uno dei caratteri più risaltanti nella Parola di Dio e in ciò che possiamo chiamare “lo stile personale del nostro Dio”.
Le parole citate del Siracide: “perché tu ne resti avvantaggiato in seguito”, sono in perfetta armonia con questo stile divino. Gli ammonimenti della Sapienza divina, indirizzata a quelli che vogliono intraprendere il combattimento per la giustizia in questo mondo, indicano le condizioni di un combattimento vittorioso. La rettitudine del cuore, la costanza che sa perseverare tranquillamente senza fuggire, uno spirito pacato e calmo che non si lascia turbare, e con tutto questo un’intima unione con Dio che innanzitutto teme di separarsi da Lui.
III. Biblica
1. Commento al Salmo 2 [23]
Perché tumultuano le genti/ e i popoli progettano invano?/ Si accampano i re della terra/ e i potenti complottano insieme./ Dicendo: “Marciamo contro Jahvé/ e contro il Suo Unto./ Rompiamo le loro catene / e gettiamo da noi le loro ritorte! (Sal 2, 1-3).
Così il Salmo 2. Che cosa vede il Salmista? Certamente vede una ribellione, una grande ribellione. È forse una ribellione delle tribù di Israele contro il loro re? No, perché si parla delle genti che tumultuano, si parla dei re della terra che si accampano. La prospettiva è però più larga. Ma forse sono le nazioni inimiche che si preparano ad una invasione della Terra d’Israele? Non sarebbe dunque una ribellione, ma una preparazione di guerra contro il popolo d’Israele? Ma allora perché tutte queste genti personalizzate nei loro re direbbero: “Rompiamo le loro catene e gettiamo da noi le loro ritorte!” Non sono queste parole di guerra, ma bensì di ribellione. Vogliono ribellarsi a un potere che sembrava loro duro e insopportabile. Il Salmista cita le loro stesse parole: “Marciamo dicono – contro Jahvé e contro il Suo Unto”. Per l’Unto di Jahvé si potrebbe capire il re di Israele, siccome i re di Israele ricevevano una unzione. Ma Israele era un piccolo paese che non dominava su molte nazioni e su molti re.
Possiamo dunque vedere qui una visione profetica di una grande ribellione contro Dio e contro il suo unico Unto Gesù Cristo. Dio ha mandato il Suo Figlio nel mondo per instaurare il Suo Regno tra gli uomini. L’instaurazione del Regno di Dio sulla terra fu l’incarico del Figlio di Dio. Dallo stesso inizio della sua missione Gesù Cristo incontrò la resistenza, la durezza di cuore, la ribellione. Poi gli Apostoli furono perseguitati, trascinati dai magistrati, dai giudici, tormentati e uccisi. E così dal suo principio fino a oggi la Chiesa è sempre in stato di guerra contro il mondo, contro il principe di questo mondo e contro le ingenti forze del male che operano in questo mondo.
Questo stato di guerra continua è per sé un mistero. Naturalmente non si capisce l’odio che ha incontrato Cristo in cambio del suo amore, della sua bontà manifestata in tante guarigioni e tante opere di misericordia. Neppure si capisce perché la sua dottrina evangelica, dottrina di una sapienza sublime, di carità e di pace, ha trovato tanto odio in risposta. Il Vangelo, e specialmente quello di S. Matteo e di S. Giovanni, sono pieni del terribile e tenebroso mistero del male. Cristo, il Vangelo, la Chiesa hanno nemici implacabili, coi quali non sarà mai possibile una riconciliazione. Sono le potenze spirituali e invisibili che cercano di distruggere ogni bene. Ci sono oggi alcuni cristiani ingenui che vorrebbero riconciliarsi con tutti e sarebbero disposti a prendere un atteggiamento pacifico ed ecumenico anche verso i diavoli, che ne ridono. Questo mistero di odio si basa su una ribellione, la ribellione degli angeli caduti e perciò è così implacabile. Sono loro che dicono: “Marciamo contro Jahvé e contro il Suo Unto. Rompiamo le loro catene e gettiamo da noi le loro ritorte”.
Ma queste parole le sentiamo spesso assunte dagli uomini di oggi. È certamente vero che la crisi spirituale dei nostri giorni si manifesta in un rifiuto di obbedienza. La parola stessa di obbedienza provoca delle reazioni allergiche, come il concetto di potere o di autorità. Alcuni dicono apertamente: parlateci di amore, ma non di obbedienza. Non vogliamo sentire più di questo. Siamo liberi e siamo adulti. Di obbedienza parlate ai bambini… Chi sta dietro una tale mentalità, se non chi ha già rotto le catene del santo timore di Dio e della santa sottomissione alla sua volontà?
In presenza di questa grande ribellione che cosa fa il Signore? Chi siede nei cieli se ne ride,/ il Signore si fa beffe di loro (Sal 2, 4).
Per prima cosa il Salmista fa capire che la ribellione contro Dio è una cosa propriamente ridicola. Tutte le grandissime potenze dell’universo creato anche riunite insieme sono un nulla davanti al Creatore. Dio ride dell’impotenza orgogliosa delle creature che pensano di essere qualche cosa di importante anche dinanzi a Dio stesso. L’illusione di essere qualche cosa è sempre un atteggiamento semplicemente ridicolo in una creatura “ex nihilo”. Tutta questa terribile ribellione contro Dio può sembrare nella prospettiva del mondo una cosa impressionante, ma nella prospettiva di Dio, cioè nella verità, è semplicemente degna d’un sorriso di commiserazione.
Poi si volge a loro nella sua ira/ e nel suo furore li sgomenta (Sal 2, 5).
La Sacra Scrittura parla molto dell’ira di Dio in immagini spesso bellissime. Studiando i testi che ne parlano vediamo che l’ira di Dio è una manifestazione del suo amore. L’ira è l’amore respinto e contrariato. L’Amore di Dio è una forza infinita. Dio ama fortemente l’uomo. Questo amore che secondo le immagini bibliche è appassionato, non può cambiarsi in indifferenza quando l’uomo lo rifiuta. L’indifferenza è contraria alla natura divina. L’amore divino ferito è l’ira di Dio, l’ira che colpisce e punisce chi respinge l’amore ma che non cessa mai di essere amore e di essere misericordia.
Possiamo immaginare un grande fiume. L’ingente mole di acque scorre tranquillamente, pacificamente senza distruggere niente. Ma se si pone un ostacolo a questo enorme volume di acque scorrenti, esse divengono una forza terribile che rompe le dighe. Il grande errore della gente di oggi è di avere una concezione laicizzata della bontà e della misericordia di Dio, di pensare che le grandi pene sono incompatibili con la misericordia di Dio. Secondo la Rivelazione invece, quando il popolo di Dio s’immerge nel peccato, quando arriva ad un alto grado di ribellione e di sfacciataggine, si deve temere un intervento terribile dell’ira del suo Signore, cioè del suo amore geloso e forte: Poi si volge a loro nella sua ira/ e nel suo furore li sgomenta (Sal 2, 5).
La storia ci racconta diverse situazioni dell’umanità, anche le decadenze del popolo di Dio; c’erano delle persecuzioni della vera fede, ma la ribellione contro Dio in forma di una vera ostilità contro Dio stesso e contro l’atteggiamento religioso come tale, questo è una vera novità sconosciuta dalla storia. Si pensa che siamo arrivati al momento della grande apostasia predetta da San Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi: “È necessario che prima si verifichi l’apostasia, si manifesti l’iniquo, il dannato, l’avversario colui che si esalta al di sopra di tutto ciò che porta il nome di Dio o è oggetto di culto, fino a insediarsi nel tempio di Dio e a proclamarsi Dio… Il mistero dell’iniquità infatti già esercita la sua azione nefasta… La manifestazione dell’empio, per l’azione di Satana, sarà accompagnata da ogni specie di portenti, segni e prodigi ingannevoli e da ogni specie di seduzioni di cui l’iniquità è capace, a danno di quelli che si perdono perché non hanno accolto l’amore per la verità che li avrebbe salvati” (2 Ts 2, 3-4.7.9-10). L’ateismo moderno sembra essere già la manifestazione di questa orrenda apostasia generale escatologica. A tutto questo tumulto delle forze ostili Dio risponde non soltanto con la sua ira, non soltanto con il suo furore che sgomenta i nemici, ma con una decisione pacifica e ferma della sua volontà.
Ma io ho stabilito il mio Re,/ sul Sion mio Santo Monte (Sal 2, 6).
La volontà di Dio immutabile, immobile è la roccia contro la quale si frantumeranno tutte le forze contrarie. Dio ha fondato la Chiesa come Regno di Cristo suo Figlio e niente può contrapporsi alla forza di questo decreto divino. Il Salmista insegna che se Dio ha stabilito qualche cosa, ogni ribellione è vana, ogni discussione è vana. L’unica cosa che si può fare è di sottomettersi pienamente alla volontà di Dio. Ora la volontà di Dio è che Cristo sia Re e che tutto sia sottomesso a Lui.
Nei versetti seguenti udiamo la voce del nuovo Re promulgante il decreto divino:
Ho da annunziarvi il decreto di Jahvé. Mi disse: Mio Figlio sei tu,/ oggi io ti ho generato./ Chiedimi e Ti darò le genti in eredità/ e in possesso le estremità della terra./ Li romperai con scettro di ferro,/ come creta di vasaio li frantumerai (Sal 2, 7-9).
Parole piene di profondità. Mi disse: “Mio Figlio sei Tu, oggi io ti ho generato”. Secondo la natura un figlio oggi generato non è capace di assumere il potere regale. Si può dunque pensare alla generazione divina nell’oggi dell’eternità.
“Chiedimi e Ti darò le genti in eredità/ e in possesso le estremità della Terra.” Dice “Chiedimi e Ti darò”. Il Figlio di Dio ha dovuto chiedere per ricevere dal Padre il Regno. Quando ha chiesto se non nella Sua Passione? In Croce ha chiesto il Regno, che poi Gli fu dato dopo la Resurrezione, come Egli stesso dice nel Vangelo di San Matteo: “Mi è stato dato ogni potere nel/ cielo e sulla terra”.
“Li romperai con scettro di ferro,/ come creta di vasaio li frantumerai”. Questo ci pare severo, ma esprime una verità profonda della vita spirituale. Ciascuno di noi non può veramente avvicinarsi a Dio né appartenere al Regno di Cristo senza la grazia della contrizione. Dobbiamo essere contriti, cioè rotti e quasi frantumati interiormente per poter veramente ricevere in noi stessi la vita divina. Ci sono tante durezze nel cuore dell’uomo! Gli ultimi versetti sono una conclusione pratica del Salmo. Contro la volontà di Dio che stabilisce il Regno del Suo Figlio non si può far niente. L’unica via da seguire è quindi quella dell’umiltà e dell’obbedienza: Or dunque re, fate senno…/ servite Jahvé in timore/ ed esultate in tremore, portate doni/ che non si adiri…/ perché divampa per poco la sua ira./ Felici quanti si rifugiano in Lui! (Sal 2, 10-11).
2. Commento al Salmo 4 [24]
Quando ti invoco rispondimi, Dio, mia giustizia:/ dalle angosce mi hai liberato;/ pietà di me, ascolta la mia preghiera.
Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore?/ Perché amate cose vane/ e cercate la menzogna?
Sappiate che il Signore/ fa prodigi per il suo fedele:/ il Signore mi ascolta quando lo invoco.
Tremate e non peccate,/ sul vostro giaciglio/ riflettete e placatevi.
Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
Molti dicono: “Chi ci farà vedere il bene?”/ Risplenda su di noi, Signore,/ la luce del Tuo Volto.
Hai messo più gioia nel mio cuore/ di quando abbondano vino e frumento.
In pace mi corico e subito mi addormento:/ Tu solo, Signore,/ al sicuro mi fai riposare.
Il Salmo costituisce la preghiera di un uomo che ha esperimentato la bontà di Dio nella sua propria vita. Dice al Signore pieno di una santa riconoscenza: “dalle angosce mi hai liberato.” È proprio dell’azione divina di mettere l’anima al largo. Ogni operazione spirituale che serra, che stringe, non è di origine divina e non riflette la natura di Dio. Dio mette l’anima al largo, come dice il testo latino del nostro Salmo: “in tribulatione dilatasti mihi”.
Il Salmista, avendo sperimentato Dio e la sua straordinaria bontà nella propria vita, è pieno di stupore guardando gli uomini, come essi vivono, amando e ricercando cose vane, incoscienti dei veri valori. Vedere questo è per il Santo salmista un vero scossone. Lui si rivolge agli uomini con un grido sdegnato: “Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?”
A colui che conosce Dio, che vive in contatto con Lui, la vita come la vivono gli uomini moderni pare un assurdo. Il Salmo ci mostra che un’autentica esperienza di Dio è necessariamente apostolica. Essa spinge l’uomo che ne è beneficato a rivolgersi ai peccatori per predicare loro la necessità di una conversione a Dio. La caratteristica del peccatore è la durezza di cuore e la menzogna, cioè l’incapacità di giudicare le cose di questo mondo secondo il loro vero valore. Questa incapacità di giudicare le cose conformemente alla verità costituisce uno stato di menzogna. Un cuore implicato nelle cose mondane e nella loro continua ricerca diviene duro e incapace di capire, se si tratta di cose divine e grazia di Dio.
Il Santo invece sa bene che essi potrebbero esperimentare delle meraviglie dell’azione divina nella loro propria vita, se non fossero così appesantiti e inconsiderati. Di questo lui vuole convincerli:
Sappiate che il Signore fa prodigi/ per il suo fedele./ Il Signore mi ascolta quando lo invoco./ Tremate e non peccate,/ sul vostro giaciglio,/ riflettete e placatevi (Sal 4, 4-5).
Queste parole contengono una grande verità della vita spirituale: il cristiano potrebbe avere una esperienza personale della meravigliosa azione di Dio, se fosse aperto alla sua grazia. Ma l’attrattiva dei beni apparenti lo rende duro e pesante. In questo stato lui avrebbe bisogno di uno scossone salutare per liberarsene: “Tremate e non peccate”. Per essere liberato da un mondo fittizio e irreale egli ha bisogno di una percossa della verità. Dopo lo scossone che provoca alla conversione viene una calma riflessione che, in collaborazione con la grazia divina, apporta una modifica decisiva alla vita: “sul vostro giaciglio/ riflettete e placatevi”. Su questo problema importantissimo dell’apertura alla grazia e della durezza di cuore ciascuno di noi deve riflettere.
Dopo la conversione comincia una vita rinnovata, una vita totalmente rivolta a Dio. A questa vita nuova si riferisce l’ultimo consiglio del Santo salmista ai peccatori chiamati alla conversione e a un radicale rinnovamento della vita. Dice loro nel versetto 6: “Offrite sacrifici di giustizia/ e confidate nel Signore”.
Ecco un bel programma di vita rinnovata espresso in poche parole, due con solo “ sacrifici di giustizia”: sono tutti questi atti buoni che dobbiamo fare. Tutti hanno un valore religioso, sono “sacrifici”. Abbiamo qui una bella concezione della vita. L’uomo che compie i suoi doveri, l’uomo che fa la volontà di Dio, è un vero sacrificatore. La sua vita è un continuo offrire a Dio sacrifici graditi al Signore. Ma non meno importante è il secondo consiglio: “e confidate nel Signore”. Senza questo secondo neppure il primo si potrebbe adempiere. La fiducia in Dio deve pervadere tutta la nostra vita, tutti i nostri atti, giacché non possiamo fare niente di veramente salutare senza la grazia di Dio. Molte buone risoluzioni vengono meno perché non sono immerse nella potente grazia di Dio mediante una vera e profonda fiducia. Siamo di natura pelagiani incorreggibili. Ecco veramente un bel programma di vita proposta da un santo a peccatori desiderosi di conversione e di cambiamento di vita: “Offrite sacrifici di giustizia / e confidate nel Signore”.
Nel versetto 7 il Salmista introduce una obiezione umana contro il dovere di una vera conversione di vita: “Molti dicono: Chi ci farà vedere il bene?”
È una obiezione che si sente spesso ancora nei nostri tempi. Un dubbio sul vero bene, sul senso della vita umana, sulla retribuzione nella vita eterna, pervade l’umanità ancora oggi. Purtroppo si trova questo dubbio anche tra i cristiani. Questo dubbio, questa incertezza che si incontra nei cuori degli uomini fa male al cuore del Santo. Egli sente la sua incapacità di far passare la sua serena certezza di fede rinforzata dall’esperienza personale della bontà di Dio in questi cuori vacillanti. Si rivolge quindi a Dio in una ardente preghiera in favore del mondo non credente o fluttuante nella fede. È una preghiera bellissima che chiede l’unico ed essenziale rimedio per tutti, per tutta l’umanità ammalata che si dibatte nelle sue tenebre. “Risplenda su di noi, Signore / la luce del Tuo Volto!” Ecco la preghiera di Cristo per un mondo immerso nelle tenebre del peccato: “Risplenda su di noi, Signore,/ la luce del Tuo volto!” Non c’è altro rimedio, non c’è altra soluzione del problema dell’uomo. “Risplenda su di noi, Signore,/ la luce del Tuo volto!” Così anche un altro Salmo propone la soluzione del problema dell’uomo: “Dio degli eserciti, ristoraci;/ fa brillare il Tuo volto e saremo salvi!” (Sal 80, 8).
L’Uomo è creato per Dio, è creato per vedere Dio, e quindi la soluzione di tutti i problemi umani è il Volto di Dio, la rivelazione del volto di Dio come S. Giovanni dice nella sua prima lettera: “Sappiamo che quando si manifesterà, saremo somiglianti a Lui, poiché lo vedremo così come è” (1 Gv 3, 2). Ognuno di noi può con piena verità ripetere per se stesso questa ardente preghiera del Salmista: “Risplenda su di noi; Signore, / la luce del Tuo volto!”
Finito il suo discorso ai peccatori e la preghiera per loro il Santo si rivolge a Dio con un ringraziamento per il gran dono della gioia spirituale, della quale si sente ricolmo. È una gioia soprannaturale e misteriosa che non si può paragonare a nessun’altra gioia nel mondo. Per far risaltare il carattere imparagonabile e soprannaturale di questa gioia dice: “Hai messo più gioia nel mio cuore/ di quando abbondano vino e frumento”. La gioia della mietitura rappresenta ogni gioia umana naturale come gioia dell’abbondanza dei beni della Terra. Ma questa misteriosa gioia che riempie il cuore dell’uomo senza che egli sappia da dove viene, questa misteriosa gioia senza oggetto concreto che trasforma tutto in chiarore, questa è un dono di Dio: “Tu hai messo più gioia nel mio cuore”. È Dio solo che mette la sua gioia nel piccolo cuore della sua creatura. L’ultimo frutto della grazia di Dio è la pace profonda e la sicurezza sotto la protezione misericordiosa di Dio: “In pace mi corico e subito mi addormento:/ Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare”.
3. Salmo 23, 1-3 [25]
Il Creatore ha proprietà assoluta di tutto ciò che esiste, se l’esistenza stessa non è niente di più che l’effetto immediato d’un atto di volontà di Dio e non dura neppure un istante di più di questo atto. Tutto l’immenso cosmo, tutti gli esseri spirituali e materiali sono in ogni momento totalmente dipendenti dalla durata di questo atto che li ha chiamati dal non essere all’essere. Tutto questo ha fatto nostro Padre e tutto questo gli appartiene. Nella letteratura si incontra l’uomo che sente nell’universo come una forza nemica, terribile che lo fa sentire solo e abbandonato davanti a un mondo ostile e pericoloso. Tale atteggiamento non è cristiano. Questo universo è stato creato da nostro Padre e per noi le cose create sono beni di famiglia che ci fanno sentire a casa. Dunque:
Del Signore è la terra e quanto contiene, l’universo e i suoi abitanti (Sal 23, 1).
Il cristiano ama tutto questo e si sente, tra le creature, come nella casa paterna.
È Lui che l’ha fondata sui mari, e sui fiumi l’ha stabilita (Sal 23, 2).
I mari e i fiumi, come generalmente le grandi acque, significano potenze nemiche e pericolose. Si può dire dunque, pensando alla fondazione della terra, che Dio ha fondato la Chiesa sui mari e l’ha stabilita sui fiumi, che la forza divina ha dato alla Chiesa una stabilità miracolosa malgrado non ci sia nulla di stabile, e che l’essere naturale, tutto il mondo, si possono paragonare alle grandi acque dove tutto è fluido, niente è fermo, niente è stabile. Così, in questo mondo, la Chiesa appare come l’unico punto forte, l’unico punto stabile che Dio ha miracolosamente creato e fortificato e posto in mezzo a una realtà fluida che nulla ha di forte e stabile. Una tale visione della Chiesa nel mondo è impressionante e vera. Il Salmista mette in rilievo la misteriosa forza che mantiene la Chiesa nella forza di Dio, quando tutto è mobilità, cambiamento, debilità e inconsistenza.
Però possiamo dare un’altra interpretazione creando un’altra visione della Chiesa fondata sui mari e stabilita sui fiumi, considerando le grandi acque questa volta come simbolo della infinita abbondanza della grazia di Dio – Dio è il Bene infinito. Lui è il Ricco che fa tutto con una infinita generosità. Si può dunque insistere sull’infinita generosità di Dio e sull’abbondanza immensa della sua grazia. Dio fa tutto in modo divino, non si può esprimere con concetti umani ma, in parte, con simboli. Ciò che si dice della Chiesa si può anche riferire all’anima. L’anima è fondata e stabilita su grandi acque. E anche pensando all’anima le acque sono simbolo di forze selvagge elementari e ostili, simbolo della fluidità del mondo che non può dare alcun appoggio all’anima, ma le acque possono anche richiamare l’abbondanza delle grazie divine che inondano il cristiano in vita.
Chi salirà il monte del signore, chi starà nel suo luogo santo? (Sal 23, 3)
È vero, Signore, che Tu sei invisibilmente presente tra le Tue creature, ma Tu hai il Tuo luogo, infinitamente elevato, Tu abiti una luce inaccessibile. E nessuno può vedere Te e vivere. Come si può porre una tale questione: Chi salirà al monte del Signore, chi starà nel suo luogo santo? Il Salmo non solo pone tale quesito, ma dà pure una risposta! Questo è il centro meraviglioso del mistero cristiano: l’uomo abiterà nel luogo di Dio, abiterà in una casa con Dio, vivrà in Dio e di Dio. Questo è incredibile. Si deve dire che l’essenza del cristianesimo è costituita di incredibile!
4. Salmo 86 [26]
Salmo arduo e sublime. Canta il mistero della maternità universale di Gerusalemme. Di tutte le città del mondo, di tutte le città di Giacobbe la prediletta per il Signore è Gerusalemme, che i profeti hanno celebrato con mirabili vaticini sulla sua futura gloria.
Le sue fondamenta sui monti santi,/ Jahvé ama le porte di Sion/ su tutte le tende di Giacobbe/ cose gloriose si dicono di te/ città di Dio./ Posso citare Rahab e Babilonia fra i miei conosciuti,/ ecco i Filistei e Tiro con Cush/ questi è nato là!/ E di Sion si dice: “Questi e quelli è nato in essa;/ ed Egli la consolida, l’Altissimo./ Jahvé elenca nel registro dei popoli:/ questi è nato in essa./ E canteremo come danzatori:/ tutte le mie fonti sono in Te! (Sal 86, 1-7).
Ci sono state diverse città, diversi regni e imperi in questo mondo, imperi potenti suscitanti ammirazione tra gli uomini. Come l’Impero Romano con il suo spazio, con la sapienza delle sue istituzioni, con le sue leggi che ispirano ancora oggi legislatori moderni. L’Impero Romano ha potuto radunare molte nazioni sotto il suo potere e sotto il suo governo non solamente energico, ma anche prudente e misurato. Ma nel corso della storia del mondo, mentre diversi regni si succedono, Dio si costruisce una città, Dio si prepara il Regno definitivo. Gerusalemme come Città Santa, Città del Signore Dio, era soltanto un’immagine, un segno debole di questa somma realtà.
5. Salmo 92, 1-5 [27]
Il Signore regna, si ammanta di splendore; Il Signore si rivesta, si cinge di forza; rende saldo il mondo, non sarà mai scosso. (Sal 92, 1) Pensiamo al Regno di Dio, al suo splendore, alla sua gloria immensa. Essa è più reale in questo momento. Già posso vederla attraverso la fede, contemplarla, gioirla. Dobbiamo imparare a vivere di questa realtà invisibile (all’occhio), ma visibile alla fede. La nostra fede, già attraverso il velo, l’àncora della nostra speranza, già sta in questo splendore, già vive di questa potenza, di questa gioia invincibile. Tutto il mondo e le sue cose sono un soffio se paragonate a questa realtà così vicina e così nostra. Che cos’è tutta la nostra vita di fede se non una contemplazione continua della verità, della realtà invisibile ma presente, di questo splendore del Regno che è già nostro unico appoggio. L’educazione cristiana in stretta collaborazione colla grazia dello Spirito Santo non cerca altro che stabilire la nostra vita nella verità. Questa realtà che possediamo già invisibilmente per fede è il nostro unico appoggio, la nostra unica gioia, cioè la nostra vita è già un vero inizio della vita eterna. Se la nostra pedagogia non è questo, non è una vera pedagogia cristiana.
Questo Salmo è pasquale. Il Signore fu umiliato, oltraggiato, maltrattato, ucciso, ma ecco, Egli stesso regna, si ammanta di splendore: si rivesta, si cinge di forza. La Pasqua cambia tutto: ecco, sorge già un mondo nuovo, ma non come questo che un gran terremoto può distruggere, che uno scontro interplanetario può annientare. Il mondo nuovo – dice il Salmista – è differente: “Il Signore rende saldo il mondo, non sarà mai scosso” (Sal 92, 1). Ecco, scioglie davanti agli occhi della nostra fede un mondo eterno, un mondo in cui non esiste niente che non sia già avvolto dalla giustizia di Dio. Contempliamo con ammirazione il Re sul suo Trono celeste e diciamo: Saldo è il Tuo Trono fin dal principio, da sempre Tu sei! (Sal 92, 2)
Nella gioia della vittoria pasquale contempliamo il nostro Re vincitore. Ammirando la sua bellezza e la sua gloria il nostro cuore è rapito in una meditazione profonda. Riconosciamo nel Trionfatore pasquale il Re eterno, il Creatore delle cose visibili e invisibili e diciamo con vero stupore: “Saldo è il tuo trono fin dal principio, da sempre tu sei”! Noi abbiamo contemplato la Tua debolezza e la tua umiliazione, abbiamo visto la tua lotta terribile e la tua vittoria. Chi potrebbe capire che è vero anche questo: “Saldo è il tuo trono fin dal principio, da sempre tu sei”!
Alzano i fiumi, Signore, alzano i fiumi la loro voce, alzano i fiumi il loro fragore. Ma più potente delle voci di grandi acque, più potente dei flutti del mare, potente nell’alto è il Signore. (Sal 92, 2-4) Mi ricordo di aver contemplato la bellezza e la potenza del mare in Francia, nel punto in cui la catena dei Pirenei tocca l’Atlantico. La potente onda oceanica attaccava le rocce della costa. L’acqua infuriata entrando nella caverna della rupe faceva un fragore simile all’effetto di una grande bomba. La potenza delle grandi acque, meravigliosa e pericolosa, ha sempre impressionato l’uomo. Con questa immagine d’una forza infinita alla quale non si può resistere, nello scontro con la quale l’uomo può essere squarciato tra le rocce, il Salmista vuole aiutarci alla contemplazione della potenza irresistibile di Dio trascendente: “potente nell’alto è il Signore”. La parte finale sembra non appartenere a questo Salmo; pare scendere dalle alture a un tema più vicino alla vita umana:
Degni di lode sono i Tuoi insegnamenti, la santità si addice alla Tua casa per la durata dei giorni, Signore. (Sal 92, 5) Questo Signore, che si ammanta di splendore e di forza, che è trascendente a tutte le potenze create, in cui noi riconosciamo il Creatore eterno, non è rimasto nascosto nella sua trascendenza. Ciò che è grande è che Lui ha voluto scendere per insegnare agli uomini. Esiste dunque nel mondo un insegnamento di Dio, una saggezza trascendente a tutte le scienze, a tutte le filosofie, a tutte le conoscenze degli uomini. Oh uomo, cerca questa unica dottrina del tuo Dio! È il suo Amore che ha voluto fare questa opera straordinaria di scendere sulla terra per insegnarti la sua sapienza! Pensa che hai poco tempo, che la tua vita è breve, cerca, senza perdere tempo, di riempirti di questo insegnamento. Questo è il tesoro nascosto che un uomo trovò nell’agro e vendette tutto per comprare quell’agro. Non rimanere nella tua stoltezza avendo trovato la sapienza eterna!
Pensa che i Salmi devono salvarti strappando il tuo spirito dall’ambiente spirituale del mondo e dal suo relativismo essenziale per la contemplazione dei valori assoluti del Regno di Dio. La salvezza progressiva dell’uomo si fa per mezzo di una evasione dell’uomo, operata in collaborazione colla grazia di Dio, che opera come un rapimento dell’anima umana, vivente nel soggettivo, per stabilirla nell’ oggettivo e assoluto. Come guida in questo cammino il Salmo ci conduce a fissare la nostra mente e, a poco a poco tutta la nostra spiritualità, nei valori assoluti e immobili. Questa fuga della nostra anima dalla mobilità e relatività del mondo assomiglia alla fuga di Lot che gli angeli presero per mano tirandolo fuori da Sodoma, che doveva essere distrutta perché simbolo del sistema di valori mondani effimeri (1 Cor 7, 31). L’anima cristiana quindi deve trovare sempre più il gusto delle cose eterne, perché questa vita possa realizzare la sua destinazione che è il passaggio all’eternità. Molti cristiani non capiscono che tale è il senso della loro vita, ma i monaci devono capire le parole di San Paolo (2 Cor 4, 18).
Apprezzando la dottrina di Dio diciamo: “Degni di fede sono i tuoi insegnamenti, la santità si addice alla tua casa nella durata dei giorni, Signore”. Qualcuno potrebbe dire che non si devono insegnare queste cose, troppo sublimi, all’uomo che è un essere terreno... Ma qui espressamente il Salmo contraddice tale opinione dicendo: “la santità si addice alla tua casa”. Dio ha rivelato che noi siamo la casa di Dio e la casa di Dio esige la santità, allora è chiaro che tutti i membri della casa di Dio hanno bisogno di una dottrina sublime e devono essere educati nella contemplazione delle cose invisibili che sono eterne. È un imperdonabile sbaglio educare ad una dottrina terrena e non introdurre alla collaborazione con la potenza trascendente di Dio. “La santità si addice alla tua casa” già adesso “nella durata dei giorni di questa vita mortale”.
6. Salmo 130 [28]
Questo breve Salmo appartiene ai 15 Salmi “delle ascensioni”. Sono chiamati così probabilmente perché costituivano una collezione di canti che il popolo Ebreo cantava salendo, da ogni parte, verso la Città Santa Gerusalemme e il Tempio che era costruito a 740 metri di altezza. Queste grandi processioni verso la Santa Città si facevano tre volte l’anno, cioè nelle solennità principali: Pasqua, Pentecoste e Capanne, e in quei giorni il popolo si recava all’incontro del suo Dio Jahvé con grandissima gioia cantando Salmi. Queste salite in massa del Popolo Santo verso Gerusalemme e il Tempio, per incontrare Dio, udire la Sua parola e offrirGli sacrifici, erano colme di significato. In questi solenni pellegrinaggi, in queste grandi festività piene di gioia, la fede del popolo si rinforzava insieme con la sua coesione e unità. L’Amore di Dio cresceva e la coscienza comune di costituire il suo popolo privilegiato veniva rinvigorita.
Il nostro Salmo 130, appartenendo al gruppo di Salmi delle ascensioni, partecipa a questa atmosfera di gioia di appartenere a Dio e di poterLo così visitare nella sua casa per godere con Lui. Ma questo Salmo ha un accento speciale, una profonda spiritualità che sorprende essendo nel Vecchio Testamento. Noi monaci dobbiamo amarlo in modo particolare, perché in esso troviamo espresso, in modo perfetto, l’atteggiamento monastico, alla formazione del quale tende tutta la Regola di San Benedetto. Il Santo Patriarca non manca di citarlo:
Signore, il mio cuore non ha pretese né i miei occhi mirano troppo alto.
Non mi muovo tra cose troppo grandi
o troppo magnifiche per me.
Anzi, ho placato e acquietato la mia anima
come uno svezzato dalla madre,
come un bimbo tranquillo è il mio spirito in me;
Aspetta Israele Jahvé; da ora in eterno!
Il buddismo cerca la pace nel sopprimere tutti i desideri, il credente invece la trova nella piena e amorosa sottomissione a Dio. Il buddista non può condividere la soluzione cristiana perché non crede a un Dio personale, non ha quindi a chi far dono di se stesso, non trova a chi potrebbe dare tutto se stesso con tutti i suoi desideri e tutte le sue brame. Non trovando quindi in chi potrebbe amorosamente riposarsi, cerca di annientare se stesso per fuggire l’insopportabile dolore dell’esistenza. Il cristiano invece trova la soluzione nell’umiltà e nella fiducia piena di amore in un Dio personale.
Tutta questa sapienza si trova espressa nel nostro breve Salmo. Non bisogna annientare il desiderio, ma si deve dirigere bene. E come? Prima di tutto accettare i propri limiti. È questa una grande sapienza, un’autentica sapienza che tutta la natura creata osserva e insegna. Così piante e animali hanno le proprie dimensioni oltre le quali non si estendono; le membra di un corpo pure. Se un membro cresce oltre la propria misura, non è più perfetto, non è motivo di gloria, ma piuttosto di vergogna. Un naso di due metri di lunghezza non apporterebbe gloria al suo possessore. Il desiderio di grandezza, l’illusione del più è ciò che fa errare e soffrire l’uomo, inutilmente.
Del trattamento terapeutico del desiderio parla bene il Siracide: “Non ricercare ciò che è più alto di te; non scrutare ciò che ti è nascosto. Pensa a quanto ti è stato ordinato… Quanto più sei grande, tanto più umiliati e troverai favore innanzi a Dio ed Egli viene glorificato dagli umili! (Sir 3, 18. 21-22). San Benedetto nella sua Regola, nel sesto grado di umiltà, parla della contentezza del monaco: “Omni vilitate vel extremitate contentus sit monachus” (Cap. VII). Il monaco è contento – dice il nostro Santo Legislatore – perché sente sempre di aver ricevuto fin troppo.
Ci sono due atteggiamenti spirituali che importa discernere. Possiamo immaginare due pesci contemplanti l’immensità dell’Oceano. Il primo è triste perché vorrebbe inghiottire l’oceano e non lo può fare: può soltanto ritenere poche gocce d’acqua. L’altro invece non vuole inghiottire niente, contenere niente, possedere niente, vuole soltanto immergersi e così, perdendosi, gioire di tutta l’immensità dell’ Oceano non ritenendo nulla per sé. Questo è l’atteggiamento dei contemplativi. Anche nella vita monastica-eremitica può sopravvivere un certo spirito di carriera. Ma chi vuol essere importante perde la pace e non la può ritrovare. Monaci di questo genere rovinano la pace di intere congregazioni.
L’immagine del bimbo in braccio a sua madre è molto espressiva. Il bimbo è cosciente della sua debolezza, non cerca di liberarsi, non cerca di esser indipendente, di esser importante, vuol rimanere dove si trova, è placato e tranquillo, anche se svezzato: un’immagine bellissima e ispiratrice per la vita d’un monaco consacrato al Signore.
L’umiltà è piena di luce, piena di conoscenza di se stessa e di conoscenza di Dio. Con quel che so di me stesso – dice il Salmista – c’è poco da inorgoglirsi… Le “cose grandi” le fa solo il Signore. Con quale profondità e bellezza questo spirito si trova espresso nel cantico del “Magnificat” della Madre di Dio! Solo quando, riconosciuti e accettati i propri limiti come dimensione concreta del quotidiano cammino di perfezione, l’anima si sarà abbandonata, senza riserve, all’azione del Signore, solo allora sarà Lui la sua forza e la sua nuova e vera dimensione. Il paradosso della vita spirituale si trova in questo: solamente accettando i propri limiti si possono oltrepassare e si può così godere di ciò che non ha limiti.
7. Sul Libro dei Proverbi [29]
Gli Ebrei mostrarono di possedere dati eminenti nel genere sapienziale, in quella poesia didascalica, cioè il cui oggetto è la sapienza, ricercata direttamente o divulgata attraverso massime, sentenze, consigli ecc., redatti in prosa o in versi. Il termine sapienza per gli Ebrei non comprende un concetto unico, ma può indicare la virtù con la quale gli atti umani sono rettamente indirizzati al fine (i beni del corpo e della fortuna, i costumi), e allora abbraccia tutto il complesso delle virtù morali, poiché ha per base il timor di Dio, per strumenti la disciplina e la scienza, e come aiuto la prudenza, la riflessione e il consiglio. Si deve notare però che la sapienza ebraica non trae precetti e consigli dalla legge divina positiva o legge mosaica, ma dalla ragione, cioè dalla legge naturale e specie dall’esperienza: assomiglia alla filosofia etica e ne possiede perciò il valore universale. Nella legge mosaica erano già tramandate norme importantissime di vita retta e giusta; perciò qualche volta la sapienza viene identificata e personificata nella stessa legge mosaica, che in quel caso assurge a esempio e prototipo di sapienza. Ancora più importante però è la personificazione della Sapienza di Dio: la divina Sapienza, che è la sorgente di ogni saggezza e che risplende mirabilmente nelle opere della creazione, è presentata dagli autori sacri come persona che sta a sé e agisce indipendentemente da Dio.
Tutti gli esseri che Dio ha creato sono incarnazioni ed espressioni del suo pensiero e della sua volontà. In tutto l’universo si trova un ordine obiettivo e un senso, segno indubbio della Sapienza di Dio dalla quale tutto proviene. Tutto questo meraviglioso ordine dell’universo creato è una Parola di Dio all’uomo, una trasmissione del pensiero del Dio, dell’Amore che vuole condurre l’uomo e formarlo secondo la sua Sapienza eterna. Si può dire che già nell’ordine della natura l’uomo sarebbe condotto a una certa unione con il suo Creatore, poiché il suo compito sarebbe di inserirsi il più perfettamente possibile nell’ordine divino della creazione.
Gli esseri privi di intelligenza lo fanno, immancabilmente e perfettamente, ma l’uomo dovrebbe farlo con consapevolezza e libera volontà. I precetti della legge naturale sono dunque luoghi di incontro e mezzi di unione dell’uomo colla Sapienza di Dio Creatrice, cioè con Dio stesso. La sapienza dell’uomo è quindi una partecipazione della Sapienza creatrice di Dio, essa rende l’uomo capace di seguire le vie misteriose della Sapienza di Dio nel mondo e di sottomettere così alla Sapienza di Dio la propria condotta morale. Non si può dunque separare la santità e la giustizia dalla sapienza. Tutte e tre esprimono una sottomissione amorosa dell’uomo all’ordine divino dell’universo e una partecipazione dell’uomo all’operazione della Sapienza di Dio nel mondo.
Prima che si rivelasse il Figlio di Dio Incarnato come unica Sapienza, e prima che l’Universo fosse rapito nel turbine della vita Trinitaria, questa dottrina della Sapienza esprimeva bene il senso naturale e soprannaturale della vita e condotta umana. Tutto il Libro dei Proverbi costituisce una esortazione a vivere bene secondo i principi della sapienza per essere felice! Per primo ci colpisce il tono dell’esortazione divina, dove la grande serietà si mischia a una bontà e tenerezza paterna:
Figlio mio, non dimenticare le mie istruzioni/ e la tua mente conservi i miei precetti /poiché giorni lunghi, anni di vita/ e pace ti porteranno.
Bontà e fedeltà non ti abbandonino mai:/ legale al tuo collo,/ iscrivile sulla tavola del tuo cuore,/ così incontrerai favore e stima/ agli occhi di Dio e degli uomini (Pr 3, 1-4).
Gli ammonimenti di Dio sono pieni di una tenera carità, come un padre che ammonisce il suo figlio. Non c’è più nessuna aggressività, né amarezza, né irrequietezza, ma un desiderio ardente e pacifico di trasmettere il tesoro della sapienza e dell’esperienza paterna in un cuore giovane minacciato di leggerezza e di spensieratezza, esposto a numerosi errori, allo scopo di renderlo più forte e più sicuro nella via del Signore! Tutto qui respira la pace della verità tranquillamente posseduta, la pace che viene dall’inserimento nell’ordine obiettivo e assoluto di Dio e dell’universo, realtà indipendente da tutto ciò che può accadere. Ciò che è, è, ed è come è indipendentemente da tutto ciò che fanno e che vogliono gli uomini, indipendentemente da tutte le passioni che agitano questo mondo. La vera educazione è quella che radica lo spirito dell’uomo nell’ordine divino universale, nella verità che è insieme tenerezza e pace immensa.
Gli ammonimenti del Libro dei Proverbi possono essere considerati come modelli dell’ammonizione cristiana. Il loro clima di bontà e di pace sana le ferite dell’anima come un olio spirituale. Niente di aggressivo, niente di impaziente. Il maestro che ammonisce non lo fa solamente per compiere un dovere, ma lo fa per amore e con gran desiderio del bene del figlio a cui si rivolge. Non vuole soltanto farlo obbediente, ma sapiente e maturo. L’ammonimento è dunque una trasmissione di sapienza. Tutto ciò che Dio esige e comanda all’uomo è per il bene dell’uomo e per la sua felicità. Il gran desiderio del bene dell’uomo è la caratteristica della pedagogia divina nella Sacra Scrittura. Dio desidera che l’uomo con una piena consapevolezza e libertà scelga la via della sapienza. All’ordine che prende piuttosto la forma di un consiglio è giunta una promessa di un bene e della felicità, alla quale conduce la sottomissione a quell’ordine:
Figlio mio, confida in Jahvé con tutto il cuore/e non appoggiarti alla tua intelligenza./ In tutti i tuoi sentieri pensa a Lui/ ed Egli appianerà il tuo cammino./ Non essere saggio ai tuoi occhi,/ temi Jahvé e fuggi il male:/ sarà salute per il tuo corpo/ e ristoro per le tue ossa/. Onora Jahvé con i tuoi beni,/ con le primizie dei tuoi prodotti;/ allora i tuoi granai saranno ricolmi di grano/ e i tuoi tini traboccheranno di mosto./ Non disprezzare la disciplina di Jahvé figlio mio/ e non ti ripugni la sua repressione,/ perché Jahvé corregge chi ama/ e castiga il figlio più caro (Pr 3, 5-12).
Vi è una grandissima varietà di sentenze e di pensieri in questo Libro dei Proverbi. Ma ci sono due atteggiamenti principali, ai quali si riduce tutto, nel comportamento morale dell’uomo: la sapienza e la stoltezza. L’atteggiamento primo è essenzialmente religioso: riconosce Dio come Creatore, come assoluto Signore e anche come sorgente di ogni bene. L’atteggiamento secondo è essenzialmente irreligioso. Non vuol sapere niente di Dio e segue gli impulsi della sua natura corrotta. Come la benedizione della sapienza è di tutti i tempi, così è anche la tragedia della stoltezza dell’uomo. La stoltezza dei nostri tempi è specialmente pericolosa perché è non soltanto irreligiosa, ma pensa di aver trovato nella stessa sua irreligiosità una sapienza superiore.
Prendiamo adesso alcuni versetti del nostro Libro per ammirare la ricchezza e la varietà dell’insegnamento: In ogni luogo sono gli occhi di Jahvé e vedono i cattivi e i buoni (Pr 15, 3). Ecco la Sorgente della saggezza – “gli occhi di Jahvé”. Non basta controllare se stesso e vegliare sulla propria anima per essere sapiente. Se questa custodia dell’anima non sarà un confronto con Colui che è e che vede, non ci aiuterà a vincere la nostra debolezza e stoltezza. Sapiente si può essere soltanto vivendo in confronto con Dio. La tragedia dello stolto è nella carenza di questo confronto.
Una risposta calma acquieta l’ira,/ ma una parola pungente eccita la collera (Pr 15, 1). La parola calma è un frutto della sapienza e insieme la condizione. La parola calma ha una doppia azione sanante. Essa sana o conserva la salute di colui che parla, e sana colui a cui è indirizzata come un vero dono. Invece la parola pungente produce una doppia ferita. Vediamo qui che l’uomo sana gli altri sanando se stesso (una verità importante). Ci si deve quindi adoperare per calmare il nostro proprio interno, dominare le nostre proprie passioni, frenare i loro scatti esterni per arrivare alla parola calma e sanante. Nella nostra povera natura ammalata c’è molto veleno. Se non controlliamo le nostre reazioni spontanee, possiamo invelenire l’ambiente come un camino e ferire noi stessi e gli altri. Le reazioni spontanee non controllate sono caratteristiche della stoltezza. Il Libro dei Proverbi è poco utile per chi volesse leggerlo come altri libri “in lectione continua”. Ma scrutando un po’ le singole scritture, si può trovare una dottrina spirituale profonda e abbondante.
8. Lettera ai Filippesi [30]
Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù a tutti i Santi in Cristo Gesù che sono a Filippi con i vescovi e i diaconi. Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo (Fil 1, 1-2).
L’Apostolo Paolo è l’autore della lettera – associa il suo discepolo fedele Timoteo – non ha l’autorità dell’Apostolo – carattere fraterno della Chiesa – servi di Gesù Cristo – tutti sono servi (schiavi, doulej) di Gesù Cristo (cf. 2 Cor ) – 2 Pt: Servo e Apostolo – Giacomo – tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi. Santo dice più che cristiani. Il nome cristiano viene dai pagani di Antiochia che non conoscevano l’essenza del cristianesimo (partigiani di Cristo). I cristiani hanno conservato questo nome per amore del Cristo, dando un senso più profondo alla parola (unione con Cristo, pienezza) – Santi è più profondo = quelli che appartengono alla Santità di Dio, che sono dentro della sfera di Dio, che hanno ricevuto lo Spirito Santo. Fuori della sfera della santità c’è il mondo profano. Non si usa più questo nome per designare i cristiani (è peccato).
Con vescovi e diaconi evpiskopoi e presbu,teroi = superiori di chiese, terminologia ancora non stabilita definitivamente. Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. L’augurio buono precede ogni conversazione (così si dice in Colombia) – è umano e cristiano – la grazia di Dio e la pace (Cristo risorto). Augurio e dono? I cristiani possono comunicarsi a vicenda i beni che vengono da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo.
Ringrazio il mio Dio ogni volta ch’io mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi in ogni mia preghiera (Fil 1, 3-4).
Gioia e ringraziamento, saper gioire degli altri – coscienza della grazia.
a motivo della vostra cooperazione alla diffusione del Vangelo dal primo giorno fino al presente (Fil 1, 5).
La cooperazione alla diffusione del Vangelo è compito di ogni cristiano, immediatamente, quindi ogni cristiano è capace di maniera sua.
e sono persuaso che colui che ha iniziato in voi quest’opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù (Fil 1, 6).
Occhi aperti per vedere il bene di Dio, l’azione di Dio nelle persone – Dio ha iniziato, Dio porterà a compimento – nostra tristezza, pessimismo, scoraggiamento perché siamo pelagiani – giudicando gli altri – il giorno di Cristo Gesù.
È giusto, dal resto, che io pensi questo di tutti voi, perché vi porto nel cuore, voi che siete tutti partecipi della grazia che mi è stata concessa, sia nelle catene, sia nella difesa e nel consolidamento del vangelo. Infatti Dio mi è testimonio del profondo affetto che ho per tutti voi nell’amore di Cristo Gesù. (Fil 1, 7-8)
Questo passo è meraviglioso – la trasformazione interiore di S. Paolo – la potenza dell’amore – affetto trasformato nell’amore di Cristo Gesù – partecipi nella grazia (doppia)
E perciò prego che la vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni genere di discernimento perché possiate distinguere sempre il meglio ed essere integri ed irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quei frutti di giustizia che si ottengono per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio (Fil 1, 9-11).
Importanza della conoscenza di Dio. Ignoranza di Dio anche tra cristiani, tra religiosi e contemplativi (vergogna). Da questa conoscenza di Dio scrive ai Colossesi: “Non cessiamo di pregare per voi, e di chiedere che abbiate una conoscenza piena della sua volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore per piacergli in tutto” (Col 1, 9-10).
Di che conoscenza si tratta? 1. Arricchimento della carità; 2. Ogni genere di discernimento (a’’i[sqhsij) ed esperienza; 3. Volontà di Dio, il più perfetto. Relazione amore-conoscenza e la loro collaborazione. Tutto in preparazione per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia (per mezzo di Cristo). Tutto finalmente a gloria e lode di Dio.
Desidero che sappiate, fratelli, che le mie vicende si sono volte piuttosto a vantaggio del vangelo, al punto che in tutto il pretorio e dovunque si sa che sono in catene per Cristo (Fil 1, 12-13) [31].
Qui si deve dire qualche cose sulla prigionia di S. Paolo. Fino a pochi anni fa si pensava che S. Paolo avesse scritto questa lettera dalla prigione romana come le lettere agli Efesini, ai Colossesi e a Filemone. Oggi gli scienziati ammettono un’incarcerazione dell’Apostolo per breve tempo a Efeso durante il suo soggiorno in questa città negli anni 54 – 57. Fino a poco tempo fa si parlava anche solo di incarcerazione di S. Paolo a Cesarea (58 – 60), poi a Roma due volte, la prima volta per tre anni (60-63). L’Apostolo fu liberato nel 63 perché innocente. La sua prima detenzione a Roma non fu molto severa e non gli impedì i contatti apostolici. Liberato nel 63 compì alcuni viaggi dei quali sappiamo poco. Forse andò in Spagna come aveva progettato? La seconda volta fu imprigionato a Roma nel 67 e questo fu molto più grave. Nello stesso anno probabilmente morì martire di Cristo. Oggi si pensa che solo Efesini e Colossesi furono scritte nel carcere di Roma (durante la prima incarcerazione); invece Fiippesil e Filemone furono mandate dalla prigione di Efeso.
Può sembrare che questa teoria contraddica l’affermazione di S. Paolo nel v. 13: “al punto che in tutto il pretorio si sa che sono in catene per Cristo”. La presenza del pretorio sembra indicare Roma. La Bibbia di Gerusalemme dà il commento seguente: “Se S. Paolo scrive da Roma, si tratta della guardia pretoriana che si accampava presso le mura dell’Urbe. Se invece scrive da Efeso, bisogna allora pensare al personale del pretorio, e alla Residenza del governatore che si trovava in questa città”. Dunque non è necessario pensare a Roma e ci sono altri argomenti seri che fanno pensare piuttosto a Efeso.
L’Apostolo vuole che i fratelli di Filippi sappiano che la sua incarcerazione non ha cattivato la Parola di Dio e che, per l’azione provvidenziale di Dio, tutti gli impedimenti possono cambiarsi in mezzi, una fede indispensabile ai cristiani. Il cristiano ha una relazione speciale con l’impedimento quando si tratta dello sviluppo del vero bene. Ma ciò che l’Apostolo ci dice sull’atteggiamento di alcuni fratelli e le loro reazioni ha qualche cosa di strano. Questi versetti, come molti altri del NT, non ci permettono di idealizzare i primi cristiani. Certo molti erano pieni di fervore, ma i vizi delle natura umana caduta erano pure svegli e attivi. Vediamo ciò che ne scrive S. Paolo:
in tal modo la maggior parte dei fratelli, incoraggiati nel Signore dalle mie catene, ardiscono annunziare la Parola di Dio con maggior zelo e senza timore alcuno. Alcuni, è vero, predicano Cristo anche per invidia e spirito di contesa, ma altri con buoni sentimenti. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono stato posto per la difesa del vangelo. Quelli invece predicano Cristo con spirito di rivalità, con intenzioni non pure, pensando di aggiungere dolore alle mie catene (Fil 1, 14-17).
Un tratto positivo di questi giovani cristiani è che non sono stati scoraggiati dalle catene dell’Apostolo, ma al contrario, essi vi hanno trovato una sorgente di coraggio. La reazione ordinaria degli uomini è spesso contraria: quando è colpito il capo, tutti si rifugiano in una passività. Essi invece hanno mostrato l’amore di Dio e l’amore di Paolo.
Ma c’erano altri che agivano per invidia, spirito di contesa e rivalità, pensando di aggiungere dolore all’Apostolo perché lui non poteva predicare. Erano invidiosi perché non potevano uguagliarlo nella predicazione e pensavano di farlo soffrire suscitando in lui invidia. Invidia è il più diabolico dei vizi umani. L’invidia del diavolo ci ha fatto perdere il Paradiso. L’invidia è sorgente dell’odio.
La gelosia è più umana. Il geloso vorrebbe possedere il bene altrui, l’invidioso invece vorrebbe distruggere il bene e il suo possessore. L’invidia di Caino ha introdotto il primo omicidio nel mondo. Se Caino fosse stato solo geloso, avrebbe forse cercato di imitare il fratello per uguagliarsi a lui… Ma l’invidia non vuole imitare, vuole sopprimere il migliore assieme al suo bene. L’invidia dei fratelli di Giuseppe ha ispirato la sua vendita in Egitto, l’invidia di Saul ha generato il suo odio implacabile contro Davide…
I movimenti dell’invidia che possono essere presenti anche nelle anime avanzate nella vita spirituale, mostrano la profondità della nostra ferita spirituale, rivelano l’abisso del male che resta ancora nell’anima che Dio solo può salvare. L’invidia non sopporta la superiorità altrui, la perseguita, la vuole distruggere. Essa perseguita il bene divino negli uomini; ucciderebbe Dio, se potesse. L’invidia ha aspettato migliaia di anni che Dio si facesse mortale per ucciderlo (Mt 27). La parabola sugli operai nella vigna mette in risalto l’invidia. Il proprietario della vigna non ha fatto torto a nessuno. Tutti hanno ricevuto il salario convenuto, ma erano scontenti e mormoravano non perché avevano ricevuto troppo poco, ma perché gli ultimi avevano ricevuto una ricompensa uguale alle loro; non volevano ricevere di più, ma che gli altri ricevessero di meno. Ecco l’invida che il proprietario della vigna smaschera con queste parole: “Perché guardi con male occhio che io sono buono?” (Mt 20, 15). Per questo la nostra lotta contro l’invidia deve essere una “guerra totale”. Non possiamo permetterci un solo sentimento macchiato da questo vizio orribile. Non solo sopportare ma amare la superiorità altrui è un segno di carità molto generosa (S. Giovanni della Croce?).
La situazione umana di Paolo è un po’ complicata, ma lo spirito di Paolo, reso semplice per l’amore di Cristo, è l’assoluta fiducia in Dio. Non si ferma a tutte queste complicazioni degli uomini, ma con un colpo d’ala le trascende tutte e raggiunge la pura luce di Dio.
Ma questo che importa? Purché, in ogni maniera, per ipocrisia o per sincerità, Cristo venga annunziato, io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene. So infatti che tutto questo servirà alla mia salvezza grazie alla vostra preghiera e all’aiuto dello Spirito di Gesù Cristo. Secondo la mia ardente attesa e speranza che in nulla rimarrò confuso; anzi nella piena fiducia che, come sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia che io muoia (Fil 1, 18-20).
Le cose umane non lo interessano più. Come ha scritto ai Romani, “noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio” (Rm 8, 28). Adesso vive intensamente questa verità: “So infatti che tutto questo servirà alla mia salvezza grazie alla vostra preghiera e all’aiuto dello Spirito di Gesù Cristo”. Egli è cosciente che sia la preghiera dei cristiani che lo stesso Spirito di Cristo contribuiscono a questo unico, che lui stesso desidera con tutte le sue forze: “Secondo la mia ardente attesa e speranza che in nulla rimarrò confuso; anzi nella piena fiducia che, come sempre, anche ora, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia”. Parla molto della purezza del cuore. Ma quando si ha la purezza del cuore? Vediamo. Se l’unica e ardente attesa dell’anima è che Cristo sia glorificato nel corpo, sia che viva sia che muoia, possiamo dire che si ha una perfetta purezza del cuore. Nulla si può opporre a un cristiano così. Egli realizza invincibilmente ciò che vuole, malgrado tutti gli impedimenti che diventano mezzi, perché ciò che vuole è la gloria di Cristo.
Il versetto 21 spiega questa forza invincibile: Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa debbo scegliere. Sono messo alle strette infatti tra queste due cose: da una parte il desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; d’altra parte è più necessario per voi che io rimanga nella carne. Per conto mio, sono convinto che resterò e continuerò a essere d’aiuto a voi tutti, per il progresso e la gioia della vostra fede, perché il vostro vanto nei miei riguardi cresca sempre più in Cristo, con la mia nuova venuta tra voi (Fil 1, 21-26).
Per me il vivere è Cristo [32]. Questa formula breve e forte esprime la perfezione e la pienezza della vita cristiana. Non è solo imitazione di Cristo. L’imitazione suppone che ci siano due figure, suppone una certa distanza tra il modello e colui che lo imita. Sì, è vero, nell’imitazione gli occhi sono sempre rivolti verso il modello. Ma per San Paolo la distanza è ancora troppo grande. Egli vuole vivere il Cristo stesso, vivere in unione perfetta con Lui, sparire in Lui. Egli cerca la mistica identificazione con Cristo, perché l’ideale cristiano si trova a questo livello, come vedremo nel capitolo terzo. Questo è già perfezione.
È notevole come la Chiesa conduca i suoi figli a questa perfezione. La Liturgia della Chiesa, che ci educa a vivere cristianamente, mostra in sé come una ossessione di Cristo. Che cosa ci insegna la Chiesa nella sua Liturgia se non questa ossessione di Cristo? Di Lui parla l’Avvento, di Lui il Tempo di Natale, di Lui il Tempo Pasquale. Che cosa è la Quaresima se non la nostra partecipazione alla Sua Croce e l’attesa della sua Risurrezione? Anche il Tempo Ordinario è pieno di Cristo. Ogni giorno si celebra la Santa Messa per unirci con Lui e in Lui, per morire con Lui e per vivere con Lui, fin da ora, nella partecipazione alla Sua gloria eterna. Troviamo Gesù Cristo nei salmi e nelle letture del Vecchio Testamento. I Padri ne parlano, qualunque sia il tema dei loro discorsi. L’Amore li fa riferire sempre a Cristo, come se non potessero parlare di altra cosa. La formazione di questa mentalità costituisce l’autentica formazione del cristiano.
Nei salmi – malgrado i commentari dei biblisti scienziati – l’amore della Chiesa trova sempre il suo Cristo. Ecco ciò che leggiamo in un giorno feriale del Tempo Ordinario. Si tratta del commentario di Sant’Ambrogio sul Salmo 1: “Bevi dunque il calice di cui il profeta “disse: Il Tuo calice inebriante, quanto è buono!” Bevi l’uno e l’altro calice, quello dell’Antico e quello del Nuovo Testamento, perché in ambedue bevi Cristo. Bevi Cristo che è la Vita, bevi Cristo che è la pietra da cui scaturì l’acqua. Bevi Cristo che è la fonte della vita; bevi Cristo perché Egli è il fiume che allieta la Città di Dio; bevi Cristo che è la pace; bevi Cristo perché fiumi di acqua viva spargeranno dal tuo seno. Bevi Cristo per dissetarti col sangue da cui sei stato redento, bevi la sua Parola; sua Parola è l’Antico e il Nuovo Testamento. Si beve la Sacra Scrittura, anzi la si divora, quando fluisce nell’anima e le dà vigore la linfa del Verbo eterno”. In questo spirito, in questa santa ossessione di Cristo la Chiesa vuole formarci. È necessario deporre lo spirito mondano per poter ricevere questa formazione, questa ossessione di Cristo che, arrivando alla sua maturità, dice in San Paolo: “Per me vivere è Cristo”. È giusto quindi insistere sulla pedagogia liturgica della Chiesa che, per coloro che la seguono, è molto efficace per sviluppare questa visione e questo amore di Cristo che trasforma il cuore. Ma seguiamo il testo di S. Paolo.
Per me il vivere è Cristo, e il morire un guadagno (Fil 1, 21)
Come non sarebbe un guadagno il morire per chi vive così? Per l’Apostolo la morte significa l’unione perfetta con Cristo, nella visione. San Paolo pensa alla vita eterna con Cristo: per lui seguirà immediatamente dopo la morte. Quelli per i quali, ancor vivendo in questo mondo, Cristo è veramente la vita, non necessitano di una ulteriore purificazione dopo la morte: essi sono già maturi per la perfetta unione con Cristo. La morte per loro è quindi un guadagno.
Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa debbo scegliere. Sono messo alle strette infatti tra queste due cose: da una parte il desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; d’altra parte è più necessario per voi che io rimanga nella carne. Per conto mio, sono convinto, che resterò e continuerò ad essere d’aiuto a voi tutti, per il progresso e la gioia della vostra fede, perché il vostro vanto nei miei riguardi cresca sempre più in Cristo, con la mia nuova venuta tra voi (Fil 1, 22-26).
Che pensare di questo? È lecito all’uomo rinunciare alla propria salvezza per i fratelli? No. Questo non si può fare. Nessun essere può rinunciare al fine ultimo per cui è stato creato, sarebbe un disordine essenziale che Dio non può volere. La vita eterna con Dio è per ciascuno di noi la volontà di Dio indiscutibile. Il fine dell’uomo, stabilito da Dio, è la visione di Dio stesso per tutta l’eternità, come dice San Giovanni: “Noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremmo così come Egli è” (1 Gv 3, 2). L’uomo non può rinunciare, nemmeno per carità, a ciò che è l’eterna e immutabile volontà di Dio per lui. Come dunque possiamo capire ciò che San Paolo scrive ai Romani (9, 2), che sarebbe pronto a rinunciare perfino alla sua salvezza per il suo popolo Israele? “Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne?” (Rm 9, 3). In queste parole egli esprime il suo grande amore per il suo popolo e la sua profonda tristezza a causa della infedeltà degli Israeliti. Però non dice “voglio”, ma dice “vorrei” in condizionale, che si interpreta: “se fosse possibile questo, se fosse conforme alla volontà di Dio”. Nella nostra epistola San Paolo non rinuncia alla sua salvezza, ma, per il bene dei suoi fratelli, rinuncia a godere immediatamente della perfetta unione con Cristo. Questo è accettabile.
Però la nostra situazione è diversa da quella dell’Apostolo. Noi non abbiamo nessuna certezza della nostra salvezza. È un bene pensare a questo. Nella stessa Lettera ai Filippesi, San Paolo, che parlava della sua salvezza come di una cosa certa, ci esorta dicendo: Attendete alla vostra salvezza con timore e tremore (2, 12). Occorre avere una visione realistica di queste cose. Questo è oggi tanto più importante, poiché i cristiani moderni non sentono più la serietà di questi problemi. È spaventoso constatare con quale facilità e leggerezza i cristiani promettano oggi la vita eterna a coloro a cui Dio non la promette, ma al contrario, li minaccia di dannazione. È cosa caratteristica che quanto più negligente è l’uomo, quanto più disprezza i comandamenti di Dio, tanto più facilmente si promette la salvezza. “Perché Dio è Amore Misericordioso e non può rigettare nessuno, anzi sarebbe una sconfitta dell’amore di Dio, se un solo uomo si perdesse”. Questa “doctrina daemoniorum” si è fatta oggi quasi universale tra i cattolici. Però un altro fatto deve far pensare: i cristiani veramente santi hanno il timore di Dio e non pensano così. I santi pensano all’inferno con grande serietà. Essi che conoscono la Misericordia di Dio molto meglio degli altri (come per esempio la Beata Sr. Faustina, Apostola della Misericordia Divina) credono che il peccato grave meriti la pena eterna, come insegna la Scrittura e la Chiesa. Così ha parlato anche la Santissima Vergine nelle rivelazioni di Fatima.
Tutti quelli che hanno della Misericordia di Dio una conoscenza più profonda temono la pena dell’inferno per gli uomini. E chi ha conosciuto la Misericordia divina (che è un Mistero) meglio di Cristo che, molto chiaramente e più volte, parla dell’inferno? Ma noi, cristiani di oggi, sappiamo meglio di tutti questi e di Cristo stesso. Noi sappiamo che la perdita di un solo uomo sarebbe una sconfitta dell’Amore di Dio, e questo non si può pensare. Perché non si può pensare? L’Onnipotenza non può avere sconfitte, ma l’Amore sì. Egli non entra per forza, ma bussa alla porta. Dio non vuole salvarci senza la nostra volontà e la sua collaborazione. Egli non vuole trattare l’uomo come un pacco che si spedisce con indirizzo “cielo”. L’Amore può avere delle sconfitte perché è infinitamente delicato, non rassomiglia in niente ad una forza brutale. Si dimentica che gli angeli caduti erano anche oggetto dell’amore di Dio e di una sublime vocazione e caddero nell’abisso dell’odio perché lo vollero e la loro dannazione è dogma di fede. Viviamo dentro il Mistero di Dio che non comprendiamo, è dunque pericoloso prometterci ciò che Dio non ci promette.
Quando muore un cristiano non dobbiamo dire (come si sente spesso) che sta già in cielo. Preghiamo per la sua anima. Penso che S. Francesco di Sales disse una volta: “Quando morirò, non fatemi troppo presto Santo, perché mi lascerete troppo tempo in Purgatorio”. Che la nostra teologia sia seria, sia quella della S. Scrittura e della Chiesa, e non sia come quella del mondo che con una leggerezza spaventosa vuole sostituire la sapienza di Dio. Abbiamo questo atteggiamento nei nostri contatti coi secolari. Oggi, in un mondo più peccatore che mai, neppure i predicatori osano parlare della morte eterna che è il frutto naturale del peccato (Rm 6, 23). S. Paolo consente di fare un gran sacrificio per i suoi fratelli, ma spera che anche essi vorranno fare un grande sforzo per andare avanti:
Soltanto però comportatevi da cittadini degni del Vangelo perché nel caso che io venga e vi veda o che da lontano senta parlare di voi, sappia che state saldi in un solo spirito, che combattete unanimi per la fede del vangelo, senza lasciarvi intimidire in nulla dagli avversari. Questo è per loro un presagio di perdizione, per voi invece di salvezza, e ciò da parte di Dio: perché a voi è stata concessa la grazia non solo di credere in Cristo, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo la stessa lotta che mi avete veduto sostenere, e che ora sentite che io sostengo (Fil 1, 27-30).
S. Paolo esorta i cristiani a comportarsi come cittadini degni del Vangelo. “Cittadini” – il cristiano è cittadino del Regno di Dio, nel quale vige la legge del Vangelo. Una tale esortazione non ha niente di speciale, si può dire che sia ovvia. Che cosa infatti dovrebbero fare i cristiani se non vivere secondo il Vangelo? Purtroppo questa cosa, in sé evidente, non è evidente oggi. Quale parroco di oggi inculca ai suoi parrocchiani l’obbligo di vivere secondo il Vangelo, cioè di cercare la perfezione evangelica? La situazione sta forse già migliorando, perché lo Spirito Santo fa scaturire oggi non poche sorgenti di acqua cristallina (vita evangelica) nel deserto di questo mondo. Ma ancora adesso un cristiano che seriamente vuole essere fedele al Vangelo è considerato come un cristiano eccezionale. Cristo non è il maestro della maggioranza dei cristiani. C’è differenza tra un uomo buono, fedele ai principi morali e ai suoi doveri, e un cristiano che, in tutto ciò che fa, cerca l’ispirazione nel Vangelo.
Saldi in un solo Spirito (Fil 1, 27)
È certo una esigenza grave per giovani cristiani recentemente convertiti. Ma Paolo non sembra prendere questo in considerazione, non prevede tappe nelle esigenze cristiane. Si deve prendere il dono della vita cristiana nella sua integrità. Sembra che per S. Paolo la vita cristiana sia una realtà indivisibile, da accettare interamente: tutto o niente. Abbiamo perduto questa visione totalitaria del cristianesimo, la visione del puro Vangelo senza miscugli con altre ispirazioni (nostro astrazionismo). Quando si vede il cristianesimo come una “realtà viva” (per me vivere è Cristo), si capisce l’impossibilità dei compromessi, si deve ammettere che non c’è cristianesimo vivo senza questa esigenza: Saldi in uno Spirito.
che combattete unanimi per la fede del Vangelo (Fil 1, 27)
Abbiamo perduto e l’unanimità e la combattività per la fede del Vangelo. Oggi si desidera che tutto sia fiacco, altrimenti si è accusati di intolleranza. Si deve lasciare che ciascuno pensi ciò che vuole. Più pericolosa delle false dottrine è questa fiacchezza generale. Allora niente è importante, niente è assoluto. Tutto è relativo e il valore supremo non è la verità ma la tolleranza. Lo spirito moderno è contrario a ogni lotta (abisso di neutralità). Non si può colpire perché tutto è morbido. Non c’è niente di duro. Per la lotta é invece essenziale.
********************************************************************************************************************************
Piccola Sorella Magdeleine Hutin e Padre Pietro Rostworowski
Storia di un’amicizia
Piccola Sorella Magdeleine Hutin (1898-1989) e Padre Pietro Rostworowski (1910-1999) si incontrarono per la prima volta nell’estate del 1957 e col tempo crebbe tra loro una vera e profonda amicizia che durò oltre 32 anni. Questa storia è bella, affascinante e ormai è ricchezza della chiesa e della sua spiritualità del ventesimo secolo; testimonia una comunione profonda nella ricerca di Dio e dell’ascolto della sua Voce. La storia si potrebbe imperniare più sulla persona di Piccola Sorella Magdeleine – in tal caso Padre Pietro apparirebbe come uno dei tanti, tantissimi “piccoli e grandi” nel cosmo delle relazioni di questa donna straordinaria. Ma in questo saggio l’accento viene spostato più su Padre Pietro e la storia qui raccontata segue i suoi passi, anche se, paradossalmente, tutte (o quasi tutte) le informazioni su quest’amicizia provengono da Piccola Sorella Magdeleine (dai suoi diari e dalle sue lettere) e Padre Pietro è sì presente ma piuttosto tace[33]. Tutto è stato descritto da Piccola Sorella, è lei che ci racconta di Padre Pietro e lui emerge nel raggio dello sguardo di questa donna. Ma d’altra parte, essendo l’amicizia una relazione, in questa storia emergono ambedue e, in mezzo a loro, c’è l’Amico degli uomini e il Salvatore del genere umano.
I primi contatti
Piccola Sorella Magdeleine era più anziana di Padre Pietro di dodici anni e quando si incontrarono nel 1957, lei aveva 59 e lui 47 anni. In quegli anni Sorella Magdeleine fondava un nuovo ordine, che seguendo le intuizioni di Charles de Foucauld, godeva già di un certo riconoscimento e si sviluppava in modo assai dinamico. Ella nel tempo, come fondatrice seminava e visitava le sue nuove comunità in diversi continenti – superando anche la “cortina di ferro” che in quei tempi divideva l’Europa. Nel 1956 il Vicariato ha consentito la fondazione della “casa generalizia” sui terreni dell’abbazia dei trappisti di Tre Fontane. Padre Pietro invece aveva alle spalle oltre un quarto di secolo di vita monastica, di stampo benedettino, vissuta in Belgio (il monastero di San Andrea a Brugge), a Roma (Sant’Anselmo) e in Polonia (il monastero di SS. Pietro e Paulo a Tyniec vicino a Cracovia) di cui in quegli anni svolgeva tra l’altro la funzione di superiore.
Nel 1956 la politica e la vita in Polonia, fino ad allora dominata da un forte terrore stalinista, si cambiò avviando alcune aperture e riforme. Fu pertanto possibile, anche ad un ecclesiastico come Padre Pietro Rostworowski, ottenere i permessi necessari per recarsi a Roma passando per il Belgio, dove si trovava la “casa madre” del suo monastero polacco. Il suo viaggio durò dal 24 aprile al 27 luglio del 1957. Fu così che il 20 giugno 1957 apparve a Tre Fontane. Era il giorno in cui Piccola Sorella Magdeleine presentava di fronte a diverse persone della chiesa di Roma il suo nuovo progetto delle così dette “sorelle trubadure”. Non si sa perché e come Padre Pietro fosse arrivato proprio in quel giorno e per quella occasione a Tre Fontane. Forse voleva incontrarsi con l’allora Abate Generale dei Trappisti Dom Sortais che era presente? Forse cercava di vedere qualcun altro? O desiderava vedere e incontrare la comunità delle Piccole Sorelle e la sua fondatrice di cui sicuramente aveva sentito parlare? Oggi non siamo in grado di fornire una risposta a queste domande. Sappiamo solo che questo monaco apparve a Tre Fontane proprio in quel momento seminando pure un certo sconcerto (alcuni pensarono che fosse una “spia comunista” perché nonostante i cambiamenti avvenuti nell’est europeo, in Occidente si riteneva quasi impossibile attraversare “legalmente” la cortina di ferro e arrivare semplicemente a Roma). Non sappiamo nemmeno di che cosa avessero parlato Piccola Sorella Magdeleine e Padre Pietro. Di vita religiosa tradizionale e di quella nuova di cui la chiesa e il mondo avevano bisogno? Della situazione politica e della chiesa nell’est europeo?
L’unica cosa che abbiamo a disposizione è la foto in cui, di fronte agli edifici della comunità delle Piccole Sorelle a Tre Fontane, tra altre presenze ci sono proprio Piccola Sorella Magdeleine e Padre Pietro che conversano insieme. Lui nell’abito benedettino, con la testa leggermente inchinata getta lo sguardo in basso e lei che, appoggiata alla colonna del tetto, apertamente fissa il suo volto. Accanto a loro, forse partecipe del dialogo sta qualche sacerdote e ancora, vicino, un vescovo che guarda un cane tenuto da un altro prete. Tutto qua. Né Sorella Magdeleine né Padre Pietro in quel momento avrebbero potuto prevedere che quell’ incontro sarebbe stato l’inizio di una lunga e bella amicizia spirituale che sarebbe durata oltre 30 anni facendoli incontrare più di trenta volte in diverse occasioni e luoghi del mondo.
Due anni più tardi Piccola Sorella Magdeleine è di nuovo nell’est europeo per visitare le sue comunità e per prendere contatto con diverse persone della chiesa. Il 4 luglio del 1959 si incontra a Cracovia con il vescovo Karol Wojtyła e il filosofo di Varsavia Stefan Swieżawski. Cinque giorni dopo (9 luglio 1959), indirizzandosi ormai verso la Germania dell’Est, la troviamo ancora a Silesia nella città di Wałbrzych, dove si incontra con il vescovo Kominek di Wrocław e con Padre Tadeo Fedorowicz di Laski (vicino Varsavia). A questo incontro partecipa Padre Pietro e la Piccola Sorella annota nel suo diario (5 luglio 1959) la presenza de: “l’anziano priore dei benedettini di Tyniec”. Non si sa perché Padre Pietro sia stato chiamato “anziano” (aveva solo 50 anni) – forse perché appariva come un “anziano” o perché questa era ormai una “vecchia” conoscenza? Nei diari di Sorella Magdeleine non si trova niente di più riguardo a Padre Pietro. Il clima di questi incontri è segnato da clandestinità –persone che si ritrovano spostandosi in luoghi diversi, forse per sfuggire agli occhi della polizia (sono i tempi del comunismo in cui la vita ecclesiale è sempre ostacolata e le fondazioni di nuove comunità religiose sono vietate). Il nome di Padre Pietro è solo scrupolosamente segnato nel diario. Si può pure pensare che in questo periodo, considerando anche la presenza di altre personalità della chiesa polacca del tempo, dovevano ormai cadere tutti i pregiudizi su Padre Pietro come “spia comunista”. Dallo stesso anno (1959) si è conservata poi una lettera scritta da parte di Padre Pietro a Piccola Sorella Germane, una delle prime presente nelle fondazioni in Polonia, in cui risulta che già in questo tempo Padre Pietro ha capito molto bene il carisma della Fraternità delle Piccole Sorelle – ne aveva una intuizione profonda e corretta che sicuramente è stata pure alla base della fraintesa tra lui e Magdaleine.
La svolta
Una svolta radicale nel rapporto tra Piccola Sorella Magdeleine e Padre Pietro avviene nell’autunno del 1961 – più esattamente nel loro incontro del 9 settembre. È uno degli eventi più interessanti e pittoreschi della storia qui ricostruita. Un gruppo delle Piccole Sorelle tornando da un viaggio in Polonia, si dirigeva, in macchina, dalla città di Toruń attraverso Poznań, verso la Germania dell’Est. Partite la mattina presto non sapevano se là sarebbe stato possibile ricevere l’eucaristia. Ad un certo momento videro una persona sulla strada che agitando le mani cercava di fermare la loro auto. Come scrive Piccola Sorella Magdeleine: “Non credevamo ai nostri occhi riconoscendo in quella persona il Padre Piero, benedettino, che ci sorprese a Tre Fontane arrivando alla presentazione ufficiale delle Piccole Sorelle trubadure… E poiché lui è molto spiritoso, ci raccontò qualche storiella, a cui di fatti non abbiamo dato credito, e con cui lui stesso cercava di spiegare la sua presenza sulla strada proprio nel momento del nostro passaggio. Rimanemmo però molto contente che lui viaggiasse con noi”[34].
Questo frammento richiede un breve commento. Soprattutto sorprende l’atmosfera di una certa misteriosità. Magdeleine incontra Padre Pietro per la terza volta nell’arco di quattro anni ed ecco in questo momento si rende conto che una delle caratteristiche di questo uomo è il fatto di “apparire”. Non si sa né da dove né perché ma Padre Pietro “appare”. Piccola Sorella nota una analogia tra la sua “apparizione” in Tre Fontane e quella avvenuta ora sulla strada da Toruń a Poznań. Lei ha pure l’impressione che queste “apparizioni” avvengono sempre in mezzo a “qualcosa” di importante che si svolge: a Tre Fontane c’era la presentazione delle sorelle trubadure, qui il viaggio e una mancata eucaristia. La percezione di questa donna è duplice. Da una parte, secondo lei, Padre Pietro appare quando succede qualcosa di provvidenziale e d’altra parte proprio la presenza di questo monaco impregna la situazione con lo stigma della provvidenza e della presenza divina. Da ora in poi sempre Padre Pietro sarà visto in questa prospettiva, cioè come uno che appare carico della presenza divina mettendo tutta la situazione sotto la luce di una misteriosa provvidenza di cui tutti insieme si sentono “complici”.
Ma il racconto descritto nel diario prosegue: “Lui ci chiede dove andiamo… E noi rispondiamo che andiamo alla casa delle suore del Sacro Cuore. E poiché anche lui non ha celebrato la Messa in questo giorno, si combina tutto così che tre ore dopo la nostra prima colazione (consumata in automobile - MB) possiamo ricevere la comunione. Ma durante la Messa celebrata da lui, veniamo colpite dalla sua omelia, detta in francese, in cui collega l’eucaristia e la spiritualità della nostra fraternità, parlando di questo Sacramento come della fonte dell’unità e del Signore ormai sempre vittorioso sopra tutte le divisioni che di fatti sono nient’altro che mere apparizioni… Ci fermiamo con lui presso le suore di Sacro Cuore e poi ripartiamo verso la frontiera…”
Nel convento delle suore di Sacro Cuore di Poznań succede ancora qualcosa di importante. Le Piccole Sorelle e Padre Pietro celebrano insieme l’eucaristia e lui tocca i cuori di queste donne per il modo con cui celebra, come un predicatore commovente che con una profonda conoscenza spirituale parla di Cristo, dell’unità e dell’eucaristia. Da questo momento Padre Pietro diventa una persona importante e significativa non solo per la Piccola Sorella Magdeleine, ma attraverso di lei anche per tutta la comunità delle Piccole Sorelle. Purtroppo non siamo in grado di dire chi sia stata e chi sia diventata col tempo Sorella Magdeleine per questo monaco. Sappiamo solo che si è rinforzata l’amicizia e d’ora in poi cercheranno di incontrarsi quando possibile. Il loro contatto fu anche mediato dal fatto che Padre Pietro in qualche modo estese il suo interesse e la sua cura spirituale sul gruppo di Piccole Sorelle che, in quei tempi, si radicò sempre di più in Polonia. Spesso era Padre Pietro che andava ad incontrare Piccola Sorella Magdeleine quando si trovava nelle sue vicinanze. Lei invece, da parte sua, scrupolosamente annotava questi incontri nei suoi diari. E così sappiamo che ambedue si incontrarono la sera del 31 agosto 1963 nel monastero delle benedettine in Varsavia e ancora nell’anno seguente (30 luglio 1964) a Laski vicino alla capitale della Polonia. Ma i diari di Magdeleine non dicono niente di più oltre il tempo e il luogo dell’ncontro.
Una nuova tappa
Purtroppo questa catena di incontri regolari tra Magdeleine e Pietro viene interrotta per sei anni. Piccola Sorella Magdeleine in questo periodo visita alcune volte le sue comunità in Polonia, ma non può incontrarsi con Padre Pietro la cui vita ha subito alcuni bruschi cambiamenti. Tra il 1964-1967 Padre Pietro viene rinchiuso in prigione e poi, spinto dalle autorità ecclesiali, si lega con i due eremi camaldolesi (Bielany vicino Cracovia e Bieniszew nella parte centrale ovest della Polonia) cambiando in seguito appartenenza all’ordine religioso (da benedettino diventa camaldolese). Quando nuovamente si incontrano nell’estate del 1970, Piccola Sorella Magdeleine è ormai una settantenne, ben riconosciuta fondatrice di un nuovo e prominente ordine religioso sparso in tutto il mondo. Padre Pietro invece appare nell’abito bianco con una lunga barba e segnato da un ingiusto processo e imprigionamento, e dal peso delle nuove esperienza causate dal cambio della famiglia religiosa. Nonostante il contrasto: Magdeleine spazia i continenti e Pietro costretto a limitarsi nella cella (prima quella della prigione e poi quella dell’eremo), ambedue hanno la grazia e la forza di incontrarsi e i sei anni della “separazione” non hanno indebolito per niente la loro amicizia. Paradossalmente poi, nonostante l’età e l’appartenenza di Padre Pietro ad un ordine eremitico, cresce la qualità e la frequenza dei loro incontri. D’ora in poi si vedranno quasi ogni anno – sempre “in via” – in diversi posti del mondo.
Nel 1970 Piccola Sorella Magdeleine si reca, in Unione Sovietica, passando attraverso la Polonia. Durante il viaggio sosta a Laski vicino a Varsavia, dove allora si trovava anche uno dei centri delle Piccole Sorelle frequentato da diverse persone e personalità della chiesa polacca dell’epoca (cardinale Stefan Wyszyński, filosofo Stefan Swieżawski, sacerdote Tadeo Fedorowicz, ecc.). Dai diari di Piccola Sorella Magdeleine sappiamo che Padre Pietro viene informato della sua presenza in Laski, ma non è sicuro di poterla raggiungere. Finalmente però arriva nel monastero delle suore francescane situato nel centro di Varsavia il 20 luglio 1970. Sappiamo che durante questo incontro Padre Pietro racconta le sue esperienza di prigione e la Piccola Sorella è colpita dal suo cambiamento esteriore (la barba, l’abito bianco, il volto segnato dalla prigionia). È possibile solo immaginare il clima di questo incontro su cui si stendeva l’ombra del comunismo che ostacolava la vita della chiesa – si ricorda che le Sorelle questa volta andavano dalla Polonia in Russia Sovietica, cioè proprio nella tana del “orso russo”.
Un anno dopo avviene un altro incontro – questa volta in un altro centro delle Piccole Sorelle in Polonia, cioè in Częstochowa. Padre Pietro viene a sapere da un telegramma che la Piccola Sorella si sarebbe trovata là e, dal suo eremo, la raggiunge. Così almeno per il momento possono incontrarsi e stare di nuovo insieme con persone come: Padre Tadeo, Padre Martino Polpiel, le Sorella Caterina e Stefania e la famiglia Swieżawski, cioè “tutti – come scrive Magdeleine nel suo diario –motivo per cui la Polonia è cara alle Piccole Sorelle”.
Ancora, nell’anno seguente Padre Pietro nel suo eremo riceve per telefono notizia del passaggio di Piccola Sorella Magdeleine per Częstochowa. Immediatamente prende il treno e la sera è già in questa città. In questa occasione avviene anche un piccolo “incidente”. Bisogna a questo punto sottolineare o ripetere che questa amicizia e questi incontri, come anche tutta la storia degli inizi della vita della Piccole Sorelle in Polonia in cui Padre Pietro era coinvolto, sono stati segnati sempre da qualche “avventura”. Padre Pietro dunque, scende dal treno e cerca di raggiungere la casa delle Piccole Sorelle. E’ ormai buio e camminando non si accorge che nella vicinanze della casa è scavata una buca fangosa, in cui cade. Appare così alla porta tutto sporco di fango: vi invito ad immaginare la scena. Padre Pietro che si deve lavare, pulire, cambiare – tutto con un po’ d’imbarazzo e un po’ d’umorismo. Ma ciò che importa è che Magdeleine e Pietro si possono incontrare e parlare. La nota che ricorda tutto questo nel diario di Piccola Sorella finisce con la frase: “Ero profondamente commossa dal fatto, che lui (Padre Pietro) fosse riuscito a raggiungerci così presto e che siamo riusciti a parlare insieme a lungo” (Diari 1972, vol. 39, p. 49).
Negli anni seguenti Piccola Sorella Magdeleine e Padre Pietro si incontrarono regolarmente e almeno una volta all’anno. Le testimonianza di questi incontri è sempre riportata nei diari di Magdeleine. Talvolta non succedeva niente di rilevante, altre volte invece, dalle annotazioni emerge qualcosa di significativo. E così per esempio in data 10 agosto 1973 si legge, tra l’altro, che ormai Magdeleine si era abituata al ritmo di questi incontri annuali con Padre Pietro e che questa volta lui sarebbe arrivato in ritardo perché viaggiava col treno – Magdeleine nota che normalmente Padre Pietro viaggiava in auto-stop e così arrivava sempre in tempo (Cf. Diario, 1973, vol. 41, p. 54). Immaginiamoci questo uomo ormai più che sessantenne vestito in bianco e con una lunga barba mentre ferma le automobili per le strade di Polonia e si sposta da un luogo all’altro per raggiungere questa Francese che semina nel mondo le cellule di una nuova comunità religiosa. Un anno dopo, 30 luglio 1974, Piccola Sorella Magdeleine si trova di nuovo a Częstochowa dove di nuovo arriva Padre Pietro e lei, dopo questo incontro scrive: “Parlo per il momento con Padre Pietro (Père Pierre) che arriva qui ogni volta quando noi passiamo e per me la sua visita è sempre una grande gioia. Lui irradia la pace del Signore nonostante la sua vita sia stata assai tormentata perché ha dovuto passare alcuni anni in prigione” (Diario, 1974, vol. 43, 27).
Gli incontri dell’anno seguente si fecero più frequenti e ancora più avventurosi. Dapprima i nostri due protagonisti si incontrarono a Częstochowa, dove Padre Pietro arrivò la mattina di 14 luglio 1975. Magdeleine racconta che passarono il tempo insieme parlando della situazione in Polonia in cui, in quel momento, secondo Padre Pietro il problema non stava più negli ostacoli amministrativi che il governo avrebbe potuto esercitare di fronte alla chiesa. Secondo lui ormai si era passati ad un programma assai sistematico per lo sradicamento della fede del popolo. A questo scopo doveva servire il progetto del servizio militare prolungato e il cambiamento del sistema educativo che voleva tenere gli allievi a scuola per tutto il giorno desiderando con ciò diminuire l’influsso e il contatto con la famiglia. Pietro vedeva tutta questa situazioni nelle categorie di una battaglia in cui la fede doveva essere difesa (Diario, 1975, vol. 45, p.7). Questa relazione rivela anche il clima in cui si svolgevano sia questi incontri, sia l’instaurarsi delle Piccole Sorelle in Polonia. Con questo si spiega anche un certo radicalismo e la tenacità del pensiero di Padre Pietro, come si può cogliere nei suoi scritti. Tali fatti però non toglievano la gioia di stare insieme, di pregare, di celebrare l’eucaristia, di condividere il pranzo e di lasciarsi con la promessa di rivedersi entro una settimana. E di fatti Padre Pietro arrivò (21 luglio) di nuovo alla casa delle piccole Sorelle a Częstochowa alla vigilia della festa del 22 luglio (Santa Magdeleine) – nonostante fosse un giorno di pioggia si poté far festa e ancora una volta parlare, pregare e mangiare insieme. Padre Pietro ritornò all’eremo di Bielany vicino Cracovia dopo il pranzo – ancora una volta con la prospettiva di vedersi con Magdeleine entro qualche giorno. E così fu, perché le Piccole Sorelle prima di lasciare la Polonia andarono a visitare Padre Pietro nel suo eremo. Ma quest’esperienza si rivelò piuttosto dolorosa. Soprattutto perché il tempo si era cambiato, e nonostante il periodo estivo, faceva già freddo e pioveva. Quando le Piccole Sorelle arrivarono con la loro automobile (il famoso camioncino chiamato “Stella filante” che era insieme una macchina, una cappella, una sala da letto, uno studio, ecc) alla porta dell’eremo camaldolese, scoprirono che li era impossibile entrare, perché in quei luoghi erano impedito l’accesso alle donne. Faceva allora freddo e loro, sedute con Padre Pietro sulla panchina vicino all’entrata – pur essendo contente dell’incontro – temevano di ammalarsi. Ovviamente si discusse sulla stranezza di una tale regola e Padre Pietro cercò di giustificare la situazione con la mancanza di denaro per la costruzione di un parlatorio. Ma si sapeva che non di mancanza di denaro qui si trattava, ma piuttosto di una mancata sensibilità umana. Piccola Sorella Magdeleina nel suo diario finisce tutto questo con la frase “ Lui – cioè Padre Pietro – è certamente troppo buono per non soffrire in tutta questa situazione” (Diario, 1975, vol. 45, p. 14). Questo fatto come anche il commento di Magdeleine spiegano assai bene lo stato in cui Padre Pietro viveva nel sistema dell’ordine camaldolese. Alla fine, con quel freddo e non potendo riscaldarsi in nessun edificio del monastero, tutti si spostarono nell’auto delle Piccole Sorelle per continuare il colloquio fino a sera. Poi Padre Pietro ripassò la porta del monastero e le Piccole Sorelle rimasero a dormire nella loro macchina parcheggiata nella foresta accanto all’eremo. Il giorno dopo (27 luglio 1975) era Domenica giorno in cui anche le donne potevano entrare nello spazio dell’eremo che schiudeva le sue porte per i fedeli della zona per il tempo della celebrazione. Dopo la Messa ripartirono e Padre Pietro decise di accompagnare le Piccole Sorelle per un po’ di strada. Magdeleine scrive che questo fare la strada con loro da parte di questo monaco era ormai una tradizione (ibid., p. 15) – ma si può anche immaginare che il povero Padre Pietro avesse voluto anche appagare con questo gesto la mancata ospitalità che le Sorelle avevano subito nel suo eremo a causa della rigidità e stranezza delle regole (Magdeleine non dimentica di annotare nel suo diario di sperare in una modifica di tale regola entro qualche anno). Il gruppo partì dall’eremo e si indirizzò verso Oświęcim (Auschwitz) dove nel museo presente nel campo di concentramento visitarono insieme la cella in cui era morto Massimilano Kolbe. Dopo di che le Piccole Sorelle ripresero la loro strada verso la Germania e Padre Pietro – questa volta in auto-stop – ritornò al suo eremo. Su tutta questa avventura bisognerebbe solo dire – rifugiandosi in una espressione inglese: No comment.
Un anno dopo (17 luglio 1976), di nuovo a Częstochowa, Padre Pietro arriva la mattina – Piccola Sorella Magdeleine e il monaco si scambiano alcune informazioni e si aggiornano reciprocamente. Padre Pietro cerca di spiegare la situazione dell’ordine camaldolese e della sua difficoltà ad “eclissarsi” quando avrebbe voluto, pur non negando ma desiderando per sé la vita eremitica (lui vive nelle vicinanze di Cracovia e ormai da trent’anni). Magdeleine riprende il discorso sullo shock subito l’anno precedente circa la totale mancanza di sensibilità per gli ospiti di sesso femminile. Padre Pietro la informa sull’avvio di lavori per la costruzione di un parlatorio accanto all’eremo che avrebbe potuto almeno parzialmente rimediare ad una tale mancanza. Il pomeriggio Padre Pietro può ancora celebrare l’eucaristia nella casa delle Piccole Sorelle e riparte subito per trovarsi nel suo eremo vicino a Cracovia la sera stessa. Un simile, breve, incontro ebbe luogo dopo circa sei mesi, il 13 febbraio 1977 – ma il diario di Piccola Sorella Magdeleine non apporta niente di più oltre l’annotazione che è avvenuto e la gioia che lo ha accompagnato.
“Succede sempre che ci ritroviamo su qualche strada”
Il 14 settembre 1977 Piccola Sorella Magdaleine e Padre Pietro si ritrovano a Tre Fontane. Sono passati ormai 20 anni dal loro primo incontro in quello stesso luogo. Nel 1977 lui aveva quasi settant’anni e lei quasi ottanta – ambedue arricchiti da diverse esperienze vissute e viste. Magdeleine annota nel suo diario che Pietro, arrivato a Tre Fontane, ha un’aria così stanca che in un primo momento lei non lo riconosce e lo crede un barbone (bella questa! – cf. Diario, 1977, p. 64). Quel giorno si celebrava la festa dell’ Esaltazione della Santa Croce e non si sa perché Padre Pietro si fosse trovato a Roma (probabilmente per motivi legati alla congregazione camaldolese). Per la festa lui celebra nella casa delle Piccole Sorelle la Messa, e pronuncia l’omelia di cui si è conservata la registrazione e la trascrizione (ibid. 74-75). Durante il pranzo a Padre Pietro vengono presentate tutte le Piccole Sorelle dell’Est presenti in quel momento nella casa.
Nell’estate dell’anno seguente Magdeleine e Pietro si incontrano in Polonia per ben tre volte. La prima volta Padre Pietro arriva il 20 giugno 1978 a Częstochowa. Si tratta di una visita molto breve – si vedono, si scambiano qualche parola e Pietro si esprime dicendo che “oggi” non basta credere, ma bisogna anche confessare e testimoniare la propria fede in mezzo alla gente (in questo di nuovo risuona il suo radicalismo cristiano dovuto sia al suo atteggiamento interiore sia alla situazione storica in qui viveva). Poi celebrano la Messa di cui si è pure conservata la breve meditazione di P. Piotr che dopo un pasto breve e leggero riparte. (Diario, 1978, vol. 53, pp. 127-128). Magdeleine annota tra l’altro che lui nel frattempo aveva cambiato luogo di soggiorno – non abitava più nell’eremo di Bielany vicino Cracovia, ma a Bieniszew nella parte Nord-Centrale del paese. Dieci giorni più tardi (30 giugno 1978) Padre Pietro di nuovo è presente a Częstochowa. Arrivando la mattina, celebra la Messa (di cui di nuovo abbiamo le parole della sua omelia) e riparte dopo il pranzo.
Per la terza volta nell’anno 1978 le Piccole Sorelle e Padre Piero si incontrano: è l’8 Luglio – e questo fu uno di quegli incontri strani e sorprendenti, inventati del tutto da Padre Pietro. Le Sorelle si recavano in Russia Sovietica e ad un tratto Padre Pietro “apparve” loro seduto vicino la strada. Ma qui è meglio dare la voce a Piccola Sorella Magdeleine che scrive: “Come fummo soltanto due chilometri dalla frontiera, rimanemmo molto sorprese nel vedere sulla strada una persona vestita in un talare nero e con una lunga barba che era quella di Padre Pietro. Fummo colpite profondamente pensando che lui fosse venuto proprio là per darci l’ultimo saluto conoscendo forse il giorno del nostro passaggio” (Diario, 1978, vol. 53, pp. 153-154). In tutto questo colpisce il forte legame emotivo che univa queste persone. Le sorelle andavano in Russia – che era sempre a quei tempi pericoloso. Ma Pietro desiderava fortemente vedere Magdeleine con cui si era incontrato nell’arco di tre settimane ormai due volte. Ora lui si era recato dall’Ovest del paese dove si trovava il suo eremo alla parte dell’estremo Est… soltanto per salutarla e per vederla per un momento. Si possono immaginare le fatiche e le difficoltà delle strade che questo monaco (non più tanto giovane) doveva affrontare per giungere a quell’incontro. Tutto questo è sorprendente e bello e non dicendo niente dice molto sul legame che è esistito tra queste persone.
Ma ecco come Magdeleine continua il racconto: “La gioia di rivederci è mescolata con una certa inquietudine. Perché le vicinanze della frontiera russa (siamo sempre nei tempi del comunismo assai arduo – MB) sono talmente sorvegliate che fermarsi qui e per di più parlare con qualcuno è una cosa molto imprudente… Ma che importa… Offriamo allora a Padre Pietro una tazza di café, un biscotto e una crocetta fatta di eucalipto da una delle sorelle di Tre Fontane. Pensiamo che sia prudente che nessuno ci veda insieme. Lui invece ci dà la benedizione e ci lascia”. Ecco il clima dell’incontro: clandestinità, paura, apparizione, fretta – ma in tutto questo non manca un po’ d’umanità (café e biscotto) e un po’ di fede (croce e benedizione).
Poi Magdeleine continua: “Noi invece dobbiamo ancora aspettare a lungo, perché alla frontiera c’è una lunga fila di macchine. Arriva un poliziotto, e dopo averci chiesto i passaporti, ci fa domande su questo “pop” (così sono chiamati i preti ortodossi - MB) con la talare nera e con la barba bianca che ci ha raggiunto sulla strada (il poliziotto aveva pensato che questo poteva essere una spia o qualche contatto illegale – MB). Noi semplicemente rispondiamo che non era un “pop” ma un Padre Camaldolese che si chiama Pietro, ma di cui abbiamo dimenticato il cognome (piccola bugia – MB) perché è un polacco e i nomi polacchi sono difficili da ricordare per i Francesi… Noi lo abbiamo conosciuto nel suo monastero a Bielany che è un posto molto turistico” (ibidem). Poi le sorelle partirono per la Russia. In quel momento Padre Pietro era probabilmente già lontano – immerso nei suoi pensieri e nel suo viaggio di ritorno (sicuramente in auto-stop).
Nel 1979 Padre Pietro si trova a Częstochowa proprio nel tempo in cui in questa città e nel santuario ha luogo la visita di Papa Giovanni Paolo II. Nello stesso tempo è qui presente anche la Piccola Sorella Magdeleine che nel suo diario scrive: “Il 6 giugno Padre Pietro Rostworowski, il nostro grande amico, priore dei camaldolesi, è qui con i suoi quattro novizi per assistere alla Messa celebrata dal Papa Giovanni Paolo II a Jasna Góra per i seminaristi e i novizi di ordini religiosi” (Diari-Lettere stampati, vol. 16, p. 51). Poi loro due si rivedono ancora il primo luglio quando Padre Pietro ancora una volta ripassa a Częstochowa. Pietro celebra per le Sorelle l’eucaristia la sera del suo arrivo e il giorno dopo, e riparte poi per il suo eremo. Nelle note di Piccola Sorella Magdeleine risuona un certo tono melanconico causato da queste via-vai di diversi amici (Pietro incluso).
L’anno seguente (5 luglio 1980) visitando Polonia le Piccole Sorelle arrivano con la loro auto all’eremo di Bieniszew e ancora una volta si sorprendono quando sulla strada appare Padre Pietro che sta passando di li con la sua macchina, si ferma e le saluta. È un breve incontro e le Sorelle ripartono a sud del paese, dandosi però un appuntamento con lui in una delle strade vicino a Cracovia. Magdeleine commenta questo fatto scrivendo: “Succede sempre che ci ritroviamo su qualche strada” (Diario p. 147). Trovandosi a Cracovia con le Piccole Sorelle, Padre Pietro fa loro da guida – visitano insieme il centro storico della città e poi vanno a Tyniec – il monastero benedettino in cui prima di diventare camaldolese Padre Pietro aveva vissuto per anni.
Nel 1981 Magdeleine e Pietro si incontrano a Tre Fontane (25 marzo) e poi in Polonia a Częstochowa (22 luglio) – dalle note di Magdeleine risulta che il tema principale discusso all’occasione di questi incontri è soprattutto la situazione politica in Polonia e la posizione della chiesa in mezzo a tutti i cambiamenti che incominciano ad avvenire nel blocco dell’est europeo (si pensi all’elezione di un Polacco alla Sede di Pietro, alla rivoluzione di Solidarnosc, ecc.). Un ritmo simile segna l’anno seguente. Prima il 3 giugno 1982 Padre Pietro, come scrive Magdeleine “all’improvviso come sempre” (Diari stampati, vol. 20, 483), arriva a Tre Fontane fermandosi solo per qualche ora (tempo di mangiare e parlare insieme). Nel mese successivo si rivedono già a Częstochowa (22 luglio 1982) dove nel monastero di Jasna Góra Padre Pietro alla presenza di altri amici delle Piccole Sorelle (Padre R. Voillaume, Padre Marcin, Padre Tadeo, Signora e Signore Świeżawski) presiede la Messa. Poi si rivedono ancora una volta nel posto chiamato Zielonka, un nuovo centro questa volta per i Piccoli Fratelli in Polonia, il 20 agosto 1982.
L’ultimo giorno del giugno 1983 Magdeleine e Pietro si incontrano di nuovo a Zielonka dove tra l’altro stabiliscono che nei giorni successivi le Piccole Sorelle con la loro macchina (la famosa “Stella filante”) avrebbero trascorso qualche giorno nella solitudine della foresta vicino all’eremo di Bieniszew dove in quel tempo abitava Padre Pietro. E di fatti le quattro Sorelle (insieme con Magdeleine ci sono : Marie-Luise, Léon, Jeanne) arrivano a Bieniszew la sera del 4 luglio – Pietro indica loro un angolo nella foresta dove, secondo lui, sarebbero state al sicuro, celebra una Messa vespertina e le lascia nella loro auto-furgone nella solitudine e nel silenzio della foresta. La mattina del giorno dopo Padre Pietro arriva e celebra la Messa nella macchina (non è una domenica e le donne non possono invadere la clausura dell’eremo). Le Sorelle passano la giornata nel silenzio della foresta – la sera dedicano ancora un’ora all’adorazione del Santissimo sacramento esposto di nuovo… nella macchina. È bello immaginarlo: la foresta, la macchina che ha passato tante frontiere, un gruppo delle Sorelle, Santissimo Sacramento, un monaco-amico che viene ogni tanto dal suo eremo accanto, il silenzio, il mistero. Piccola Sorella Magdeleine non esita a confessare che “da almeno quarant’anni non avva mai avuto la possibilità di godersi una tale solitudine e una tale pace” (Diario, 1983, vol. 68, p. 56). Due Sorelle dormono nella macchina e due altre nella tenda sul tetto della macchina (si ricorda che Magdeleine allora aveva circa 85 anni! – e soffriva il calore dell’estate, la presenza delle zanzare e delle ortiche che in quella foresta si trovavano ovunque). Padre Pietro arriva solo alle cinque di sera per celebrare la Messa. Il giorno dopo le quattro Sorelle e Padre Pietro si rivedono la mattina: lui di nuovo celebra la Messa e poi tutti insieme partono – il monaco accompagna le Sorelle per un po’ mostrando loro la strada; poi lui fa ritorno al suo eremo e loro proseguono verso la frontiera della Germania. Magdeleine e Pietro si rivedono a Tre Fontane il 20 ottobre 1983 quando lui partecipa a Roma al Sinodo dei Vescovi dedicato al sacramento della riconciliazione. Nell’occasione Magdeleine nota – un tratto particolare – che a mezzogiorno, al suono delle campane, Padre Pietro spontaneamente inizia a recitare l’“Angelus” e le altre lo seguono (Magdeleine osserva che questa prassi, peccato, si era ormai persa tra le Piccole Sorelle…).
Poi la vita di Padre Pietro si cambiò – dovette spostarsi per vivere a Nola vicino Napoli ed essendo un secondo visitatore dell’ordine, dovette viaggiare tra Italia, Polonia e Stati Uniti passando ogni tanto un momento a Tre Fontane dove sempre più frequentemente risiedeva ormai avanzata nell’età e fisicamente indebolita Piccola Sorella Magdeleine. Così fu per esempio il 27 settembre 1984. L’anno seguente invece Magdeleine e Pietro si incontrarono prima a Częstochowa (30 giugno 1985) e poi a Regelsbrunn (5 luglio 1985) in Austria. Le Sorelle tornavano a Tre Fontane e Padre Pietro con un'altra macchina, passando per Roma andava al suo eremo di Nola vicino Napoli. Ambedue pur prendendo strade diverse riuscirono a mettersi in contatto e incontrarsi per una giornata nella cittadina austriaca. Tutto si svolse come di solito: incontro sulla strada, la Messa, il pranzo, il dialogo e la partenza.
L’anno seguente il loro incontro fu segnato da un altro colorito. Padre Pietro il 20 ottobre 1986 apparve senza annuncio a Tre Fontane così che Magdeleine lo trovò semplicemente nella sua stanza tornandovi dopo qualche altro incontro da fuori. Pietro rientrava dalla Polonia dove era stato, salutando tutti (Magdeleine scrive “per dire a Dio”) perché aveva ricevuto l’ordine di recarsi in Columbia per prendere cura delle nuove vocazioni eremitiche. La Piccola Sorella nota nel suo diario che Padre Pietro è per lei un esempio dell’obbedienza, del coraggio e del buon umore: scherza dicendo che si sente come Abramo che a 75 anni, obbedendo alla voce di Dio, dovette partire per terre sconosciute – e ora Padre Pietro avendo ormai 76 anni, con una salute danneggiata da reumatismi e senza conoscere lo spagnolo deve recarsi oltre l’Oceano Atlantico (tutto questo è raccontato nel Diario di Magdeleine). Le note di Magdeleine non dicono molto, ma sicuramente ambedue si rendono conto che quello forse poteva essere l’ultimo incontro: la Columbia era lontana, ambedue erano avanti negli anni e il futuro poco prevedibile. Rimaneva però il contatto epistolare – e così Padre Pietro mandò a Mgdeleine già il 24 ottobre – cioè subito dopo il suo arrivo – la lettera in cui descrive le sue prime impressioni delle vita in Columbia. Ad essa ne seguono altre: il 27 gennaio 1987 e il 16 maggio 1989.
L’ultimo incontro ebbe luogo a Tre Fontane nel 1989 – poco prima della morte di Magdeleine. L’8 settembre si celebrava il 50-esimo anniversario della Fraternità e il 13 settembre, andando al capitolo generale dei Camaldolesi a Frascati, Padre Pietro tornava dalla Columbia. Ma Mgdeleine era ormai molto debole ed esaurita –si videro “soltanto” e poi Padre Pietro ripartì. Così si chiude la storia di questi incontri. Tutto è incominciato a Tre Fontane nel lontano 1957 – ora lui la “vede” e parte.
Quando Padre Pietro seppe della morte della Piccola Sorella Magdeleine (6 novembre 1989) ha inviato il 26 dicembre 1989 dal suo eremo columbiano a Envigado alla casa di Tre Fontane una lettere in cui in qualche modo ha dato la testimonianza di questo che cosa era per lui la Piccola Sorella Magdaleine e la sua amicizia. Ne leggiamo:
“Sono rimasto profondamente impressionato e commosso dalla vostra lettera che mi ha annunciato la scomparsa della Piccola Sorella Magdaleine di Gesù, richiamata da questo mondo da parte del nostro Padre Celeste. E vero che già durante la mia ultima visita a Tre Fontane agli inizi dell’ottobre si notava la sua grande debolezza che faceva pensare di una sua fine vicina. Non di meno questa scomparsa è un evento spirituale non solo per la vostra Famiglia religiosa di cui lei era la Fondatrice e Madre, ma anche per me che da sempre mi sono sentito indegno della sua amicizia, però tutto in me mi dice che questa amicizia era autentica e sincera.
È una santa che ci ha lasciato visibilmente per rimanere con noi invisibilmente. Le sue ispirazioni, profondamente evangeliche, hanno arricchito la Chiesa di Dio; e il sue benefico influsso si può ritrovare persino nei documenti e nello spirito del Vaticano II e nella vita postconciliare della Chiesa.
La sua anima da una parte molto forte e inflessibile, fondata sulla fede e fiducia in Dio, possedeva d’altra parte una tenerezza straordinaria; questa era la tenerezza divina che sta nel fondo di tutte le cose create ed è il tono il più profondo e il più divina delle Scritture e di tutto questo che realmente esiste.
Essa (Piccola Sorella Magdaleine - MB) aveva una intuizione del tutto eccezionale del Vangelo e di questo che è evangelico; ma questa fedeltà al Vangelo, assai austera, non ha diminuito per niente la sua straordinaria bontà e dolcezza.
Per la sua comunità ora incomincia una nuova tappa. Gli apostoli non hanno capito immediatamente che la scomparsa di Cristo era allo stesso momento una grazia per loro. Questa grazia della scomparsa senza dubbio si mescola con il dolore. Ma dobbiamo scoprirla.
Preghiamo il Signore infinitamente Santo che nella sua immensa misericordia conceda all’anima della sua Serva la gioia della vita eterna.
Rimango profondamente unito alla cara congregazione delle Piccole Sorelle di Gesù in questo giorno e per sempre”.
Sarebbe difficile scrivere una conclusione di tutta questa storia. E forse non basta affermare che è una storia bella e affascinante. Si potrebbero scrivere tantissime altre storie parallele: cioè tantissime altre amicizie che hanno segnato la vita di Magdeleine e quella di Pietro. Ognuno di loro ne aveva tante – ma anche tra loro erano legati da una relazione molto particolare, profonda e fondata sul Vangelo e sulla simile passione per Dio. Aggiungere un tale saggio alla fine di questo libro ha uno scopo molteplice: 1. far conoscere questa storia; 2. mostrare la ricchezza della vita di Pietro Rostworowski di cui l’amicizia con Piccola Sorella Magdeleine è “solo” una (nel cosmo delle sue relazioni in Cristo ve ne erano tante, tantissime altre “grandi e piccole”); 3. ammonire i futuri storici che la vita di questo monaco era ricca, complessa, piena di sorprese e lontana da schemi – vedere, comprendere e descrivere tutto questo rendendone giustizia è un’impresa tanto bella quanto difficile.
Maciej Bielawski (2003)
[1] Eremo di Frascati 22.10.1995. Questa meditazione è stata scritta in polacco – la traduzione in italiano è di M. Bielawski.
[2] Eremo di Frascati: 11.05.1995.
[3] Eremo di Nola: 31.03.1984.
[4] Eremo di Nola: 7.04.1984.
[5] Eremo di Nola: 19.05.1984.
[6] Eremo di Nola: 26.05.1984.
[7] Eremo di Nola: 4.08.1984.
[8] Manca la data di questa conferenza.
[9] Eremo di Nola: 11.08.1984.
[10] Eremo di Nola: 25.08.1984.
[11] Eremo di Nola: 15.09.1984.
[12] Eremo di Nola: 17.08.1985 (vedi anche l’omelia per la festa di San Lorenzo, pp...)
[13] Eremo di Nola: 8.09.1984.
[14] Eremo di Nola: 22.12.1984.
[15] Eremo di Nola: 22.12.1984.
[16] Eremo di Nola: 30.03.1985.
[17] Eremo di Nola: 28.04.1984.
[18] Eremo di Nola: 5.05.1984.
[19] Eremo di Nola: 18.05.1985.
[20] Eremo di Nola: 2.06.1984.
[21] Eremo di Nola: 13.07.1985.
[22] Eremo di Nola: 10.08.1985.
[23] Eremo di Nola: 27.07.1985.
[24] Eremo di Nola: 3.08.1985.
[25] Eremo di Frascati: 27.02.1995.
[26] Eremo di Nola: 20.07.1985.
[27] Eremo di Frascati: 27.02.1995.
[28] Eremo di Nola: 17.03. 1984.
[29] Eremo di Nola: 14.07.1984.
[30] Eremo di Pasce Lupo: 24.04.1993.
[31] Siamo al v. 12 del cap. 1. L’Apostolo informa i fratelli di Filippi sulla sua situazione. Umanamente parlando, essa non è felice. Egli si trova in prigionia e non può predicare il Vangelo. Ma tutte le difficoltà per lui non sono niente. Il suo amore di Cristo e la sua speranza gli danno un ottimismo invincibile. (Nota scritta dal Padre Pietro)
[32] Eremo di Pasce Lupo: 12.06.93
[33] Tutte le informazioni provengono sia dai diari sia dalle lettere di Piccola Sorella Magdeleine conservate nell’archivio a Tre Fontane (Roma) e sono indicate nel testo. Nello stesso archivio si trovano tante fotografie che pure narrano questa storia. Esistono poi ancora vivi i ricordi che “girano” nella comunità delle Piccole Sorelle e che fanno parte della loro tradizione viva – ogni tanto questi racconti mi hanno aiutato di comprendere e di interpretare alcuni eventi. Bisogna menzionare il fatto che dopo la morte di Piccola Sorella Magdeleine, e a poca distanza della sua, Padre Pietro ha scritto un testo, una testimonianza su Magdeleine, ma questa per il momento, a ragioni diverse, non può essere resa pubblica.
[34] Diaire de Petite Soeur Magdeleine de Jésus, 9.09.1961, vol. 17, pp. 60-61 (traduzione italiana MB).